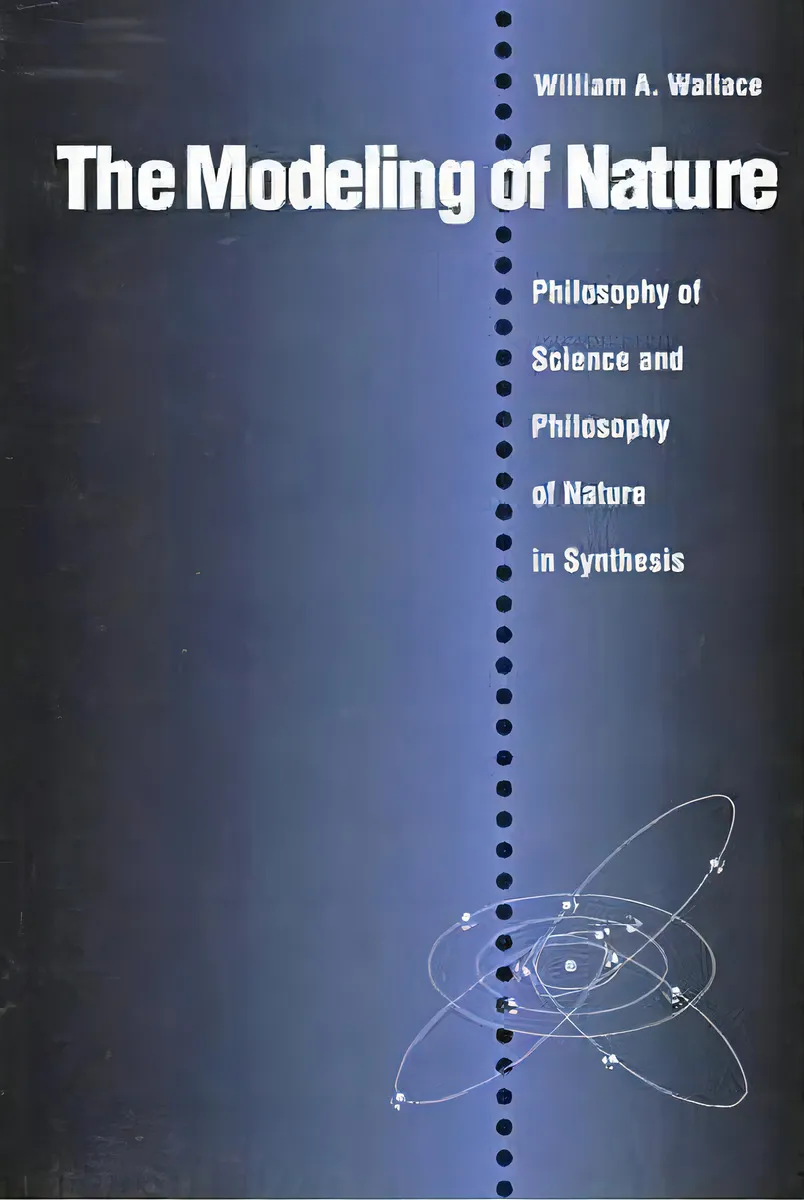Titolo: The Modeling of Nature: Philosophy of Science and Philosophy of Nature in Synthesis Autore: William A. Wallace Editore: The Catholic University of America Press Anno: 1996
Introduzione: un progetto audace di sintesi
In un panorama intellettuale in cui la filosofia della scienza del XX secolo sembrava aver scavato un solco incolmabile tra sé e le sue radici classiche e medievali, l’opera del 1996 di William A. Wallace, The Modeling of Nature, si erge come un monumento di rara ambizione e profonda erudizione. Non si tratta semplicemente di un’analisi storica o di una critica delle correnti dominanti, ma di un poderoso tentativo di ricostruzione. L’obiettivo dichiarato da Wallace, esplicitato fin dal sottotitolo, è niente meno che la reintegrazione di due discipline che la modernità ha progressivamente allontanato: la filosofia della scienza e la filosofia della natura. Nella sua prefazione, Wallace attribuisce l’intuizione di base ad Aristotele, il “Padre della Scienza Occidentale”, secondo cui la mente umana è capace di trascendere i limiti dei sensi e di cogliere le “nature” delle cose. Per riuscirci, la mente ragiona da ciò che è più noto a ciò che è meno noto, spesso impiegando, come afferma Wallace, “tecniche di modellizzazione per penetrare i segreti della natura”, un’idea che egli collega direttamente al ragionamento aristotelico per analogia.
Il progetto di Wallace nasce dalla diagnosi di una profonda crisi epistemologica nella filosofia contemporanea. Egli sostiene che lo scetticismo di David Hume, che nega la possibilità di cogliere connessioni causali, e l’agnosticismo di Immanuel Kant, che preclude la conoscenza delle “cose in sé”, hanno lasciato la filosofia della scienza incapace di giustificare le pretese di verità della scienza stessa. Il risultato, secondo Wallace, è il dominio del relativismo e del pragmatismo, dove la scienza è ridotta a “credenza giustificata”, a mito o a retorica, indistinguibile dalla mera opinione (doxa) e incapace di raggiungere la verità e la certezza (epistēmē).
Contro questa visione, Wallace propone un ritorno a un “aristotelismo progressivo”. Non si tratta di un’adesione servile al pensiero del IV secolo a.C., ma dell’uso dei principi analitici di Aristotele per comprendere e sintetizzare le scoperte della scienza moderna, in uno spirito simile a quello di Alberto Magno e Tommaso d’Aquino. L’ambizione è monumentale: fondare una filosofia della scienza non sulla sola logica formale o sull’analisi linguistica, come tentato dall’empirismo logico, ma su una robusta e rinnovata filosofia della natura. Per fare ciò, Wallace introduce il concetto chiave di “modellizzazione” (modeling) come strumento per rendere accessibili e applicabili al mondo contemporaneo concetti aristotelici come materia, forma, causa e potenza. Questa recensione analizzerà la struttura bipartita del volume, esplorando prima la fondazione gettata nella filosofia della natura e poi l’edificio epistemologico che su di essa viene eretto nella filosofia della scienza, per valutare l’importanza e la portata di questa straordinaria sintesi.
Le fondamenta – una filosofia della natura per il mondo moderno
La prima metà dell’opera di Wallace, che occupa i capitoli da 1 a 5 , è dedicata interamente alla costruzione di una filosofia della natura rinnovata. L’autore comprende che, per poter parlare di una “scienza della natura”, è indispensabile anzitutto chiarire cosa si intenda per “natura”. Rifiutando le caricature post-cartesiane, l’autore recupera il concetto aristotelico di natura (physis) come “una dimensione interiore”, un principio intrinseco di moto e di quiete che rende un ente ciò che è e ne spiega le attività caratteristiche.
Capitolo 1: il modello causale e la dimensione interiore
Il primo capitolo funge da chiave di volta per l’intera opera. Qui Wallace introduce il suo strumento analitico fondamentale: il “modello causale”, basato sulle quattro cause di Aristotele . Con un’abile mossa pedagogica, parte dall’analisi di un artefatto, una sedia, per illustrare la funzione distinta della causa materiale (il legno), formale (la forma della sedia), efficiente (il falegname) e finale (lo scopo di sedersi). La vera svolta filosofica, tuttavia, avviene nel trasporre questo modello al mondo naturale.
Wallace sostiene che, mentre nell’artefatto le cause efficienti e finali sono estrinseche, negli enti naturali vengono “internalizzate” . La “forma naturale” (NF) di un essere vivente, come uno scoiattolo, non solo struttura la sua materia, ma contiene in sé il potere (dynamis) di agire (causa agente) e di replicare la sua stessa forma in un nuovo individuo (causa finale) . Questa internalizzazione delle cause è ciò che costituisce l’essenza della natura come principio immanente.
Wallace ridefinisce alcuni concetti concetti chiave per il lettore moderno. La materia prima (protomatter, PM), che Aristotele definiva “conoscibile per analogia”, non è un substrato inerte, ma un principio potenziale e dinamico, una “potenza potente” che persiste attraverso ogni muteamento. Wallace la accosta audacemente al concetto scientifico di massa-energia , citando persino Werner Heisenberg a sostegno di questa interpretazione. La forma naturale (NF) è il principio di attualità, intelligibilità e stabilità; è ciò che organizza la materia e la rende una sostanza specifica. È la forma che la mente umana coglie, inizialmente in modo confuso e poi sempre più distintamente, quando comprende la “natura” di qualcosa .
Capitoli 2-5: la gerarchia delle nature e il “Powers Model”
Seguendo l’ordine del corpus aristotelicum, Wallace applica questo quadro concettuale alla gerarchia degli enti naturali, costruendo modelli sempre più complessi. Il suo strumento visivo e concettuale, il “Powers Model”, mostra come i livelli superiori della natura integrino e sussumano i poteri dei livelli inferiori.
- Il mondo inorganico (Cap. 2): Lungi dal considerare la fisica e la chimica moderne come in rottura con l’aristotelismo, Wallace le interpreta come una sua profonda delucidazione. Egli mostra come il modello di Bohr dell’atomo non sia altro che un tentativo di rappresentare la forma di un elemento chimico. La disposizione specifica di protoni, neutroni ed elettroni non è un mero assemblaggio, ma una struttura unificante e dinamica (NF) che spiega le proprietà chimiche e fisiche dell’elemento. Le quattro forze fondamentali della fisica (forte, elettromagnetica, debole, gravitazionale) sono interpretate come i “poteri” o le capacità operative intrinseche alla natura inorganica spiegando come la forma di un composto, come il sale (NaCl), sostituisca le forme dei reagenti (Na e Cl), mentre la protomateria (PM) funge da principio di conservazione sottostante .
- Le nature vegetali e animali (Cap. 3): Salendo nella scala della natura, il “Powers Model” si arricchisce. La natura vegetale sussume e organizza i poteri inorganici per i propri fini vitali. Ai quattro poteri fisici si aggiungono i poteri vegetativi: controllo omeostatico e metabolico, sviluppo e riproduzione. La natura animale, a sua volta, integra i poteri vegetativi e vi aggiunge quelli del senso (sensi esterni e interni) e della mobilità, mediate da un sistema nervoso. Wallace utilizza qui modelli cibernetici (come la machina speculatrix ) per illustrare per analogia le funzioni sensoriali e motorie, ma sottolinea la differenza fondamentale tra l’automa e l’organismo vivente: quest’ultimo è auto-sviluppante e auto-attivante, la sua forma è il principio immanente della sua attività . L’analisi della molecola di DNA, con la sua struttura a doppia elica, è presentata come un modello iconico perfetto della forma che presiede alla riproduzione.
- La mente e la natura umana (Cap. 4-5): Questi capitoli rappresentano il culmine della Parte I. Wallace affronta la cognizione, distinguendo nettamente la conoscenza sensibile (sensazione e percezione), che produce un “percepito” concreto e individuale, dalla conoscenza intellettuale, che astrae l’intelligibile contenuto nel percepito per formare un “concetto” universale . Qui l’autore introduce il termine anima (psyché) come sinonimo tecnico per la forma naturale di un essere vivente . La natura umana è caratterizzata da poteri che trascendono la materialità: l’intelletto e la volontà. L’intelletto astrae l’universale dal particolare, mentre la volontà (o appetito razionale) tende al bene così come viene appreso dall’intelletto . L’analisi dell’atto umano, scomposto nelle sue fasi intellettuali e volitive, è presentata in dettaglio. Wallace conclude la prima parte mostrando come la natura umana sia non solo la più complessa, ma anche la più perfetta, in quanto capace di perfezionamento operativo attraverso le virtù intellettuali (scienze e arti) e morali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza), che costituiscono una “seconda natura” per l’uomo .
In sintesi, la prima parte del libro è un’imponente ricostruzione della filosofia della natura che non si limita a riesumare concetti antichi, ma li rinvigorisce mettendoli in dialogo con la scienza contemporanea.
L’edificio – una filosofia della scienza realista ed epistemica
Se la prima parte ha gettato le fondamenta, la seconda (capitoli 6-10) erige l’edificio. L’obiettivo di Wallace è ora quello di usare la sua rinnovata filosofia della natura per fondare una filosofia della scienza che possa rivendicare per l’indagine scientifica lo status di epistēmē — conoscenza vera, certa e causale.
Capitoli 6-7: Critica della visione dominante
Wallace inizia con una disamina storica e critica della filosofia della scienza del XX secolo. Egli identifica la “rottura con Aristotele”, operata principalmente da Cartesio e Kant, come l’origine della deriva soggettivista e agnostica della filosofia moderna. Analizza poi le principali correnti: l’empiriocriticismo di Mach, il convenzionalismo di Poincaré e Duhem, e soprattutto l’empirismo logico del Circolo di Vienna.
Il cuore della sua critica è che queste scuole di pensiero, concentrandosi sulla logica formale e su un’epistemologia humiana, hanno svuotato la scienza del suo contenuto ontologico. Il modello ipotetico-deduttivo (HD), descritto da Hempel e altri, può al massimo portare a una “conferma” probabile, ma mai alla certezza, poiché si basa sulla fallacia formale dell’affermazione del conseguente. Wallace compie qui un’osservazione brillante: il ragionamento scientifico, così come viene descritto dagli empiristi logici, non corrisponde alla dimostrazione scientifica degli Analitici Posteriori di Aristotele, ma piuttosto al ragionamento dialettico dei Topici . La scienza, nella visione dominante, è ridotta a doxa (opinione). Anche le reazioni storiciste, come quella di Thomas Kuhn con la sua teoria delle rivoluzioni scientifiche e dei paradigmi, pur evidenziando i limiti del modello logico, sfociano in un relativismo che rende la verità un costrutto sociale.
Capitoli 8-10: La dimensione epistemica della scienza
È in questi capitoli finali che Wallace presenta la sua proposta costruttiva. Per superare l’impasse probabilista, egli sostiene la necessità di recuperare la logica materiale di Aristotele, in particolare la teoria della dimostrazione (apodeixis).
Lo strumento metodologico chiave che Wallace ripropone è il regressus demonstrativus (regresso dimostrativo), una metodologia affinata dagli aristotelici padovani come Jacopo Zabarella e conosciuta e utilizzata, secondo Wallace, dallo stesso Galileo . Il regressus è un processo a due stadi che permette di passare dalla conoscenza del “fatto” (quia) alla conoscenza della “ragione del fatto” (propter quid) :
- Prima fase (Risolutiva): Si procede a posteriori, dall’effetto conosciuto alla sua causa ancora sconosciuta (demonstratio quia).
- Fase intermedia (Examen Mentale): La mente compie un “lavoro intellettuale” per assicurarsi che la causa scoperta sia la vera e unica causa convertibile con l’effetto.
- Seconda fase (Compositiva): Una volta che la causa è stata compresa “formalmente”, si procede a priori, deducendo l’effetto dalla causa (demonstratio propter quid), che fornisce conoscenza scientifica certa e causale.
La genialità della proposta di Wallace sta nel mostrare, attraverso una serie di studi di caso storici (Capitolo 9), come questo modello descriva la struttura profonda di alcune delle più grandi scoperte scientifiche. Egli analizza in dettaglio, tra gli altri:
- La spiegazione dell’arcobaleno di Teodorico di Freiberg, che distingueva tra i principi dei colori e la dimostrazione geometrica delle loro traiettorie .
- Le scoperte di Galileo sulle montagne della luna, i satelliti di Giove, e la sua fondamentale dimostrazione della legge di caduta dei gravi basata su esperimenti con piani inclinati .
- La dimostrazione di William Harvey sulla circolazione del sangue, basata su argomenti quantitativi e sull’analisi della funzione delle valvole cardiache .
- L’analisi di Isaac Newton sulla composizione della luce bianca attraverso il prisma (experimentum crucis) e sulla gravitazione universale .
- La scoperta di atomi e molecole attraverso le leggi della chimica quantitativa, culminata nel lavoro chiarificatore di Stanislao Cannizzaro .
- La scoperta della struttura a doppia elica del DNA da parte di Watson e Crick .
In ciascun caso, Wallace mostra come gli scienziati siano partiti da un effetto osservato, abbiano ragionato a ritroso per identificare la sua causa propria, e infine abbiano usato questa causa per spiegare deduttivamente il fenomeno di partenza. Il capitolo 10 affronta le controversie che circondarono queste scoperte, mostrando che la resistenza iniziale non era dovuta a un difetto intrinseco nelle dimostrazioni, ma alla mancanza, da parte dei critici, della “preconoscenza” e dell’accettazione delle “supposizioni” necessarie per comprendere la forza apodittica dell’argomento.
Valutazione complessiva e importanza dell’opera
The Modeling of Nature è un’opera di un’importanza capitale. La sua rilevanza può essere riassunta in diversi punti chiave:
- Una fondazione realista per la scienza: In un’epoca segnata dal relativismo, Wallace offre una difesa del realismo scientifico che non è né ingenua né dogmatica. Il suo realismo è critico, fondato su una metodologia rigorosa che permette di distinguere tra conoscenza certa e opinione probabile.
- La reintegrazione di natura e scienza: L’opera sana la frattura moderna tra l’oggetto della scienza (la natura) e la conoscenza stessa (la scienza). Per Wallace, la filosofia della scienza è una parte specializzata della filosofia della natura .
- Un ponte tra antico e moderno: Il concetto di “modellizzazione” è il geniale ponte che Wallace costruisce per rendere l’apparato concettuale aristotelico rilevante per l’analisi della scienza contemporanea. I modelli scientifici diventano le nostre migliori rappresentazioni analogiche delle nature e dei poteri che operano nel mondo reale .
- Recupero della dimensione epistemica: Forse il contributo più significativo è la riaffermazione che la scienza può aspirare alla certezza. Riscoprendo e applicando il regressus demonstrativus, Wallace fornisce un modello di razionalità scientifica che va oltre il semplice schema ipotetico-deduttivo, mostrando come la scoperta e la giustificazione siano due momenti di un unico processo razionale .
- Una nuova lettura della storia della scienza: L’analisi storica di Wallace non è mera aneddotica. I suoi studi di caso sono intesi a rivelare la struttura logica profonda del progresso scientifico, offrendo una potente alternativa sia alla visione cumulativa lineare dei positivisti sia alla visione rivoluzionaria e irrazionale di Kuhn.
Naturalmente, l’opera non è priva di sfide per il lettore. Richiede una certa familiarità con il pensiero aristotelico e scolastico. Alcuni potrebbero obiettare che la sua applicazione del regressus a casi storici sia una ricostruzione a posteriori che forza le scoperte in uno schema predefinito. Tuttavia, la coerenza e la potenza esplicativa del suo approccio sono innegabili.
Conclusione
William A. Wallace, in The Modeling of Nature, ha realizzato un’opera magistrale. È un invito a ripensare dalle fondamenta il nostro modo di concepire la scienza e il suo rapporto con la realtà. Rifiutando di scegliere tra un realismo ingenuo e uno scetticismo disincantato, Wallace traccia una “terza via” aristotelica che restituisce alla scienza la sua dignità epistemica e alla natura il suo status di realtà intelligibile. È un libro che sfida, provoca e illumina, e che merita di essere studiato attentamente da chiunque sia interessato ai fondamenti della conoscenza scientifica. Non è semplicemente un libro sulla filosofia della scienza; è un tentativo di fare filosofia con la scienza, in una sintesi che recupera il meglio di una tradizione millenaria per affrontare le sfide intellettuali del nostro tempo.