Nel panorama degli studi sulle origini cristiane, pochi libri hanno la capacità di scuotere le fondamenta delle certezze condivise come “Il vangelo ebraico: Le vere origini del cristianesimo” di Daniel Boyarin. In questo saggio denso, erudito e al tempo stesso accessibile, il rinomato studioso del Talmud e della cultura rabbinica si prefigge un obiettivo tanto ambizioso quanto dirompente: decostruire la grande narrazione che per duemila anni ha contrapposto ebraismo e cristianesimo come due universi teologici distinti e inconciliabili. La tesi di Boyarin, sostenuta con una meticolosa analisi dei testi evangelici e della letteratura ebraica coeva, è che questa separazione non fu un evento originario, una “biforcazione delle vie” avvenuta con la predicazione di Gesù, ma il lento e sofferto prodotto di secoli di controversie, polemiche e, in ultima analisi, di una ridefinizione politica delle identità religiose. Il cristianesimo primitivo, lungi dall’essere una religione “nuova” sorta in opposizione a una “vecchia”, era, nella visione di Boyarin, una delle tante, vibranti e legittime espressioni del pluralistico mondo ebraico del Secondo Tempio. L’opera si propone quindi come un audace tentativo di “rimpatrio”: riportare i Vangeli a casa, nel loro contesto ebraico originario, per leggerli non come l’atto di fondazione di un’alterità, ma come un capitolo interno, per quanto radicale e di enorme successo, della storia religiosa di Israele.
Una prefazione illuminante: La parabola dei gemelli di Jack Miles
La prefazione, a cura di Jack Miles, funge da magistrale porta d’ingresso al pensiero di Boyarin, preparandone il lettore alla natura “conturbante” delle tesi che incontrerà. Miles, da una prospettiva cristiana, non nasconde come le idee dello studioso ebreo possano turbare profondamente le auto-percezioni consolidate di entrambe le fedi, proprio perché ne “sfumano i contorni” e complicano identità costruite per reciproca definizione negativa. Per rendere tangibile il cuore del progetto di Boyarin, Miles ricorre a una splendida e memorabile parabola: quella dei due gemelli, Ben e Josh.
Ben è il prototipo dell’atleta, un ragazzo ambizioso e fisicamente prestante, incoraggiato dalla madre proveniente da una famiglia di sportivi. Josh, al contrario, è il cantautore sognatore, l’anima romantica e sensibile, prediletto dal padre che discende da una stirpe di musicisti. Pur essendo gemelli e conoscendosi intimamente, le aspettative familiari e sociali li spingono a cristallizzarsi in questi ruoli semplificati. Ben è “l’atleta”, Josh è “l’artista”. Con il tempo, entrambi finiscono per interiorizzare queste etichette, dimenticando o reprimendo le parti di sé che non si conformano al modello. Ben quasi si scorda di possedere una meravigliosa voce tenorile, che solo Josh conosce, e Josh smette di allenarsi nel baseball, sport in cui un tempo poteva persino battere il fratello. Le loro sono diventate, come le definisce Miles, “identità reciprocamente stabilite”: ognuno è definito non solo da ciò che è, ma soprattutto da ciò che l’altro rappresenta.
Questa parabola è la chiave di volta per comprendere la relazione tra ebraismo e cristianesimo come la vede Boyarin. Sono i due gemelli. Nati dalla stessa matrice culturale e spirituale, hanno passato i primi secoli della loro esistenza come parte della stessa “famiglia”, litigando e dibattendo, ma pur sempre sotto lo stesso tetto. Fu solo attraverso un lungo processo di polemiche, persecuzioni e ridefinizioni teologiche che iniziarono a vedersi come entità separate e opposte, ripudiando come “alieno” ciò che in origine faceva parte del patrimonio comune. L’ebraismo ha represso la sua antica vena “binitariana” e le sue complesse speculazioni messianiche per definire se stesso contro la cristologia cristiana; il cristianesimo, a sua volta, ha ripudiato la sua eredità legale e rituale (la Torah) per definirsi come la religione della fede e dell’amore in opposizione al presunto “legalismo” ebraico.
Il ruolo di Boyarin, in questa metafora, è quello di un vecchio e saggio insegnante, il signor Boyarin, che, invitato a cena dalla famiglia, si imbatte nel vecchio album di fotografie. Lì scopre le prove dimenticate della loro complessità originaria: una foto di Josh, il menestrello, vestito da giocatore di football, e una di Ben, l’atleta, che canta come soprano solista nel coro della scuola. Boyarin è lo storico che riporta alla luce questi “siparietti così estranei ai personaggi”, dimostrando che le identità rigide e semplificate sono una costruzione posteriore, non un dato di fatto originario.
Miles stesso confessa come la lettura di Boyarin abbia trasformato la sua percezione delle Scritture. Racconta di aver ascoltato in chiesa il Vangelo di Matteo (capitolo 23), dove Gesù critica aspramente i farisei ma allo stesso tempo ingiunge alla folla: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo”. Solo dopo aver letto Boyarin, Miles ha colto la portata di quella frase: non un preludio all’abolizione della Legge, ma una critica feroce al modo ipocrita di viverla, una difesa della Legge mosaica contro la sua strumentalizzazione. La domanda che pone Miles, e che il libro di Boyarin esplorerà, diventa quindi quasi ovvia, per quanto scioccante per la sensibilità tradizionale: se Gesù non aveva nulla contro la Legge, “perché mai non avrebbe dovuto” mangiare kosher?
L’introduzione di Boyarin: Decostruire la “religione” e la “separazione”
Nell’introduzione, Boyarin stesso prende la parola per esporre la sua metodologia. Egli attacca frontalmente l’idea che ebraismo e cristianesimo siano definibili tramite un modello che egli chiama a “lista di controllo” (checklist). Questo modello, tipico della modernità, presuppone che ogni religione sia un sistema chiuso di credenze e pratiche. Per essere cristiano, devi credere A, B e C (Trinità, incarnazione) e non praticare X, Y e Z (leggi alimentari, circoncisione). Per essere ebreo, devi fare il contrario. Questo approccio, sostiene Boyarin, è anacronistico e proietta sul passato categorie che non gli appartengono.
Nell’antichità, il concetto stesso di “religione” come sfera separata della vita non esisteva. Esistevano i popoli, e ogni popolo aveva i suoi culti, le sue leggi e le sue tradizioni. L’ebraismo non era una “fede” a cui si poteva aderire o meno, ma il complesso di “rituali, pratiche, credenze e valori, storia e devozioni politiche legati al popolo d’Israele”. In questo mondo, l’idea di un ebreo che credeva in Gesù come Messia non creava una contraddizione in termini, non lo espelleva automaticamente dalla sua identità etnico-culturale. Egli era semplicemente un ebreo con una particolare credenza messianica, così come c’erano ebrei sadducei, farisei, esseni, zeloti, ognuno con le proprie interpretazioni della Torah e le proprie aspettative.
La “separazione delle vie”, quindi, non fu un evento singolo e precoce, ma un processo lungo e graduale. Boyarin rifiuta l’idea che la distruzione del Tempio nel 70 abbia causato un’immediata biforcazione. La diversità continuò per secoli. Il vero punto di svolta, egli sostiene, fu l’intervento del potere imperiale romano. Con la conversione di Costantino, il cristianesimo si trovò nella necessità di definire un’ortodossia chiara e universale. I grandi concili ecumenici, in particolare quelli di Nicea e Costantinopoli, furono gli strumenti di questa normalizzazione. Furono questi concili a creare la “lista di controllo” ufficiale, stabilendo dogmi come la consustanzialità del Figlio e separando nettamente la Pasqua cristiana dalla Pèsach ebraica. Questo processo, imposto con la forza della legge imperiale, rese impossibile ciò che prima era stato possibile: essere contemporaneamente ebreo e cristiano.
A riprova di questa tesi, Boyarin cita un passo straordinario da una lettera di San Girolamo, che lamenta l’esistenza di una setta, i Nazareni, i quali accettano pienamente il credo niceno (la divinità di Cristo, la nascita verginale, la risurrezione) ma persistono nel voler seguire la Legge ebraica, frequentando le sinagoghe. La conclusione sconcertata e infastidita di Girolamo è che “non sono né giudei né cristiani”. Per Boyarin, questa è la prova regina. Queste persone esistevano, si consideravano pienamente ebrei e pienamente seguaci di Cristo, e fu solo l’imposizione di una logica binaria ed esclusivista, promossa sia dalle autorità ecclesiastiche che da quelle rabbiniche emergenti, a dichiarare la loro identità “impossibile”.
Al posto di questo modello rigido, Boyarin propone di adottare il concetto di “somiglianza di famiglia” di Wittgenstein. I vari gruppi che componevano l’ebraismo del primo secolo, inclusi i seguaci di Gesù, non condividevano tutti un’unica essenza, ma erano legati da una complessa rete di somiglianze e differenze sovrapposte. Un gruppo poteva condividere una credenza teologica con i seguaci di Gesù ma non una pratica rituale, e viceversa. Questa visione permette di includere i Vangeli e i primi scritti cristiani all’interno del “raggio d’azione” dell’ebraismo, come documenti di una delle sue tante, affascinanti “famiglie”.
Capitolo 1: La sorprendente inversione di “Figlio di Dio” e “Figlio dell’Uomo”
Il primo capitolo del saggio entra nel vivo della teologia, affrontando i titoli cristologici fondamentali di Gesù e operando un rovesciamento interpretativo radicale. Nell’immaginario comune, “Figlio di Dio” è il titolo che esprime la divinità di Gesù, mentre “Figlio dell’Uomo” si riferisce alla sua natura umana. Boyarin dimostra che, nel contesto ebraico originale, era vero quasi l’esatto contrario.
- “Figlio di Dio” come titolo umano e regale: Boyarin spiega che, nella Bibbia ebraica, “Figlio di Dio” non era un titolo ontologico, ma politico e funzionale. Era uno degli appellativi del re d’Israele, il Mashiach (l’Unto), discendente della dinastia davidica. L’unzione con l’olio consacrava il re, rendendolo rappresentante di Dio sulla terra. Citando il Salmo 2, “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato”, Boyarin evidenzia come il testo si riferisca a un’adozione divina che avviene in un momento preciso, “oggi”, cioè il giorno dell’incoronazione. Era un titolo che esprimeva un rapporto di intimità e delega tra Dio e il re, ma il re rimaneva un essere umano. Era il sovrano terreno d’Israele, non una divinità incarnata.
- “Figlio dell’Uomo” come titolo divino: La vera pretesa di divinità, sostiene Boyarin, si nasconde nel titolo apparentemente più umile: “Figlio dell’Uomo”. Le sue origini non vanno cercate in un generico riferimento all’umanità, ma in una lettura specifica e potente del capitolo 7 del Libro di Daniele. In questo testo apocalittico, il profeta ha una visione celeste in cui compaiono due figure divine: un “vegliardo” (l’Antico dei Giorni), che siede su un trono di fuoco, e una seconda figura, descritta come “simile a un figlio di uomo”, che arriva sulle nubi del cielo. A questa seconda figura viene concesso un dominio eterno e universale.
Secondo Boyarin, questa visione non è un’invenzione del II secolo a.C., ma l’eco di una teologia israelitica antichissima e in gran parte soppressa, una teologia “binitariana” che ricorda la struttura del pantheon cananeo, con un dio padre anziano e trascendente (‘El) e un dio figlio giovane, guerriero e attivo nel mondo (Ba’al). Sebbene il monoteismo biblico ufficiale abbia fuso queste due figure in YHWH, questa antica dualità non è mai scomparsa del tutto e riemerge potentemente in testi apocalittici come Daniele. L’autore stesso di Daniele, secondo Boyarin, era a disagio con questa teologia, tanto che, nella seconda parte del capitolo, fa interpretare da un angelo la figura del “figlio di uomo” non come un essere divino, ma come un’allegoria del “popolo dei santi dell’Altissimo”, cioè Israele perseguitato. Questa discrepanza, per Boyarin, è la prova di un conflitto teologico interno all’ebraismo stesso, molto prima di Gesù.
Quando Gesù, nei Vangeli, si autodefinisce “Figlio dell’Uomo”, sta bypassando l’interpretazione allegorica e rivendicando per sé lo status della figura divina originale della visione di Daniele. È questa l’affermazione che suona blasfema alle orecchie dei suoi interlocutori. Quando in Marco 2, Gesù si arroga l’autorità (exousía) di perdonare i peccati, sta reclamando la sovranità divina concessa al “figlio di uomo” in Daniele. Quando si dichiara “Signore del sabato”, non sta abolendo la legge, ma sta affermando che la sua autorità divina, quella del Redentore escatologico, ha giurisdizione anche sulla più sacra delle istituzioni.
Capitolo 2: Testimoni indipendenti: Enoc e il Quarto Libro di Ezra
Per rafforzare la sua tesi che la cristologia alta non fu un’invenzione ad hoc dei seguaci di Gesù, ma una corrente di pensiero già presente nell’ebraismo, Boyarin si rivolge a due testi apocalittici non cristiani.
- Le Similitudini (o Parabole) di Enoc: Questo testo, parte del corpus del Primo Libro di Enoc e databile (secondo l’autore) all’incirca allo stesso periodo dei Vangeli, è per Boyarin il pezzo da novanta. Esso presenta una figura di Redentore, chiamato esplicitamente “il Figlio dell’Uomo”, le cui caratteristiche sono sorprendentemente simili a quelle del Cristo evangelico. Questo Figlio dell’Uomo enochico è una figura divina e preesistente, il cui nome esisteva presso il “Signore degli Spiriti” prima ancora della creazione. È destinato a essere giudice finale, a ricevere adorazione universale e, in un passo fondamentale, viene chiamato “il Suo Messia”. Le Similitudini, quindi, presentano una “cristologia alta” pienamente formata, con un Messia divino e preesistente, in un contesto interamente ebraico e indipendente dalla tradizione evangelica. Ma c’è di più. La narrazione culmina in un evento straordinario: il patriarca umano Enoc, dopo la sua ascesa al cielo, viene identificato con questa figura divina. Un angelo si rivolge a lui e gli dice: “Tu sei il Figlio dell’Uomo”. In questo momento, Boyarin vede la sintesi di due modelli teologici: la teofania (la discesa di un Dio che si manifesta in forma umana) e l’ apoteosi (l’ascesa di un uomo che viene divinizzato). Questa complessa dinamica, questa fusione tra l’umano e il divino, è esattamente la stessa che sta al cuore del mistero di Cristo nei Vangeli.
- Il Quarto Libro di Ezra: Scritto dopo la distruzione del Tempio, anche questo testo presenta una visione di un Redentore messianico che è una chiara rielaborazione della figura di Daniele 7. Ezra vede “qualcosa di simile a un uomo” salire dal mare e volare “assieme alle nubi del cielo”, un guerriero divino che distrugge i nemici di Dio. Anche qui, la figura è identificata con il Messia. La presenza di questa stessa tradizione interpretativa in un testo diverso e indipendente conferma, secondo Boyarin, che l’idea di un Messia divino, il “Figlio dell’Uomo”, era una credenza diffusa e dibattuta all’interno dell’ebraismo del primo secolo. Gesù non inventò questo ruolo, ma si inserì in un’aspettativa già esistente.
Capitolo 3: La difesa della Torah: Gesù mangiava kosher
Dopo aver esplorato le altezze della teologia, Boyarin scende sul terreno pratico della legge religiosa, la halakha, per affrontare una delle presunte prove più evidenti della rottura di Gesù con l’ebraismo: l’episodio di Marco 7, in cui sembra che questi voglia abolire le leggi alimentari. L’argomentazione di Boyarin è un capolavoro di esegesi contestuale, basata su una distinzione fondamentale tra due tipi di leggi alimentari nella Torah.
- Leggi del Kashrut: Queste sono le leggi che specificano quali animali si possono mangiare e quali no (es. il divieto di mangiare maiale). Sono leggi che riguardano la natura intrinseca del cibo.
- Leggi di purità e impurità (tuma’h vetaharah): Questo è un sistema rituale distinto. Un cibo perfettamente kosher (permesso) può diventare ritualmente impuro se viene a contatto con una fonte di impurità (ad esempio, un cadavere o una persona in uno stato di impurità rituale).
La controversia descritta in Marco 7, insiste Boyarin, non ha nulla a che fare con il kashrut, ma riguarda esclusivamente la seconda categoria, le leggi di purezza. I farisei venuti da Gerusalemme accusano i discepoli di mangiare “con mani immonde”. Questa pratica del lavaggio rituale delle mani prima di mangiare il pane non è un comandamento della Torah scritta, ma un’innovazione dei farisei, parte della loro “tradizione degli antichi”. Essi avevano esteso le leggi di purezza, originariamente legate al culto del Tempio, alla vita quotidiana, sostenendo che mangiare con mani ritualmente impure contaminasse non solo il cibo, ma anche la persona che lo mangiava.
La risposta di Gesù, quindi, non è un attacco alla Torah, ma una difesa conservatrice della Torah scritta contro queste innovazioni farisaiche. Quando egli afferma che “non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo”, sta riaffermando il principio biblico secondo cui l’impurità rituale è generata da ciò che esce dal corpo (flussi corporei), non da ciò che entra. Egli accusa i farisei di sostituire il “comandamento di Dio” con i loro “precetti di uomini”.
In questa luce, la frase finale del narratore, “Dichiarava così mondi tutti gli alimenti”, assume un significato completamente diverso. Non significa che Gesù rendesse lecito mangiare cibi non kosher. Significa che, rifiutando la dottrina farisaica sulla contaminazione, egli dichiarava tutti i cibi (kosher) “puri” dal punto di vista rituale, liberandoli da questo strato aggiuntivo di regole inventate dall’uomo. Gesù, dunque, non abolisce la Torah, la difende. La sua era una lotta interna all’ebraismo, tra una visione tradizionalista (probabilmente tipica della Galilea rurale) e le nuove tendenze riformiste e rigoriste provenienti dal centro urbano di Gerusalemme.
Capitolo 4 e Epilogo: La passione del Messia come midrash ebraico
Nell’ultimo capitolo, Boyarin affronta il tema più iconico e apparentemente divisivo: la Passione di Cristo. L’idea di un Messia sofferente e morente è universalmente considerata la linea di demarcazione definitiva tra ebraismo e cristianesimo. La narrazione comune vuole che questa teologia sia stata sviluppata ex eventu, dopo la crocifissione, come un modo per dare un senso a un esito disastroso e inaspettato.
Boyarin, ancora una volta, capovolge la prospettiva. L’idea di un Messia sofferente, egli sostiene, non era affatto estranea al pensiero ebraico, ma poteva essere derivata direttamente dalle Scritture attraverso il metodo interpretativo del midrash. Il midrash è l’arte rabbinica di accostare versetti provenienti da diverse parti della Bibbia per illuminarsi a vicenda e generare nuovi significati.
La narrazione evangelica della passione, secondo Boyarin, è un grandioso esempio di questo processo. Gli evangelisti hanno tessuto insieme diversi fili scritturali. Il primo è, ancora una volta, il capitolo 7 di Daniele. Se il Messia è il “Figlio dell’Uomo”, allora la sua storia deve includere anche la parte della profezia in cui si dice che i “santi” (figura del Messia) saranno sconfitti e perseguitati dalla bestia “per un tempo, più tempi e la metà di un tempo”, prima della loro vittoria finale. Questo fornisce un modello biblico per un periodo di umiliazione e sofferenza.
Questo modello viene poi intrecciato con un’altra potentissima figura biblica: il “servo sofferente” di Isaia 53, un uomo “disprezzato e reietto dagli uomini” che “si è caricato delle nostre sofferenze”. Contrariamente all’idea moderna che gli ebrei abbiano sempre interpretato questa figura come un’allegoria del popolo di Israele, Boyarin dimostra, citando fonti talmudiche e medievali, che un’influente tradizione ebraica ha sempre identificato il servo sofferente con il Messia stesso. Il Talmud Babilonese, ad esempio, chiama il Messia “il lebbroso”, basandosi proprio su questo passo di Isaia.
La teologia della Passione, dunque, non è un’invenzione cristiana post-crocifissione. È il risultato di una profonda e creativa esegesi midrashica, pienamente coerente con le tecniche interpretative ebraiche, che ha visto nel destino di Gesù il compimento delle profezie su un Messia divino (il Figlio dell’Uomo di Daniele) destinato a un periodo di sofferenza vicaria (il servo di Isaia).
Nell’epilogo, Boyarin tira le fila del suo discorso. Il suo libro è un invito a riconsiderare radicalmente la storia delle origini cristiane. I Vangeli non sono il manifesto di una nuova religione, ma testi profondamente ebraici, che riflettono i dibattiti, le speranze e le modalità di pensiero dell’ebraismo del loro tempo. La grande tragedia storica è che il cristianesimo successivo, nel definire la propria identità, ha “strappato quel testo di natura ebraica dalle sue radici culturali”, trasformandolo in un’arma contro quelle stesse tradizioni che, in origine, esso cercava di interpretare e, a suo modo, di difendere. “Il vangelo ebraico” è, in definitiva, un potente appello a riconoscere che, prima della divisione, c’era una storia condivisa, e che le radici del grande albero del cristianesimo affondano interamente e inestricabilmente nel ricco e fertile suolo dell’ebraismo.
Conclusione
In definitiva, “Il vangelo ebraico” di Daniel Boyarin è un’opera di rara potenza intellettuale, un saggio destinato a lasciare un segno indelebile in chiunque sia interessato alle complesse e intrecciate origini di ebraismo e cristianesimo. La sua meticolosa decostruzione delle categorie teologiche che hanno definito per secoli le due fedi in opposizione reciproca è tanto rigorosa quanto illuminante. Rileggendo i Vangeli non come il primo capitolo di una nuova religione, ma come un vibrante capitolo della letteratura ebraica del Secondo Tempio, Boyarin sfida entrambe le tradizioni a riconsiderare le proprie origini e la propria relazione con l’altro. La sua analisi del “Figlio dell’Uomo” come titolo divino, di Gesù come difensore conservatore della Torah contro le innovazioni farisaiche, e la dimostrazione di come una “cristologia alta” fosse già presente in testi come il Libro di Enoc, sono argomentazioni formidabili che ridefiniscono il panorama del dibattito. Tuttavia, è proprio nell’affrontare il culmine della narrazione evangelica, la Passione, che la sua affascinante costruzione interpretativa presenta, per certi versi, il suo punto più debole e controverso. Boyarin dimostra magistralmente come la nozione di un Messia sofferente sia stata trovata e articolata dal movimento gesuano post-pasquale attraverso una interpretazione di tipo squisitamente midrashico delle Scritture, un processo creativo interamente ebraico. Eppure, a differenza della sua tesi sul “Figlio dell’Uomo”, supportata da testi coevi e indipendenti, qui l’argomentazione si basa più sulla dimostrazione di una potenzialità ermeneutica che sull’evidenza di una credenza preesistente. Manca, infatti, oggettivamente una chiara traccia di una dottrina consolidata del “Messia sofferente” nella letteratura giudaica del Secondo Tempio a noi nota; l’aspettativa dominante rimaneva quella di un liberatore trionfante. Questo non invalida la tesi centrale di Boyarin sulla “ebraicità” del processo, ma sposta l’accento dalla scoperta di un’idea già presente alla radicale innovazione teologica compiuta dai primi seguaci di Gesù. Questa innovazione, per quanto condotta con strumenti ebraici, rappresenta una rottura con le aspettative precedenti più netta di quanto non facciano gli altri elementi della sua cristologia. Ciononostante, anche questa critica non fa che sottolineare la grandezza del libro: esso ci costringe a pensare, a mettere in discussione e, infine, a comprendere con una profondità senza precedenti che la storia di Gesù, del suo movimento e dei testi che lo raccontano non è una storia anti-ebraica. È, in ogni sua fibra, un Vangelo profondamente ebraico.
Per chi volesse acquistare il volume: https://amzn.to/44IVAVS

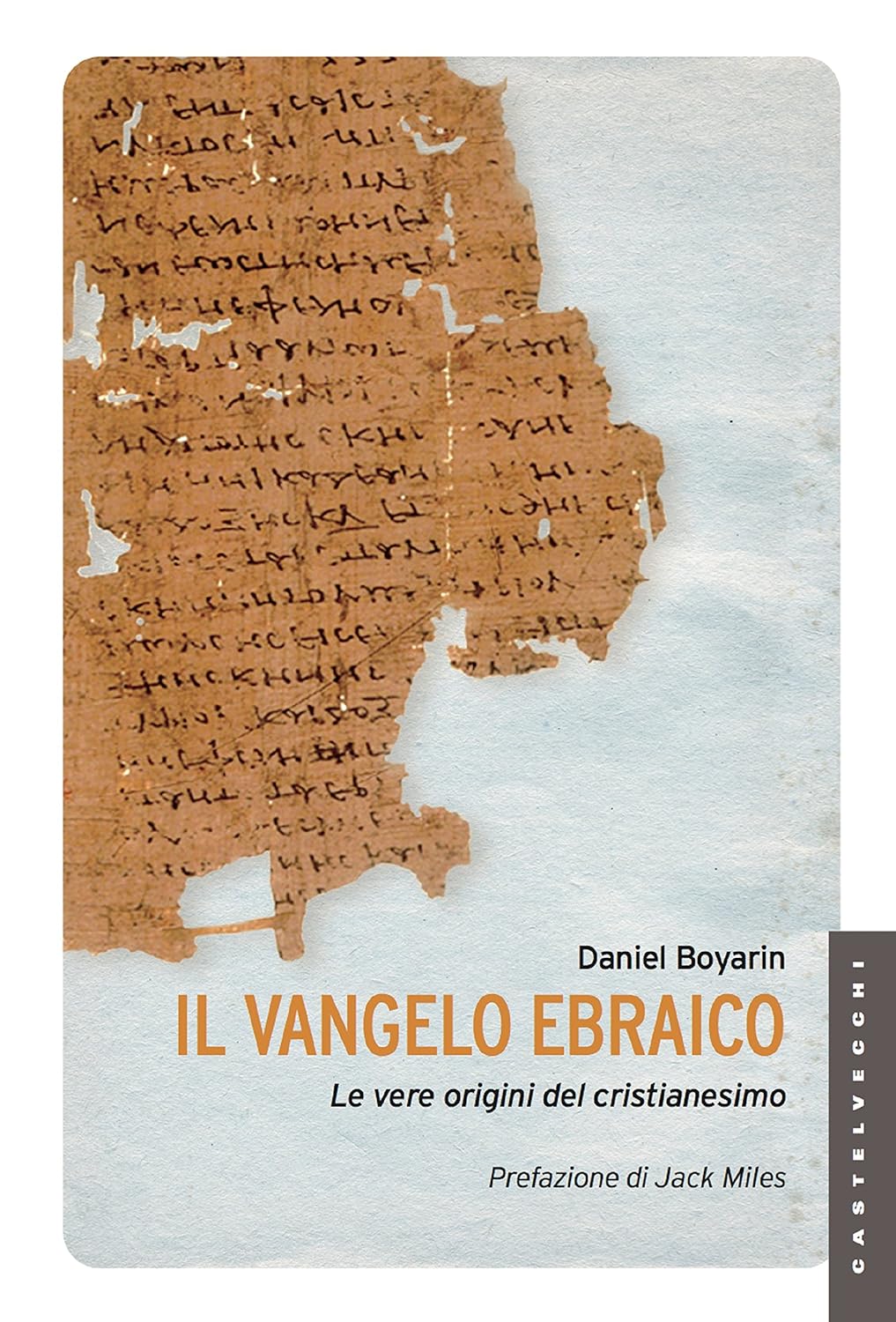
Bellissimo libro (anche se l’edizione italiana non e’ impeccabile, meglio rifarsi all’originale). E bellissima e chiarissima come sempre la recensione di Adriano. Boyarin si colloca in un filone di ricerca che dagli anni ottanta (con Alan Segal e altri) ha sottolineato l’origine comune di cristianesimo e giudaismo rabbinico “dallo stesso grembo” e si e’ nutrito della sua intensa partecipazione ai lavori dell’Enoch Seminar, con la riscoperta del contributo essenziale dato alle origini cristiane dalla tradizione enochica (e in particolare dal Libro delle Parabole di Enoc). Per chi non l’avesse ancora fatto, e’ una lettura fondamentale.
Ma che fine fanno le lettere di Paolo che pure precedono la stesura dei vangeli? Mi riferisco alle prescrizioni per i discepoli provenienti dai gentili. E qui la cosa si complica parecchio. Che ne pensi?
La cosa pare molto più complessa se si continua a leggere Paolo con gli occhi di una lunga tradizione. Ma Paolo era un ebreo del suo tempo.
In italiano ora ci sono Boccaccini e Mariotti:
https://www.carocci.it/prodotto/paolo-di-tarso-un-ebreo-del-suo-tempo?srsltid=AfmBOoq-6fljdTNozeEUIYDCI7HwjA6mMs_HCWk6sr-dH8xQCIU7uwv5
https://www.claudiana.it/scheda-libro/gabriele-boccaccini/le-tre-vie-di-salvezza-di-paolo-lebreo-9788868983048-2233.html