Il significato di una conversione controcorrente
In un’epoca in cui la traiettoria spirituale occidentale sembra spesso muoversi dal cristianesimo nominale o dal secolarismo verso le religioni orientali, un’opera che tratta di un caso che inverte radicalmente questa tendenza merita un’attenzione particolare.
The Unexpected Way: On Converting from Buddhism to Catholicism di Paul Williams non è semplicemente un racconto di conversione; è una testimonianza intellettuale e spirituale di eccezionale importanza, proveniente da una fonte di ineguagliabile credibilità. L’autore, Paul Williams, non è un neofita del pensiero buddista, ma un’autorità accademica di fama mondiale. Come Professore Emerito di Filosofia Indiana e Tibetana presso l’Università di Bristol, ex direttore del Dipartimento di Teologia e Studi Religiosi, ex direttore del Centro per gli Studi Buddisti e passato presidente dell’Associazione Britannica per gli Studi Buddisti, la sua competenza è indiscutibile. La sua opera Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations è considerata un testo di riferimento nel campo, a testimonianza della sua profonda e simpatetica comprensione della tradizione che ha poi lasciato.
Questo libro trascende il genere della semplice narrazione di conversione per diventare una formidabile opera di autobiografia intellettuale e un avvincente saggio di apologetica. Esso argomenta con forza la superiorità razionale della fede cattolica rispetto a quella buddista. La potenza del libro risiede nella sua fusione unica di argomentazione filosofica rigorosa, onestà personale disarmante e profonda intuizione spirituale, che lo rendono un “classico moderno della spiritualità cattolica” e un potenziale “punto di svolta nel dialogo tra buddismo e cristianesimo”. Il suo significato primario deriva dalla sua natura di “critica dall’interno”. A differenza delle polemiche scritte da esterni, l’analisi di Williams di quelle che a suo avviso sono le carenze filosofiche ed esistenziali del buddismo ha un peso immenso proprio perché proviene da uno dei più rispettati interpreti occidentali e da un devoto praticante della tradizione che ha abbandonato. Ciò costringe a un confronto più serio sia i buddisti che i cristiani, sfidando entrambe le tradizioni a “verificare la coerenza delle proprie convinzioni intellettuali e morali” ed elevando il libro da semplice storia personale a evento significativo nel discorso interreligioso.
L’architettura di una confessione intellettuale
The Unexpected Way si distingue per la sua forma letteraria ibrida e complessa. Non è un memoriale standard, ma una miscela di generi che lo rende un’opera unica nel suo genere. È stato descritto come un “saggio di teologia radicale postmoderna” , un'”affascinante autobiografia intellettuale” e un’opera di apologetica cristiana che “suona vera perché affronta le questioni sulla religione che turbano molti”. La sua struttura e il suo tono lo collocano nella grande tradizione delle confessioni spirituali, come le Confessioni di Sant’Agostino o Sorpreso dalla gioia di C.S. Lewis, in cui il percorso intellettuale e quello personale sono inestricabilmente legati.
Uno dei maggiori punti di forza del libro è lo stile “altamente leggibile” e “colloquiale” di Williams. Questa scelta stilistica rende accessibili argomenti filosofici complessi senza sacrificare il rigore. L’autore ha la rara abilità di ancorare il pensiero astratto a una realtà concreta e quotidiana, come le sue riflessioni sul gatto di casa, Wensleydale, o le ciambelle. Questa tecnica serve a demistificare la filosofia e a collegarla direttamente all’esperienza vissuta. Il capitolo “Can Wensleydale be saved?” (“Wensleydale può essere salvato?”) è un esempio emblematico di questo metodo: una domanda apparentemente banale sul destino eterno di un animale domestico diventa una profonda esplorazione dell’identità personale, della speranza e della salvezza, affrontata con compassione, solida erudizione e argomentazioni attentamente ragionate.
Il libro è costruito su una chiara progressione logica tripartita.
- Il caso filosofico di Dio: Williams inizia esaminando gli argomenti a favore dell’esistenza di Dio, della moralità oggettiva e della natura della comunità umana.
- Il caso della risurrezione di Cristo: Successivamente, presenta le prove che ha trovato convincenti riguardo alla risurrezione di Cristo.
- Il caso della teologia cattolica: Infine, spiega le ragioni della sua scelta specifica del cattolicesimo romano rispetto ad altre confessioni cristiane.
Questa struttura metodica dimostra la natura ragionata della sua conversione, contrastando qualsiasi idea che si sia trattato di un salto puramente emotivo o irrazionale.
La crisi della speranza: la critica di un insider alla soteriologia buddista
Il nucleo della crisi intellettuale e spirituale di Williams risiede in una conclusione tanto semplice quanto devastante: il buddismo, con tutta la sua raffinatezza filosofica, era per lui in ultima analisi “senza speranza” (hope-less). Questa crisi interiore, che può essere analizzata attraverso i modelli psicologici della conversione che spesso iniziano con una fase di “crisi” che precipita una “ricerca” di nuovo significato , non fu innescata da eventi esterni, ma da un profondo malessere esistenziale.
Il punto di rottura fu il suo confronto con la dottrina dell’ anattā (non-sé). Questa dottrina centrale del buddismo insegna che non esiste un sé o un’essenza (ātman) permanente e immutabile in alcun fenomeno; ciò che percepiamo come “io” è solo un aggregato temporaneo e mutevole. Williams arrivò a vedere questa non come una verità liberatoria, ma come una dottrina di annientamento personale definitivo. L’idea che la persona “Paul Williams” sarebbe semplicemente cessata di esistere, lasciando solo un flusso causale impersonale, divenne fonte di un’angoscia esistenziale profonda. Sebbene i critici buddisti potrebbero identificare questo desiderio di continuità personale come bhava-taṇhā (brama di esistenza), per Williams era un anelito umano legittimo e profondo che il buddismo non poteva soddisfare.
Questa critica si estende ai concetti correlati di rinascita e karma. Il modello buddista di rinascita non è la trasmigrazione di un’anima, ma un continuum causale, simile a una candela che ne accende un’altra; il karma determina la natura della prossima esistenza nel ciclo del saṃsāra. Williams trovò questo processo meccanicistico privo di speranza personale e di relazione. Il ciclo karmico offriva una ripetizione infinita, ma non una salvezza definitiva per la persona. La sua domanda sul destino del suo gatto Wensleydale funge da ancora emotiva per questo tema filosofico: se non c’è un sé duraturo, qual è il significato ultimo dell’amore, dell’attaccamento e delle vite individuali? La risposta del buddismo gli parve un’alzata di spalle cosmica.
Tuttavia, la crisi intellettuale di Williams rispetto alla dottrina buddista è profondamente intrecciata con una “reversione” culturale e psicologica al suo paesaggio spirituale nativo. La sua conversione non è solo la scelta di una nuova filosofia, ma un ritorno al mondo simbolico della sua infanzia. La sua storia personale rivela un affetto profondo e duraturo per le chiese anglicane, le cattedrali e la musica cristiana, sentimenti che persistettero anche durante i suoi anni da buddista. Il suo subconscio produceva immagini di chiese inglesi quando gli veniva chiesto di visualizzare scene pacifiche, suggerendo un’identità culturale-religiosa profondamente radicata. Questo “cristianesimo inconscio” e il bisogno di sentirsi parte del “paesaggio sacro” della propria cultura sono potenti forze psicologiche nella conversione. Pertanto, la sua insoddisfazione intellettuale rispetto alla dottrina buddista può essere vista come la struttura razionale che ha permesso a una spinta emotiva e culturale preesistente verso il cristianesimo di attualizzarsi. Il suo percorso esemplifica l’idea che la vera realizzazione può essere colta solo attraverso i miti e i simboli della propria cultura, aggiungendo uno strato di profondità psicologica che mostra la conversione come un evento umano olistico, non solo un esercizio filosofico.
L’attrazione del logos: costruire una fede razionale
Il percorso intellettuale di Williams rappresenta un cambiamento fondamentale da una visione del mondo che può accogliere una realtà senza inizio e senza causa (un “fatto bruto”, come direbbero i filosofi) a una che esige una spiegazione ultima. La cosmologia buddista, con il suo concetto di un saṃsāra senza inizio, accetta una forma di regresso all’infinito, che è filosoficamente simile ad accettare l’universo come un fatto inspiegabile. Williams, tuttavia, è spinto dalla domanda ultima “perché?”, allineandosi con il Principio di Ragion Sufficiente di Leibniz, che postula che tutto debba avere una ragione o una causa. Questa esigenza di una “ragione sufficiente” per l’intera “serie di cose” lo conduce direttamente agli argomenti teistici classici. La sua conversione non è quindi meramente religiosa, ma un profondo perno filosofico dall’accettare la contingenza come ultima alla richiesta di un fondamento necessario per la contingenza.
I pilastri della sua fede razionale sono solidi e ben argomentati:
- L’argomento della contingenza: Williams trovò nella filosofia tomista una spiegazione potente per l’esistenza. Poiché tutte le cose osservabili sono contingenti (potrebbero non essere esistite), la loro esistenza deve dipendere da un “essere necessario” non contingente, che chiamiamo Dio. Questo fornì la risposta definitiva alla domanda “perché?” che il buddismo, a suo avviso, lasciava aperta.
- L’argomento cosmologico kalam: Questo argomento, che afferma che tutto ciò che inizia a esistere ha una causa e che l’universo ha avuto un inizio, conclude che l’universo deve avere una causa. Ciò rafforza la necessità di una Causa Prima, fornendo un quadro temporale all’argomento della contingenza.
- La storicità della risurrezione: Williams applica la ragione non solo alla metafisica ma anche alla storia, trovando convincenti le prove della risurrezione di Cristo. Il suo approccio è paragonabile a quello di apologeti moderni come Gary Habermas, che costruisce un caso basato su “fatti minimi” accettati anche dagli storici scettici.
Il percorso di Williams è una perfetta illustrazione vivente dei principi articolati nell’enciclica Fides et Ratio di Papa Giovanni Paolo II del 1998. Il libro dimostra, piuttosto che semplicemente enunciare, la relazione armoniosa tra fede e ragione. L’enciclica sostiene che fede e ragione sono “come due ali” che lavorano insieme per raggiungere la verità, e che la ragione senza fede porta al nichilismo, mentre la fede senza ragione porta alla superstizione. L’intero progetto di Williams è mostrare che il suo passaggio al cattolicesimo è intrinsecamente razionale. Egli incarna l’appello dell’enciclica alla filosofia affinché si impegni rispetto alla “questione radicale della verità sull’esistenza personale, sull’essere e su Dio”. Inquadrando la sua narrazione in questo contesto, si eleva l’importanza del libro, presentandolo come un testo chiave dell’apologetica cattolica contemporanea e una testimonianza della vitalità duratura della sintesi tomista di fede e ragione.
Perché Roma?
Una volta accettata l’esistenza di Dio e la risurrezione di Cristo, la domanda successiva per Williams è: quale Chiesa? La sua scelta del Cattolicesimo Romano non costituisce un approdo scontato, ma il risultato di un’ulteriore e rigorosa argomentazione teologica. Egli conclude che, se Dio è intervenuto nella storia, non può aver lasciato l’umanità senza una guida sicura riguardo al significato di tale intervento. La razionalità stessa esige una Chiesa autorevole in grado di interpretare la Rivelazione e la Scrittura, che spesso è oscura e necessita di una guida.
Questa ricerca di un’autorità lo porta a confrontarsi con le varie denominazioni cristiane. Egli respinge il Protestantesimo, inclusa la Chiesa Anglicana della sua infanzia, considerandolo “spiritualmente e psicologicamente impoverito” in confronto al Cattolicesimo. Mette in discussione la necessità divina della Riforma, in particolare quella inglese, che vede come un atto politico imposto dallo Stato su una Chiesa pre-riforma fiorente e popolare. La natura di “chiesa ampia” dell’Anglicanesimo, con i suoi confini dottrinali indefiniti, gli appare come una debolezza, non una forza. Williams desidera una Chiesa che sia sicura della propria autorità e che che cosa è corretto in materia di fede.
La sua scelta si concentra quindi sulle chiese che rivendicano una successione apostolica ininterrotta. Il punto centrale diventa il primato del Vescovo di Roma. Williams sostiene che una teocrazia, come la Chiesa, necessita di un leader terreno, un singolo arbitro dell’ortodossia per garantire la sopravvivenza e l’unità, specialmente in tempi di crisi. Egli vede questo ruolo come istituito da Cristo stesso in Pietro (Matteo 16,18) e confermato dalla preminenza storica della Sede Romana.
Lungi dall’essere un ostacolo, le dottrine cattoliche più “bizzarre” e contro-intuitive, come la Transustanziazione, la Nascita Verginale e l’Immacolata Concezione, diventano per Williams un elemento di ulteriore attrazione. Egli sostiene che una religione che ha perso il suo senso del mistero e del “non-razionale” è una religione “inutile”. La fede, per essere trasformativa, deve abbracciare il miracolo e lo stupore, e Williams trova che il Cattolicesimo “si gloria del non-razionale ed è fiducioso su quali dottrine non-razionali siano vere”.
Infine, la sua decisione è cementata dalla sua lettura dei primi Padri della Chiesa. In scritti come quelli di Ignazio di Antiochia, egli trova prove convincenti che gli elementi essenziali della fede cattolica – la Trinità, la Presenza Reale nell’Eucaristia, l’autorità della Chiesa e persino un primato di Roma – erano presenti fin dalle primissime generazioni cristiane. Questa continuità storica, unita alla sua profondità filosofica e alla sua chiara autorità, lo porta a concludere che la Chiesa Cattolica è l’unica Chiesa cristiana adatta per lui, quella che “parla come se avesse la Verità” e richiede una “obbedienza diretta”
Una testimonianza che è una sfida: il ruolo del libro nel dialogo interreligioso
L’impatto del libro va oltre le sue argomentazioni filosofiche. È un resoconto profondamente personale, segnato da “gratitudine e gioia” e da profonde esperienze post-conversione. Williams descrive la sua prima confessione come “travolgente… purificante, trasformante” e la sua visione del mondo dopo la prima Messa pasquale da cattolico come “cristallinamente limpida, splendente”, con ogni cosa che “cantava la sua dipendenza da Dio”. Questi momenti illustrano le conseguenze affettive e spirituali del suo impegno intellettuale.
Tuttavia, il tono del libro non è trionfalistico, ma di onesta ricerca. È un resoconto sincero e delicato. Il suo valore primario per il dialogo risiede nel fatto che sfida sia i cristiani che i buddisti a verificare la coerenza delle loro convinzioni intellettuali e morali, come l’oro viene provato nel fuoco. È una lettura essenziale per comprendere la fede nel nostro mondo religiosamente plurale.
Nella tabella sono illustrati i conflitti intellettuali centrali che hanno guidato la conversione di Williams:
| Domanda Esistenziale/ Filosofica | Prospettiva Buddista (come criticata da Williams) | Prospettiva Cattolica (come abbracciata da Williams) |
| La Natura del Sé | Anattaˉ (Non-Sé): Il sé è un’illusione; una collezione temporanea di aggregati mutevoli. La realtà ultima è la cessazione di questo flusso personale. | La persona come imago Dei: Il sé è un’anima reale e creata, una persona unica fatta a immagine di Dio, con un’identità duratura. |
| Realtà Ultima/Causa Prima | Origine dipendente: Una catena impersonale di causa ed effetto senza inizio (saṃsāra). Rifiuta una Causa Prima, abbracciando il regresso all’infinito. | Un Essere Necessario (Dio): Un Creatore personale, trascendente e non causato che è la ragione sufficiente per l’esistenza dell’universo contingente. |
| Il Problema della Sofferenza | Dukkha: La sofferenza deriva dalla brama e dall’ignoranza. La soluzione è l’Ottuplice Sentiero, che porta all’estinzione della brama e del sé. | La croce e la redenzione: La sofferenza è una conseguenza del peccato ma viene redenta e acquista significato attraverso il sacrificio personale e amorevole di Cristo. |
| La Natura della Speranza | “Senza speranza” (visione di Williams): La speranza è per il Nirvana, l’estinzione della fiamma dell’esistenza personale per porre fine alla sofferenza. | Speranzosa: La speranza è per la risurrezione personale, la vita eterna e la comunione con Dio e i santi in una creazione redenta. |
| Il Ruolo della Ragione | Strumentale: La ragione è uno strumento per comprendere la natura della realtà (impermanenza, non-sé) al fine di distaccarsene. Le domande ultime sul “perché” sono messe da parte. | Armoniosa con la fede: La ragione può condurre alla soglia della fede e dimostrare la coerenza della rivelazione. È un’ala per librarsi verso la Verità. |
Un classico moderno sul pellegrinaggio spirituale
In sintesi, The Unexpected Way è un’opera di eccezionale valore, che si distingue per la credibilità del suo autore, il rigore intellettuale, l’onestà personale e la risonanza culturale. Paul Williams, partendo da una posizione di profonda conoscenza e pratica del buddismo, costruisce attraverso il il racconto della sua conversione un caso molto solido per la coerenza e la razionalità della fede cattolica.
Il libro è una testimonianza potente della capacità della ragione di guidare il cuore umano verso un luogo di grazia e un ritorno a casa inaspettato. Non è semplicemente una critica al buddismo, ma un’affermazione positiva della visione cristiana del mondo, radicata in una profonda analisi filosofica e in una toccante esperienza personale. Per questi motivi, The Unexpected Way si afferma come un classico moderno della spiritualità cattolica e una lettura indispensabile non solo per teologi, filosofi e studenti di religione, ma per chiunque sia alle prese con le domande fondamentali sulla vita, il significato e la speranza nel nostro complesso mondo pluralista.

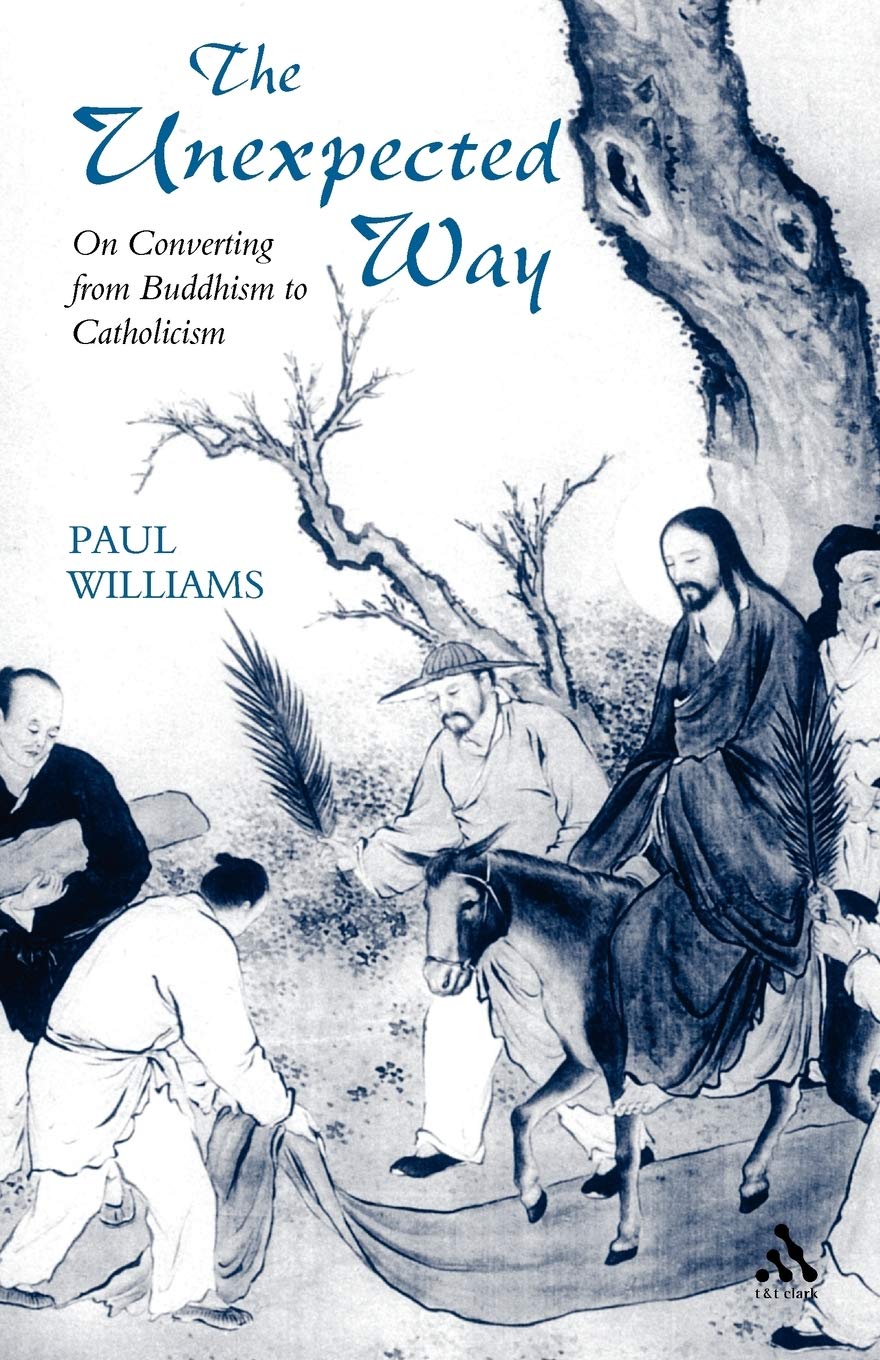
Bellissima e utilissima recensione. Grazie!