La figlia di Gibbon e il ritorno della polemica illuminista
Poche opere di storia antica hanno recentemente suscitato un dibattito pubblico così acceso come Nel nome della croce di Catherine Nixey (titolo originale: The Darkening Age), pubblicato in Italia dall’editrice Bollati Boringhieri di Torino. Salutato come un fenomeno editoriale internazionale e descritto con ammirazione per la sua prosa avvincente e la sua forza polemica — un recensore lo ha definito una “freccia di balista” — il libro si propone di rovesciare la narrazione tradizionale sulla transizione dalla Tarda Antichità al Medioevo. La tesi centrale di Nixey, esposta con chiarezza fin dalle prime pagine, è che il cosiddetto “trionfo” del cristianesimo non fu una conversione pacifica o un’evoluzione spirituale, ma una deliberata e sistematica distruzione della cultura, dell’arte e della filosofia del mondo classico da parte di un monoteismo intrinsecamente violento e intollerante. L’autrice dichiara esplicitamente di voler raccontare la storia dal punto di vista degli “sconfitti” , dando voce a coloro che furono travolti dall’avanzata della nuova fede.
In questa ambiziosa operazione, Nixey si posiziona come l’erede moderna di una tradizione storiografica che risale a Edward Gibbon, il quale, nella sua monumentale Storia del declino e della caduta dell’Impero romano, individuò nel cristianesimo una delle cause principali della dissoluzione della civiltà classica e dell’avvento di un’età di “barbarie e religione”. Tuttavia, come questa analisi si propone di dimostrare, sebbene il libro di Nixey abbia l’innegabile merito di portare all’attenzione di un vasto pubblico episodi di violenza e intolleranza cristiana spesso trascurati dalla storiografia popolare, la sua metodologia selettiva, le sue significative omissioni contestuali e il suo tono irriducibilmente manicheo lo qualificano più come un’opera ideologica che storiografica. Si tratta di un manifesto che, pur basandosi su fonti storiche, sacrifica la complessità e la sfumatura sull’altare di una tesi precostituita.
Il nucleo della critica a questo volume risiede in un paradosso fondamentale: nel denunciare la natura agiografica e trionfalistica della storiografia cristiana tradizionale, Nixey finisce per costruire un mito speculare, una contro-agiografia per un’epoca secolare. Il mondo classico viene idealizzato come un’età dell’oro di ragione, bellezza e tolleranza, mentre il cristianesimo è dipinto come una forza monolitica, ignorante e intrinsecamente distruttiva. Figure come Ipazia, Damascio e Libanio diventano i nuovi martiri della ragione, immolati sull’altare del fanatismo. Invece di decostruire il genere della storia trionfalistica, Nixey ne adotta la struttura narrativa, limitandosi a invertire i ruoli dei protagonisti e degli antagonisti. Questo approccio, evidente fin dal prologo con la drammatica decapitazione della statua di Atena, non costituisce un’analisi storica profonda, ma la creazione di una contro-leggenda, tanto avvincente quanto problematica.
La costruzione della narrazione: stile, tesi e fonti
La retorica del conflitto: un mondo in bianco e nero
Lo stile di Catherine Nixey è senza dubbio uno dei punti di forza del libro e una delle ragioni principali del suo successo. Da giornalista esperta, sa come catturare l’attenzione del lettore e suscitare una forte risposta emotiva. Le sue descrizioni sono vivide, la sua prosa è energica e le sue narrazioni sono costruite con un’abilità quasi cinematografica. Tuttavia, questa stessa abilità retorica è al servizio di una tesi che si fonda su una dicotomia netta e storicamente insostenibile.
Fin dalle prime pagine, Nixey dipinge un mondo diviso in due campi contrapposti. Da un lato, c’è il mondo classico, un regno di luce, ragione e bellezza. La statua di Atena a Palmira non è solo un pezzo di marmo, ma un simbolo della “sofisticatezza di un impero”, della “perizia” artistica e di una “bellezza” quasi ultraterrena. I filosofi di Atene, costretti all’esilio, non sono semplici accademici, ma gli ultimi eredi di una “catena aurea” che risale a Platone, portatori di una saggezza che il nuovo mondo non può più tollerare. La tolleranza di questo mondo perduto è incarnata dalla celebre frase di Simmaco, che Nixey pone a esergo della sua introduzione: “Cosa importa quale dottrina una persona sceglie per cercare la verità?”.
Dall’altro lato, si erge un cristianesimo oscuro e minaccioso. I suoi seguaci sono “fanatici barbuti vestiti di nero”, dediti ad attacchi “primitivi, teppistici e molto efficaci”. La loro violenza è “brutale, priva di qualunque rispetto”; essi “scoppiavano a ridere mentre spaccavano quelle statue ‘idolatre’ e ‘malvagie'”. Il loro Dio non è il Dio dell’amore, ma un “crudele tiranno” che esige sottomissione assoluta e giustifica ogni atrocità. Questa rappresentazione, sebbene potente, semplifica radicalmente la realtà storica, riducendo secoli di complesse trasformazioni sociali, politiche e religiose a una battaglia tra “buoni” (i pagani colti e tolleranti) e “cattivi” (i cristiani fanatici e ignoranti). Come hanno notato numerosi recensori accademici, questo approccio manicheo, pur essendo narrativamente efficace, ignora la complessità e le sfumature indispensabili per una corretta comprensione storica.
Le voci degli sconfitti e i silenzi dei vincitori: un uso selettivo delle fonti
A sostegno della sua tesi, Nixey dispiega un apparato di fonti che, a prima vista, appare solido e variegato. La bibliografia elenca un’ampia gamma di testi primari e secondari, dimostrando una conoscenza approfondita della materia. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela un uso strategico e selettivo di queste fonti, funzionale a rafforzare la sua tesi polemica piuttosto che a esplorare la complessità del periodo storico in esame.
L’autrice privilegia sistematicamente le voci di un ristretto canone di autori “pagani” del IV e V secolo, come l’oratore Libanio, lo storico Eunapio di Sardi e il polemista Zosimo. Le loro opere, intrise di un profondo risentimento verso l’ascesa del cristianesimo, forniscono a Nixey un ricco repertorio di aneddoti sulla violenza dei monaci, sulla distruzione dei templi e sulla corruzione percepita dei nuovi governanti cristiani. Sebbene queste fonti siano preziose per comprendere la prospettiva dell’élite pagana sconfitta, Nixey le presenta spesso in modo acritico, senza contestualizzare a sufficienza la loro natura intrinsecamente polemica e le loro specifiche agende politiche e personali. Le loro invettive vengono elevate a testimonianze oggettive della realtà, mentre le loro idealizzazioni del passato vengono accettate senza riserve.
Al contrario, le fonti cristiane, pur essendo citate abbondantemente, vengono utilizzate in modo strumentale. Figure complesse come Agostino, Girolamo o Giovanni Crisostomo sono ridotte a meri fornitori di citazioni a effetto che sembrano confermare la tesi di un cristianesimo monolitico e violento. Frasi come la “crudeltà misericordiosa” di Agostino o il suo appello a cancellare “ogni superstizione dei pagani” vengono estrapolate dal loro specifico contesto teologico e storico — spesso legato a lotte intestine al cristianesimo, come quella contro i donatisti — e presentate come la prova definitiva di un’essenza violenta e totalitaria della nuova fede.
In questo modo, emerge un paradosso fondamentale nell’approccio di Nixey. L’autrice sostiene di voler svelare una storia “quasi interamente” oscurata e dimenticata. Eppure, la stragrande maggioranza delle sue prove più eclatanti sulla distruzione di templi e statue proviene proprio da fonti cristiane. Autori come Eusebio di Cesarea, Rufino di Aquileia o i biografi di santi come Martino di Tours e Benedetto da Norcia non nascosero affatto questi atti di violenza; al contrario, li celebrarono come gloriose vittorie contro le forze demoniache e come prova della potenza del loro Dio. La vera questione storiografica, dunque, non è se queste distruzioni siano avvenute — le fonti cristiane lo confermano ampiamente — ma come interpretarle. Nixey presenta come una rivelazione scioccante ciò che per gli stessi autori cristiani era motivo di vanto e di edificazione spirituale. La sua “scoperta” non riguarda tanto fatti nuovi, quanto l’applicazione di una sensibilità e di un giudizio morale moderni a eventi del passato, interpretando come vandalismo ciò che per i protagonisti era un atto di purificazione religiosa. Il suo lavoro non svela tanto una storia nascosta, quanto una storia già nota, ma riletta attraverso una lente ideologica contemporanea.
Decostruzione degli episodi paradigmatici
Per sostenere la sua tesi di una distruzione sistematica, Nixey costruisce la sua narrazione attorno a una serie di episodi paradigmatici, presentati come momenti emblematici del conflitto tra la cultura classica e il cristianesimo. L’analisi di tre di questi episodi chiave — la distruzione del Serapeo, l’assassinio di Ipazia e la chiusura dell’Accademia di Atene — rivela come l’autrice tenda a privilegiare la versione più drammatica e simbolica degli eventi, spesso a scapito dell’accuratezza storiografica e della complessità contestuale.
La distruzione dei templi: il caso del Serapeo e il mito della Biblioteca di Alessandria
La narrazione della distruzione del Serapeo di Alessandria nel 392 occupa un posto centrale nel libro di Nixey. Descritto come “il più splendido edificio del mondo intero al di fuori di Roma”, il tempio viene presentato come il culmine della magnificenza architettonica e culturale classica. La sua demolizione per mano di una folla di cristiani fanatici, guidati dal vescovo Teofilo, è descritta con toni apocalittici, un atto di barbarie che segna la fine di un’era.
Le fonti storiche confermano la sostanza dell’evento: il Serapeo fu effettivamente distrutto da cristiani in un clima di crescente tensione religiosa, un episodio che sconvolse profondamente i contemporanei non cristiani. Tuttavia, la critica storiografica deve concentrarsi su un dettaglio fondamentale, che Nixey eleva a simbolo della catastrofe: l’affermazione secondo cui con il tempio furono distrutti “i resti della più grande biblioteca del mondo intero”. Questa affermazione, sebbene potente, è storicamente problematica. Il dibattito accademico sulla fine della Biblioteca di Alessandria è complesso e tutt’altro che risolto. Le prove suggeriscono che:
- La grande Biblioteca del Museo, la principale istituzione libraria, era probabilmente già scomparsa o in uno stato di grave declino secoli prima, a seguito di una serie di eventi tra cui l’incendio accidentale durante la campagna di Giulio Cesare nel 48 a.C. e, più probabilmente, la distruzione del quartiere del Bruchion durante l’attacco dell’imperatore Aureliano nel 273 d.C..
- La biblioteca ospitata all’interno del Serapeo era una collezione “figlia”, importante ma di dimensioni e prestigio inferiori rispetto a quella originaria del Museo.
- Non vi è alcuna certezza sull’effettiva consistenza del patrimonio librario presente nel Serapeo al momento della sua distruzione nel 392. Alcuni storici ritengono che potesse essere già stata danneggiata o impoverita.
Nixey, ignorando queste complessità, sceglie deliberatamente la versione più catastrofica e simbolicamente carica. La distruzione del Serapeo non è più solo un atto di violenza religiosa contro un tempio, ma diventa l’annientamento definitivo del più grande centro del sapere del mondo antico. Questo approccio, che non è possibile non definire “sensazionalistico”, trasforma un evento storico in un mito potente, funzionale alla sua tesi di un’età oscurata dal fanatismo.
L’assassinio di Ipazia: martire della scienza o pedina della politica?
L’omicidio della filosofa Ipazia ad Alessandria nel 415 è un altro pilastro della narrazione di Nixey, che le dedica un intero capitolo carico di pathos. La sua rappresentazione di Ipazia come una martire della scienza e della ragione, brutalmente assassinata da una folla di cristiani ignoranti e fanatici perché “pagana”, ricalca una tradizione romantica e illuminista che ha trasformato la sua figura in un simbolo della lotta tra libero pensiero e oscurantismo religioso.
Anche in questo caso, l’analisi delle fonti primarie — principalmente lo storico ecclesiastico Socrate Scolastico, il filosofo pagano Damascio e il vescovo cristiano Giovanni di Nikiu — offre un quadro molto più complesso. Sebbene non vi sia dubbio che Ipazia fu uccisa da una folla di cristiani (i parabolani), le fonti più attendibili indicano che il movente principale non fu di natura puramente religiosa o filosofica, ma squisitamente politica. L’assassinio si inserisce nel violento conflitto per il controllo della città di Alessandria tra il prefetto imperiale Oreste, un cristiano moderato che faceva parte della cerchia di Ipazia, e il potente e ambizioso patriarca Cirillo. Socrate Scolastico afferma esplicitamente che Ipazia “cadde vittima della gelosia politica” perché i suoi frequenti incontri con Oreste alimentarono la calunnia che fosse lei a impedirne la riconciliazione con il vescovo. Fu percepita non tanto come un’eretica, ma come l’eminenza grigia del potere rivale, un ostacolo politico all’egemonia di Cirillo sulla città.
La narrazione di Nixey, che la descrive semplicemente come “quella donna pagana” assalita da “credenti in Dio”, semplifica questo complesso scontro di potere urbano, riducendolo a una prevedibile contrapposizione ideologica. Ignora che lo stesso Oreste era cristiano e che nella cerchia di Ipazia c’erano numerosi studenti cristiani, come il futuro vescovo Sinesio di Cirene. Presentare Ipazia come una martire della scienza contro la fede è una forzatura anacronistica che oscura la vera natura del conflitto, radicato nelle dinamiche di potere della Tarda Antichità.
La chiusura dell’Accademia di Atene: la fine della filosofia?
L’atto finale del dramma narrato da Nixey è la chiusura dell’Accademia di Atene nel 529 per ordine dell’imperatore Giustiniano. L’evento è presentato come il colpo di grazia alla filosofia occidentale, la simbolica estinzione della luce della ragione greca. L’immagine dei sette filosofi, guidati da Damascio, che abbandonano Atene portando con sé solo i loro libri, è potente e commovente.
Ancora una volta, però, la realtà storica è più sfumata. La storiografia moderna ha messo in discussione questa lettura catastrofista, evidenziando diversi fattori:
- Lo stato dell’Accademia: Nel VI secolo, l’Accademia di Atene non era più il centro vibrante di ricerca scientifica e filosofica dei tempi di Platone e dei suoi immediati successori. Si era trasformata in una scuola neoplatonica con un forte orientamento mistico e teurgico, dedita a pratiche che oggi definiremmo magiche, un’evoluzione che lo stesso Platone avrebbe forse trovato problematica.
- La natura del decreto: Il decreto di Giustiniano del 529 non menzionava esplicitamente l’Accademia. Si trattava di una legge più generale che proibiva ai “pagani” di insegnare e di ricevere stipendi pubblici, parte di una più ampia politica di uniformazione religiosa dell’impero. Il suo impatto fu certamente devastante per la scuola, ma non si trattò di un atto mirato a “uccidere la filosofia”.
- La continuità della tradizione filosofica: La filosofia greca non si estinse nel 529. La sua tradizione fu portata avanti, sebbene in forme diverse, nelle scuole di Alessandria e, soprattutto, a Costantinopoli, dove rimase una componente fondamentale della cultura bizantina. Il neoplatonismo fu lo sfondo filosofico su cui si mossero molti Padri della Chiesa e di fatto il pensiero greco ebbe un’influenza enorme su quello cristiano sia nel periodo antico che in quello medievale.
Nixey utilizza l’evento come un potente simbolo di chiusura, la scena finale perfetta per il suo racconto di distruzione. Tuttavia, nel farlo, ne esagera l’impatto definitivo, ignorando le complesse vie della continuità culturale e presentando una cesura netta laddove ci fu una trasformazione graduale e una trasmissione tortuosa ma ininterrotta del sapere.
La critica più profonda che si possa muovere a Nel nome della croce non riguarda tanto ciò che racconta, quanto ciò che omette. Presentando il fanatismo cristiano come l’unica causa della “distruzione del mondo classico”, Nixey ignora quasi completamente il vasto contesto storico che rese possibile tale trasformazione. Questa omissione non è casuale, ma metodologicamente necessaria per sostenere la sua tesi polemica.
Prima dei cristiani: la crisi del III secolo e le cause endogene del declino
Il mondo in cui il cristianesimo salì al potere non era l’Impero romano stabile e prospero degli Antonini. Era un impero che era appena sopravvissuto a una crisi sistemica di proporzioni epocali, la cosiddetta “crisi del III secolo” (circa 235-284). Nixey menziona brevemente questo periodo come “un’epoca di ansia”, ma ne minimizza la portata e le conseguenze strutturali, che invece sono fondamentali per comprendere la Tarda Antichità. I fattori chiave di questa crisi includono:
- Anarchia militare e instabilità politica: Per cinquant’anni, l’impero fu dilaniato da continue guerre civili. Decine di imperatori e usurpatori, acclamati dalle legioni, si succedettero sul trono, portando al collasso dell’autorità centrale e alla definitiva emarginazione del Senato come organo politico.
- Pressione sui confini e spese militari: L’impero dovette fronteggiare una pressione militare senza precedenti su due fronti: a est contro il potente Impero Sasanide e a nord lungo il Reno e il Danubio contro le incursioni delle tribù germaniche. Ciò richiese un esercito sempre più grande, costoso e barbarizzato, che prosciugò le risorse dello Stato.
- Crisi economica e sociale: Le guerre costanti portarono a un aumento vertiginoso della tassazione, a una svalutazione monetaria catastrofica (inflazione) e al crollo dei commerci a lunga distanza. Le campagne si spopolarono, la produzione agricola diminuì e le città si contrassero. Pestilenze ricorrenti decimarono ulteriormente la popolazione.
Le riforme di imperatori come Diocleziano e Costantino non furono il capriccio di despoti, ma una risposta disperata a questa crisi sistemica. L’istituzione della Tetrarchia, la creazione di una burocrazia centralizzata e pervasiva, l’imposizione di una tassazione rigida (capitatio-iugatio) e il vincolo ereditario delle professioni furono tentativi di salvare uno stato sull’orlo del collasso. Lo stato tardoantico divenne più autoritario, gerarchico e coercitivo ben prima che il cristianesimo ne diventasse l’ideologia ufficiale. Il cristianesimo non creò dal nulla uno stato intollerante; piuttosto, si inserì e alla fine catturò le strutture di uno stato che, per ragioni di sopravvivenza, stava già diventando profondamente illiberale. L’omissione di questo contesto è la più grave lacuna storiografica di Nixey, poiché le permette di attribuire al solo fanatismo religioso cambiamenti che avevano radici strutturali, economiche e politiche ben più profonde.
La pluralità dei mondi: il “paganesimo” e il cristianesimo come realtà non monolitiche
Un’altra significativa semplificazione operata da Nixey è la rappresentazione del “paganesimo” e del “cristianesimo” come due blocchi monolitici e contrapposti. La realtà storica era infinitamente più complessa e frammentata.
Il termine “paganesimo”, un’invenzione cristiana peggiorativa, maschera un’enorme diversità di credenze e pratiche. Nella Tarda Antichità, accanto ai culti pubblici ufficiali di Roma, prosperavano i culti domestici, le filosofie a carattere religioso (neoplatonismo, stoicismo) e, soprattutto, i culti misterici di origine orientale come quelli di Iside, Mitra, Cibele e Sol Invictus, che offrivano promesse di salvezza individuale e una spiritualità più intensa. Molte di queste correnti mostravano una forte tendenza al sincretismo e all’enoteismo (la venerazione di un dio supremo senza negare l’esistenza degli altri), preparando di fatto il terreno culturale all’accettazione del monoteismo cristiano. La “tolleranza” romana, inoltre, non era un principio ideologico astratto, ma una pratica pragmatica: i culti venivano tollerati finché non erano percepiti come una minaccia all’ordine pubblico o politico (mos maiorum), nel qual caso venivano repressi come superstitio illicita.
Allo stesso modo, il “cristianesimo” del IV e V secolo era tutt’altro che un fronte unito. Mentre Nixey si concentra quasi esclusivamente sul conflitto tra cristiani e pagani, la realtà storica di quel periodo è dominata da violente lotte intestine tra diverse fazioni cristiane. I dibattiti sulla natura di Cristo diedero origine a controversie feroci come quella ariana, che divise l’impero per decenni. Conflitti come quello tra cattolici e donatisti in Nord Africa o le dispute cristologiche che portarono ai concili di Efeso e Calcedonia, furono combattuti con una violenza teologica e fisica almeno pari, se non superiore, a quella rivolta contro i pagani. Ignorare questa dimensione significa dipingere un quadro falso di un blocco cristiano omogeneo e compatto, unito nel suo assalto al mondo classico, quando in realtà era profondamente diviso e impegnato in una lotta mortale per definire la propria ortodossia.
La conservazione ambigua: i palinsesti e il paradosso dei monasteri
Nixey affronta la questione della conservazione dei testi classici, riconoscendo che la narrazione della Chiesa come salvatrice della cultura è una “verità parziale” che oscura una precedente storia di distruzione. Evidenzia correttamente episodi reali di distruzione: i roghi di libri “magici” o “eretici”, la semplice negligenza verso opere considerate inutili, e soprattutto la pratica dei palinsesti, in cui manoscritti classici venivano raschiati per far spazio a testi cristiani.
Tuttavia, la sua narrazione si concentra quasi esclusivamente sull’aspetto distruttivo, minimizzando il paradosso fondamentale che la quasi totalità della letteratura latina e greca che oggi possediamo è sopravvissuta proprio grazie al lavoro degli amanuensi cristiani nei monasteri medievali. La vera chiave di lettura per comprendere questo processo non è la dicotomia semplicistica tra “distruzione” e “conservazione”, ma il concetto di selezione culturale.
Il cristianesimo non distrusse né preservò indiscriminatamente. Agì come un potente filtro ideologico. Come teorizzato da influenti Padri della Chiesa come Basilio di Cesarea nel suo Discorso ai giovani, la cultura classica doveva essere vagliata: bisognava prendere “ciò che è utile”, come le api prendono il nettare dai fiori, ed evitare “ciò che è nocivo”. Questo programma di filtraggio spiega perché certe opere sono sopravvissute e altre no. Ciò che era considerato compatibile con la morale cristiana o che poteva essere allegorizzato in chiave cristiana — come le opere di Virgilio o di Platone — fu conservato, studiato e assimilato. Ciò che era percepito come irriducibilmente “pagano”, materialista (come l’atomismo di Lucrezio e Democrito) o sessualmente esplicito (come le opere di Ovidio o Catullo) fu censurato, trascurato o attivamente soppresso. La perdita di una parte cosistente della letteratura latina non fu quindi un incidente casuale, ma il risultato di un preciso e secolare programma di selezione culturale. La Chiesa non fu né una semplice distruttrice né una semplice conservatrice; fu l’arbitro che decise quale parte del mondo classico meritava di essere trasmessa ai posteri.
Un’età oscurata dalla polemica
In definitiva, Nel nome della croce di Catherine Nixey si rivela un’opera tanto affascinante nella forma quanto problematica nella sostanza. È un libro importante non tanto per la sua validità storiografica, quanto per il dibattito che ha saputo generare, costringendo lettori e studiosi a confrontarsi nuovamente con un periodo fondamentale e spesso idealizzato della storia occidentale. La sua forza risiede nella capacità di dare voce al trauma e al senso di perdita di coloro che videro il loro mondo culturale e religioso sgretolarsi sotto i colpi di una nuova fede, un aspetto della cristianizzazione che la narrazione trionfalistica ha a lungo messo in ombra.
Tuttavia, la sua debolezza risiede nella sua stessa natura polemica. Costruito su una narrazione manichea, un uso selettivo delle fonti e significative omissioni contestuali, il libro di Nixey semplifica un processo storico di una complessità vertiginosa, riducendolo a un unico, onnicomprensivo fattore causale: il fanatismo religioso. Il suo carattere si dimostra più ideologico che storiografico. Il suo più grande difetto non è tanto quello di raccontare delle falsità — gli episodi di violenza che descrive sono, in larga parte, storicamente accertati — quanto quello di raccontare una verità parziale in un modo così totalizzante da renderla, in ultima analisi, una distorsione.
Il libro risponde a una sete contemporanea di critica radicale alla religione organizzata, ma lo fa utilizzando il passato come un’arma in un dibattito moderno, proiettando sulle complesse dinamiche della Tarda Antichità le preoccupazioni e le categorie del XXI secolo. La Tarda Antichità non fu un’età di tenebra improvvisa, né un trionfo luminoso. Fu un crepuscolo lungo e complesso, un’epoca di profonde crisi e di straordinarie trasformazioni, in cui distruzione e creazione, continuità e rottura si intrecciarono in modi spesso inestricabili. La sua comprensione richiede più sfumature, più dubbi e meno certezze di quante la penna, pur brillante e appassionata, di Catherine Nixey sia disposta a concedere.

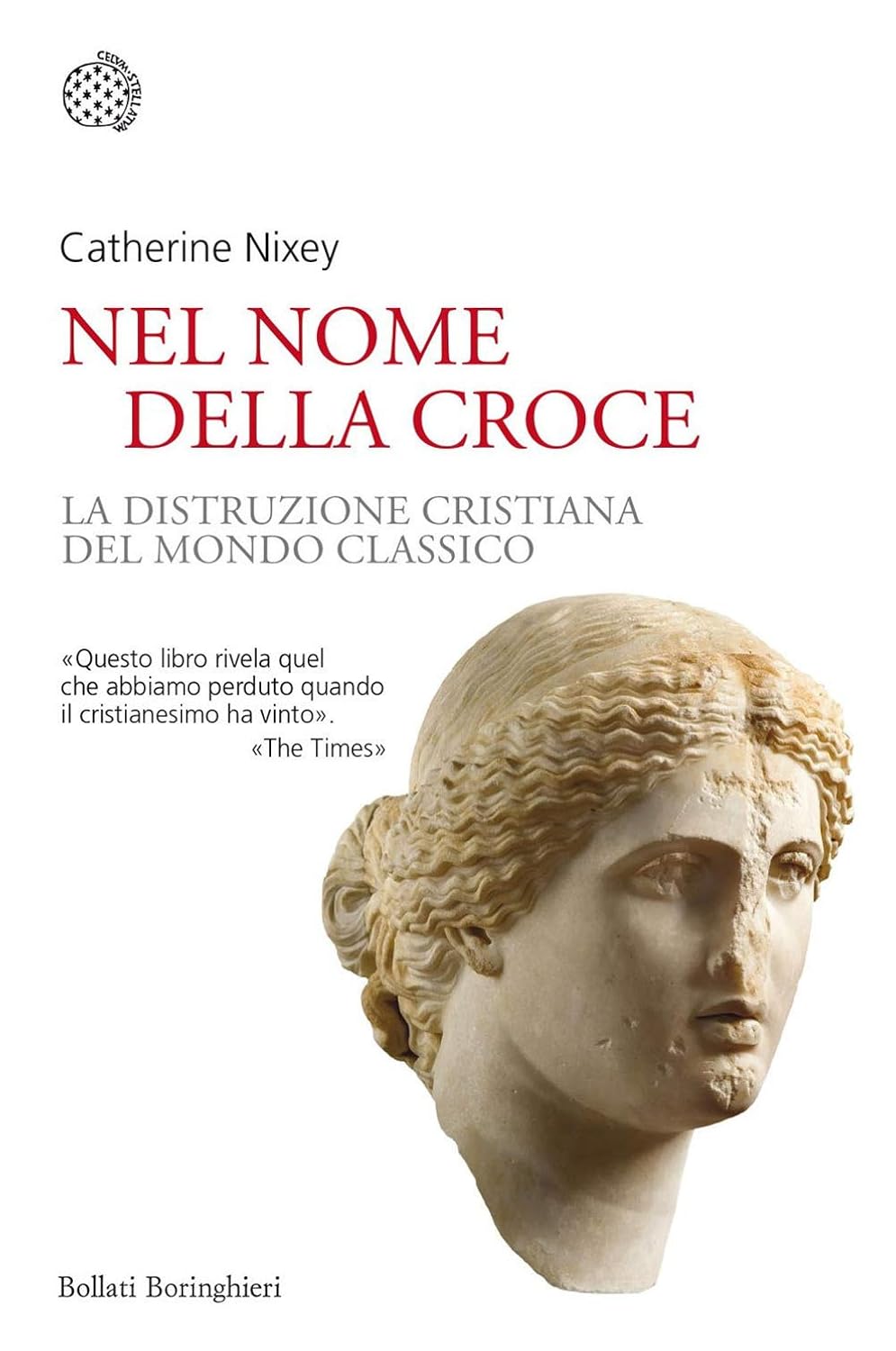
Una recensione tutta da studiare. Grazie.
Ottima recensione
Recensione figlia di solida dottrina storica e storiografica. Merita attenzione e riflessione come lo merita il periodo storico considerato.
Recensione veramente interessante, che fa venir voglia di approfondire questo periodo storico così complesso. La lettura della vicenda di Ipazia trova sostegno nel bel libro della Ronchey.
Grazie mille
Grazie! Condivido in pieno. L’autrice è sulla linea del film di Amenabar, Agorà (2009).
Molto, molto interessante! Grazie
Mille grazie per questa recensione, che in realtà è un piccolo saggio sulla questione affrontata. 👏🏻
Fatta salva (ci mancherebbe!) la tua competenza anche la tua mi pare molto una difesa d’ufficio. Il cristianesimo delle origini rivelò ben presto, anche al suo interno, una determinazione profonda a recidere ogni opinione e pratica alternativa non solo religiosa. L’idea chiarissima, viva tutt’oggi, era quella della città di Dio da sovrapporre allora e per sempre alle città dell’uomo.
Ti sfugge che nel testo da nessuna parte si nega che l’istituzionalizzazione del cristianesimo comportò anche una repressione del paganesimo (era fisiologico in un contesto culturale che non concepiva una distinzione tra sfera civile e sfera religiosa, idea che giungerà a maturazione solo nel XVI secolo con la Scuola di Salamanca). Si mettono solo i puntini sulle “i” relativamente al modo ideologico che l’autrice ha di proporre i fatti, selezionando accuratamente solo quelli che corroborano la sua tesi e spesso ponendoli in una luce che ne accentua determinate caratteristiche.
Scrivendo nel sottotitolo “La figlia di Gibbon” Virgilio ha detto tutto e, specificando lo stile giornalistico ha completato il quadro. Consiglierei personalmente a chi ha intenzione di leggere questo libro di leggersi qualcosa di più interessante circa la storia di Roma almeno partendo dal primo o secondo secolo a.C. fino al quinto sesto secolo d.C. . Intendo un serio o dei seri libri di storia che portino a dei rimandi e approfondimenti.
Una recessione molto interessante che permette di avere una chiave di lettura un libro che fa comunque discutere. Gli esperti di cultura classica e cristiana, sono altri, come Bardy ( Il Cristianesimo dei primi secoli), come Marrou (Decadenza romana o tardi antichità?).
Ogni fonte storica, nel momento in cui è analizzata e spiegata, perde la sua oggettività. L’ unico modo per minimizzare questo problema, è considerare quanti più dati ed ipotesi possibili, anche perché è da decenni che sono state abbandonate le spiegazioni monocausali e le analisi evemenziali. Questo è ciò che fa’ uno storico, se ciò non accade, si sta semplicemente scrivendo un romanzo storico che può solo accrescere confusione in chi non ha una conoscenza approfondita del periodo considerato.
concordo con Virgili, per quel che conosco, non solo con il metodo, ma pure con i richiami testuali e documentali . Nixei mi ricorda come approccio il romanzo ‘storico’ di Gore Vidal “Giuliano” dedicato a magnificare la figura dell’ultimo imperatore “pagano”, passato alla storia come l’Apostata. Ivi si sostiene la tesi che la lancia che lo uccise in battaglia fosse, “romana”, quindi “cristiana”, un assasinio politico-religioso che scontava la morte di un imperatore valoroso impegnato in una lotta contro il nemico esterno pur di eliminare un nemico del cristianesimo.
In realtà la politica religiosa di Giuliano sottraemdo ai vescovi ariani l’appoggio che avevano ricevuto da Costanzo, (il figlio di Costantino che prevalse con la forza sui fratelli) ridiede forza ai cristiani ‘niceni’.