In un panorama intellettuale spesso dominato da un riduzionismo scientista che sembra aver relegato la metafisica classica a un mero reperto archeologico del pensiero, l’opera di Robert C. Koons, “Is St. Thomas’s Aristotelian Philosophy of Nature Obsolete?”, emerge con la forza di un vero e proprio manifesto filosofico. Questo volume, pubblicato da St. Augustine’s Press nel 2022, non è semplicemente una difesa nostalgica di un sistema di pensiero superato; è un’argomentazione audace, rigorosa e straordinariamente aggiornata che si propone di dimostrare non solo la pertinenza, ma la necessità di una filosofia della natura neo-aristotelica per comprendere le scoperte più profonde della scienza contemporanea, in particolare della meccanica quantistica. L’opera di Koons è un contributo monumentale, destinato a diventare un punto di riferimento imprescindibile per chiunque desideri esplorare il dialogo tra scienza, filosofia e teologia nel ventunesimo secolo. La sua tesi centrale è tanto sorprendente quanto potentemente argomentata: la rivoluzione quantistica, lungi dall’aver inferto il colpo di grazia alla filosofia aristotelico-tomista, ne rappresenta, di fatto, una straordinaria e inattesa rivincita.
Il problema e la posta in gioco: superare il quietismo e il dualismo
Koons apre la sua trattazione delineando con eccezionale chiarezza la posta in gioco. La questione posta del titolo non è un mero esercizio accademico. Dalla sua risposta dipendono la coerenza di un’antropologia non dualista, la possibilità di una teologia sacramentale robusta e la fondazione di un’etica basata su norme oggettive. L’autore identifica e critica aspramente due strategie evasive comuni tra i pensatori contemporanei, anche di matrice tomista. La prima è quella che egli definisce “quietismo aristotelico”, la posizione, resa celebre da Jacques Maritain, che traccia una distinzione invalicabile tra la filosofia della natura e le scienze “empiriologiche”. Secondo questa visione, la filosofia della natura si muoverebbe su un piano di astrazione tale da renderla immune alle scoperte scientifiche, giustificata unicamente dall’esperienza comune. Koons smantella questa posizione con acume, sostenendo che essa rende la filosofia naturale non falsificabile e, quindi, dogmatica. La filosofia naturale aristotelica è intrinsecamente empirica e non può rinunciare al dialogo e alla verifica con l’indagine scientifica dettagliata, pena la sua trasformazione in un apriorismo sterile. Koons insiste sul fatto che l’accettazione di questa sfida comporta un rischio: la filosofia aristotelica diventa, in linea di principio, “falsificabile, o almeno soggetta a smentita, dai risultati empirici”. Ma questo, egli sostiene, “è un vantaggio, piuttosto che uno svantaggio, poiché fornisce un antidoto alla tentazione dell’apriorismo in filosofia”. Se la filosofia naturale si ritira in una torre d’avorio, diventa irrilevante. Come potrebbe, si chiede Koons, una forma generica come “inorganico”, proposta da pensatori come Charles De Koninck, spiegare la natura specifica e le interazioni di rocce, plasma e buchi neri, se questa categoria è definita solo negativamente come “assenza di vita”?
La seconda strategia, spesso una conseguenza della prima, è l’abbandono dell’ilemorfismo, la dottrina centrale di Aristotele sulla composizione di materia (gr. hyle) e forma (morphe). Le conseguenze di tale abbandono, secondo Koons, sono “devastanti”. Senza l’ilemorfismo, la dottrina della transustanziazione diventa quasi incomprensibile: se il pane non è una sostanza con una sua forma essenziale, ma un mero “conglomerato di particelle elementari” accidentalmente disposte, allora la consacrazione dovrebbe trasformare le particelle stesse. Poiché tali particelle sono estremamente stabili, il sacramento diventerebbe praticamente irreversibile e le apparenze sensibili (colore, sapore) non sarebbero proprietà reali sostenute miracolosamente, ma mere illusioni, poiché le particelle elementari non possiedono tali qualità accidentali. Similmente, e con ancora maggiore urgenza, senza l’ilemorfismo la relazione tra anima e corpo precipita inevitabilmente nel dualismo cartesiano. Se il corpo è solo un aggregato di particelle, l’anima non può essere la sua “causa formale”. La sua relazione con il corpo deve essere puramente di causalità efficiente, come un motore che muove le particelle. In questo scenario, “il corpo è estrinseco all’anima, e quindi l’essere umano consiste interamente nella sola anima, con il corpo come un corredo accidentale”. Abbandonare l’ilemorfismo significa “cadere nel dualismo cartesiano e nell’angelismo”.
La conclusione di Koons è inequivocabile: “se vogliamo un’antropologia non-dualista e una spiegazione cattolica dell’Eucaristia, abbiamo bisogno di una filosofia della natura aristotelica”. Per salvare l’ilemorfismo, però, bisogna dimostrare che esso non è solo compatibile con la scienza moderna, ma che è addirittura la migliore cornice metafisica per interpretarla. Questa è la sfida monumentale che l’autore raccoglie e vince nel corso del volume.
L’arco storico: dalla caduta alla rinascita del fisicalismo
Il primo capitolo del libro traccia un affresco storico avvincente, descrivendo l’ascesa e la caduta del “fisicalismo”. Koons delinea prima i capisaldi del sistema aristotelico: un mondo strutturato su più livelli, con una causalità che opera sia dal basso verso l’alto (causa materiale, la spiegazione del tutto tramite le parti) sia dall’alto verso il basso (causa formale, la spiegazione delle parti tramite l’essenza del tutto). In questa visione, le sostanze (ousiai), specialmente gli organismi, possiedono poteri causali irriducibili e un’intrinseca teleologia, una finalità inscritta nella loro stessa natura. La capacità di agire umana, inclusa la razionalità, non è un’eccezione miracolosa, ma il compimento di una tendenza finalistica presente in tutta la natura.
Successivamente, Koons descrive la “rivoluzione anti-aristotelica” del diciassettesimo secolo, i cui semi, egli nota, furono gettati già nella tarda scolastica. Fu Duns Scoto, secondo l’analisi di Koons, a sostituire la concezione relazionale della materia di Aristotele (la materia come pura potenzialità) con una concezione “sostanziale”, in cui la materia in sé possiede una propria natura determinata. Questo aprì la strada ai filosofi moderni per concepire la materia come una sostanza uniforme la cui essenza era puramente quantitativa (estensione, massa). Il secondo passo fu la sostituzione del modello dei poteri causali con quello di leggi di moto astratte e universali, un cambiamento che fu oscurato dal fatto che la fisica stessa (con la gravità di Newton e l’elettromagnetismo di Maxwell) reintroduceva di fatto qualcosa di molto simile alle forme aristoteliche a livello microfisico (es. la forma dell’elettrone come negativamente carico). Infine, spinti dal pragmatismo di pensatori come Bacone e Descartes, che cercavano il controllo e il dominio sulla natura piuttosto che la comprensione profonda, si abbandonò la causalità formale e finale.
Il risultato fu un mondo fratturato e la nascita del dualismo moderno. Ma questo dualismo, che relegava la mente a una “anima delle lacune” per spiegare ciò che la scienza non poteva ancora spiegare, si rivelò instabile. Man mano che la scienza sembrava colmare queste lacune, la mente stessa divenne superflua, portando al trionfo del “micro-fisicalismo”, la tesi secondo cui tutta la realtà è esaurita e determinata dalle proprietà e relazioni delle particelle fondamentali.
È qui che la narrazione di Koons prende una piega inaspettata e brillante. Egli sostiene che la rivoluzione quantistica del ventesimo secolo ha “catastroficamente” infranto l’ambizione del fisicalismo. Citando Werner Heisenberg, che riconobbe come la teoria quantistica avesse riscoperto il concetto aristotelico di potentia (potenza), Koons afferma che il mondo quantistico è un mondo dove il potenziale è reale e necessario per spiegare l’attuale. Un esempio lampante è la tecnica della “somma sulle storie” di Feynman, in cui le previsioni empiriche devono tenere conto della totalità dei percorsi potenziali di una particella. Con il ritorno della potenzialità, torna anche la teleologia, sotto forma dei principi di minima azione e della direzione intrinseca del tempo data dalla termodinamica. Fenomeni come la non-separabilità degli stati entangled, in cui lo stato di un sistema non è determinato dalle proprietà intrinseche delle sue parti individuali, dimostrano in modo incontrovertibile che “il tutto è letteralmente più della somma delle sue parti”, un anatema per il micro-fisicalismo ma un dato di fatto per l’ilemorfismo. La fisica classica, con il suo dualismo tra formulazione newtoniana (meccanicistica) e lagrangiana (olistica e teleologica), lasciava la questione metafisica irrisolta; la meccanica quantistica, secondo Koons, rende la visione lagrangiana e, quindi, aristotelica, obbligatoria.
Il cuore metafisico: ilemorfismo e sostanza nel mondo quantistico
Nel secondo capitolo, Koons getta le fondamenta metafisiche della sua proposta. Egli introduce il concetto di “escalation ontologica”, un’alternativa più precisa al termine abusato di “emergenza”. L’escalation ontologica descrive un mondo a più livelli in cui le entità di scala superiore sono parzialmente fondate su quelle di scala inferiore (causalità materiale), ma, allo stesso tempo, i poteri e le relazioni delle entità di scala inferiore sono parzialmente fondati e determinati dalle totalità di scala superiore di cui sono parti integrali (causalità formale). Questa mutua co-determinazione è il nucleo dell’ilemorfismo.
La domanda cruciale diventa allora: quali sono le sostanze del mondo, le entità fondamentali che “tassellano” la realtà senza sovrapposizioni né lacune (il “tiling constraint” di Schaffer )? Koons esamina diversi candidati e li scarta. Non possono essere gli artefatti, perché la loro unità è estrinseca, dipendente da un artefice umano e da fatti esterni. Non possono essere le particelle elementari, perché la meccanica quantistica stessa nega loro un’identità individuale persistente; esse perdono la loro individualità quando entrano in sistemi entangled, obbedendo a statistiche (Bose-Einstein, Fermi-Dirac) che le trattano come indistinguibili. Anzi, in alcuni contesti, persino il loro numero può dipendere dal sistema di riferimento dell’osservatore. Non può essere nemmeno il cosmo nella sua interezza, come vorrebbe il monismo di priorità di Jonathan Schaffer, perché questo renderebbe impossibile l’isolamento causale necessario per la conoscenza scientifica sperimentale e minaccerebbe l’agire umano (causalmente superfluo e illusorio).
Il candidato per eccellenza per il ruolo di sostanza è l’organismo vivente. Gli organismi possiedono poteri irriducibili (come la riproduzione e la sensazione), e le loro parti (come una mano o un occhio) sono definite dalla loro funzione nel tutto, in accordo con il “principio di omonimia” di Aristotele: una mano staccata dal corpo non è una vera mano, se non di nome. Per spiegare la composizione, Koons introduce la distinzione fondamentale tra parti integrali e parti virtuali. Le parti integrali, come gli organi, sono essenzialmente legate alla sostanza di cui sono parte. Le parti virtuali, come le molecole d’acqua nel corpo, hanno una natura intrinseca indipendente ma esistono solo potenzialmente all’interno della sostanza ospite, non come sostanze distinte. Questo, tuttavia, lascia aperto il problema del mondo inorganico. Se solo gli organismi sono sostanze, cosa sono le rocce, i laghi o i pianeti? Per risolvere questo enigma e soddisfare il “tiling constraint”, Koons introduce la sua proposta più originale e tecnicamente sofisticata: la teoria delle “sostanze termiche”.
La prova scientifica: termodinamica, chimica e il problema della misura
I capitoli dal terzo al quinto costituiscono il nucleo probatorio del libro, dove Koons si addentra nelle complessità della fisica moderna per dimostrare che la sua visione ilemorfica non solo è possibile, ma è la più esplicativa.
Il capitolo terzo è dedicato a derivare l’ilemorfismo dalla chimica e dalla termodinamica. L’argomento centrale è che la riduzione della termodinamica e della chimica alla fisica delle particelle fallisce. Il punto chiave, che Koons sviluppa con grande perizia tecnica, è il ruolo indispensabile del “limite termodinamico” o “limite del continuo” nei modelli fisici. Per spiegare rigorosamente fenomeni macroscopici reali, i fisici trattano i sistemi, che pure sono composti da un numero finito di molecole, come se ne avessero un numero infinito. Questa non è una mera comodità matematica, sostiene Koons, ma il riflesso di una realtà ontologica. Quando le molecole si fondono per formare una “sostanza termica”, esse creano un vero e proprio continuo aristotelico, un’entità con un numero infinito di gradi di libertà potenziali.
Questa “escalation ontologica” è l’unica via, secondo Koons, per spiegare in modo rigoroso almeno sei fenomeni fondamentali: l’irreversibilità del tempo, che richiede uno spettro continuo; definizioni rigorose di entropia e temperatura, che emergono solo a livello termodinamico; la bassa entropia dell’universo primordiale, una condizione macroscopica; la rottura spontanea di simmetria, che è impossibile in sistemi finiti; le transizioni di fase (solido, liquido, gas), che comportano discontinuità matematiche che appaiono solo nei modelli al limite del continuo; e la persistenza della forma chimica, specialmente la stabilità delle molecole chirali, che richiede l’interazione con un ambiente con infiniti gradi di libertà che induca regole di superselezione. Koons affronta e smonta le obiezioni, come l’anti-realismo (che nega la realtà delle transizioni di fase, una posizione che egli giudica assurda ) e l’idea che i modelli infiniti siano mere approssimazioni utili. Egli sottolinea che un modello finito non può approssimare adeguatamente un fenomeno (come una transizione di fase) che esso, per sua stessa struttura matematica (teorema di Stone-von Neumann ), esclude come impossibile.
Il capitolo quarto affronta il celebre “problema della misura”. La soluzione ilemorfica di Koons è elegante e potente. Gli osservatori e i loro strumenti non sono soltanto sistemi quantistici. Essi sono sostanze che possiedono proprietà “classiche” irriducibili (come la fase della materia, la temperatura) che non possono entrare in sovrapposizione. Usando il suo esempio, un “cubetto di ghiaccio di Schrödinger”, è impossibile per il cubetto trovarsi in uno stato sovrapposto di “congelato/sciolto”, perché la distinzione di fase è una proprietà formale della sostanza termica, non riducibile allo stato quantistico delle sue particelle. La misura è un’interazione tra un sistema quantistico e una proprietà non-quantica (classica) di una sostanza. Questo risolve il paradosso senza ricorrere a modifiche ad hoc della dinamica (come le teorie GRW ) o a ontologie bizzarre. Koons prosegue mostrando come le interpretazioni alternative (come la meccanica bohmiana) falliscano nel garantire l’affidabilità della nostra percezione, a causa della loro natura radicalmente non-locale che non assicura una correlazione stabile tra gli stati funzionali del nostro cervello e le posizioni delle particelle esterne.
Il capitolo quinto è una critica serrata dell’interpretazione dei Molti Mondi (MWI), specialmente nella versione funzionalista della “scuola di Oxford”. Koons, utilizzando una variante del paradosso di Putnam, dimostra che questo approccio porta a una radicale indeterminatezza del significato. Senza vincoli ontologici forti, qualsiasi permutazione degli oggetti quantistici realizzerebbe ugualmente bene la nostra teoria del mondo. La conseguenza è che ogni storia internamente coerente diventerebbe una realtà emergente altrettanto “vera” della nostra. Questo annulla la possibilità che le nostre teorie scientifiche siano sbagliate, e quindi annulla anche la possibilità che siano confermate empiricamente, minando alla base la fiducia nella meccanica quantistica stessa. Come alternativa, Koons abbozza l’interpretazione delle “forme viaggianti” (“traveling forms”) , in cui le essenze reali delle sostanze macroscopiche selezionano, istante per istante, quale dei tanti rami decoerenti della funzione d’onda è quello attuale, ripristinando un mondo unico e un’ontologia realista.
Dettagli metafisici e risoluzione di puzzle
Una dei punti di forza del libro di Koons è la volontà dell’autore di non fermarsi a un quadro generale, ma di scendere nei dettagli metafisici per dimostrare la robustezza del suo sistema. Il capitolo settimo è un esempio perfetto di questa profondità, affrontando la complessa relazione tra sostanze, accidenti e parti quantitative e risolvendo puzzle che hanno tormentato la filosofia per secoli. Koons riafferma il principio aristotelico fondamentale secondo cui nessuna sostanza è composta da altre sostanze e che le parti di una sostanza dipendono metafisicamente dal tutto.
Tuttavia, egli introduce una flessibilità cruciale per adattare il modello ai dati empirici. Riconosce che accidenti e parti possono persistere dopo la “morte” della sostanza a cui appartenevano. Un caso chiave è l’accidente di azione. L’azione di un arciere, egli sostiene seguendo Tommaso d’Aquino, continua ad esistere nel movimento della freccia anche dopo che l’arco è stato lasciato. Se l’arciere morisse, la sua azione (un suo accidente) persisterebbe. Questo si applica magnificamente alla fisica moderna: la luce che vediamo da una stella estinta è un’azione (un accidente) di una sostanza che non esiste più, che agisce su di noi ora.
Allo stesso modo, Koons argomenta che le parti quantitative di un organismo possono sopravvivere alla sua morte come “resti” (remnants). Questo spiega fenomeni moderni come la coltura di linee cellulari (come quelle di Henrietta Lacks) o i trapianti d’organo. Ancora più importante, introduce il concetto di “parti maverick” (maverick parts), parti che, pur appartenendo ancora al corpo, si sono parzialmente “separate” dal controllo della forma sostanziale dell’organismo, come le cellule tumorali. Queste parti maverick forniscono una soluzione elegante al problema della morte per cause interne. L’organismo nel suo complesso non può avere il potere attivo di distruggere se stesso (sarebbe contemporaneamente agente e paziente, vivo e morto), ma una sua parte maverick può agire come agente della morte dell’intero organismo. Questo, a sua volta, risolve il famoso puzzle medievale della “vacca marrone/carcassa marrone”: come si spiega la continuità qualitativa tra la vacca vivente e la sua carcassa se, secondo il tomismo, nulla di numericamente identico (eccetto la materia prima) persiste attraverso la morte? La risposta è che le parti maverick che causano la morte hanno il potere attivo di produrre una carcassa con le qualità appropriate, e la vacca ha il potere passivo di subire questo cambiamento. Non è necessaria alcuna identità numerica degli accidenti o delle parti. Questa sezione dimostra che l’ilemorfismo di Koons non è un rigido dogma, ma un sistema esplicativo dinamico e fecondo.
Conclusione: un’opera necessaria per il nostro tempo
“Is St. Thomas’s Aristotelian Philosophy of Nature Obsolete?” è un’opera di rara ambizione intellettuale e di impressionante profondità analitica. Robert Koons non si limita a difendere una posizione, ma costruisce un sistema. Attraverso un’analisi rigorosa che spazia dalla metafisica scolastica alle formulazioni algebriche della meccanica quantistica, egli dimostra che la visione del mondo aristotelico-tomista, centrata sui concetti di sostanza, forma, potenza e teleologia, non è un fossile del passato. Al contrario, essa offre la grammatica concettuale più adeguata per articolare le scoperte più controintuitive e profonde della fisica del secolo scorso.
Il libro è una potente confutazione del micro-fisicalismo e un invito a riconsiderare la natura della realtà come gerarchicamente strutturata, olistica e intrinsecamente finalistica. Koons ci mostra che la scienza moderna, quando interpretata con coraggio filosofico, non ci costringe a scegliere tra un mondo di particelle senza senso e un dualismo insostenibile. Esiste una terza via, quella dell’ilemorfismo, che restituisce integrità ontologica agli oggetti del mondo di mezzo – gli organismi, gli esseri umani, le sostanze chimiche – e fonda la possibilità di un’azione, una conoscenza e un valore auentici.
Quest’opera non è una lettura facile; richiede attenzione e la volontà di seguire l’autore in argomentazioni tecniche complesse. Tuttavia, la chiarezza espositiva di Koons e la struttura logica impeccabile del suo ragionamento rendono il percorso non solo fattibile, ma intellettualmente esaltante. Si tratta di un testo fondamentale, un capolavoro di filosofia sistematica che ha il potenziale di ridefinire i termini del dibattito per gli anni a venire. È, senza esagerazione, una delle opere di filosofia della scienza e di metafisica più importanti e stimolanti del nostro tempo, un libro che ogni filosofo, teologo e scienziato interessato alle questioni ultime dovrebbe leggere, meditare e con cui dovrebbe confrontarsi. Rappresenta la prova definitiva che, per rispondere alle domande più difficili della scienza, potremmo aver bisogno di recuperare la saggezza più profonda della nostra tradizione filosofica.
Per chi volesse acquistare il volume: https://amzn.to/4etG8jx

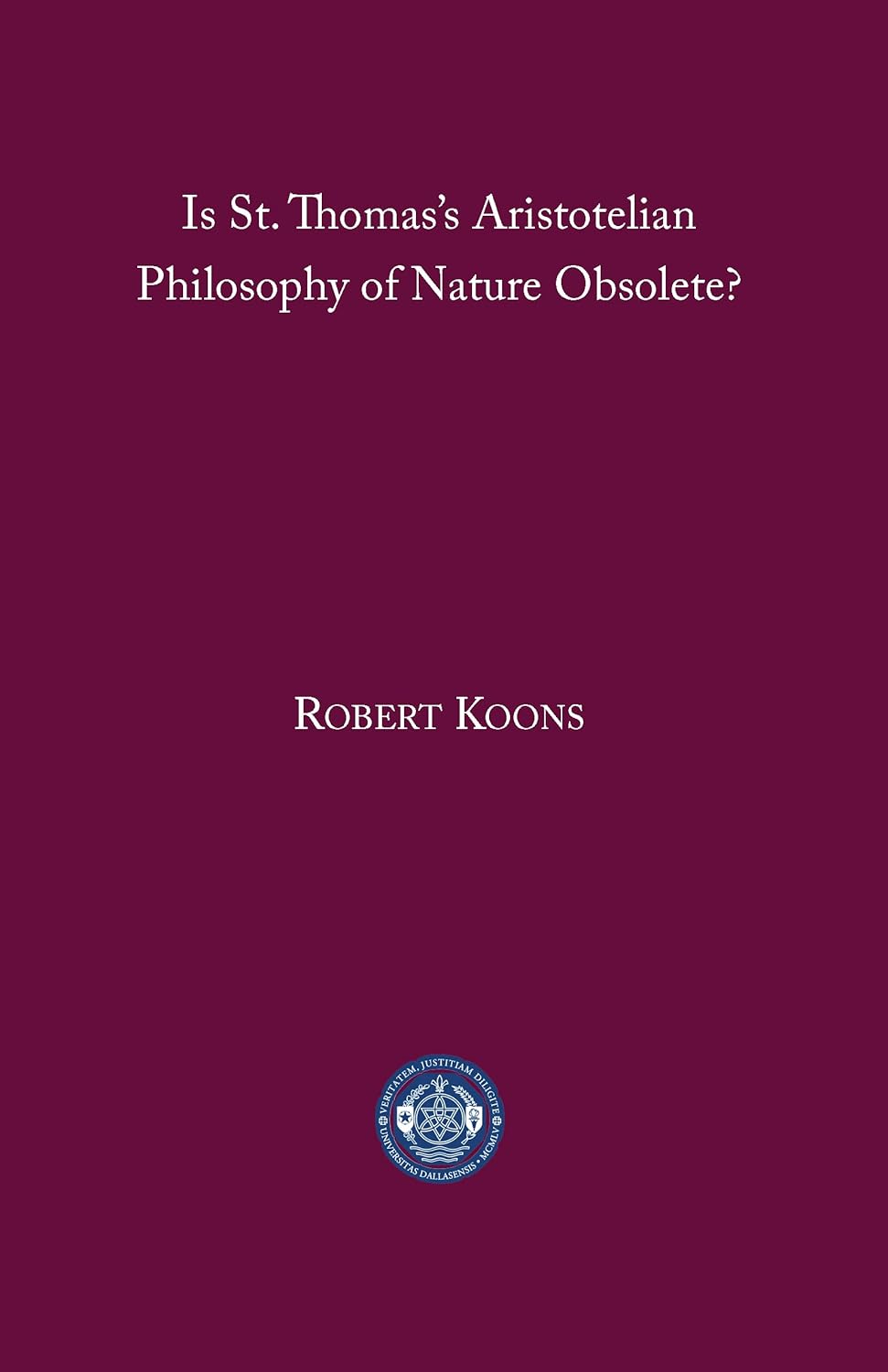
Questo articolo dovrebbe essere letto da tutti quegli atei “da tastiera” che sostengono che fede e scienza sono in contrasto tra loro
Lettura molto interessante, grazie.