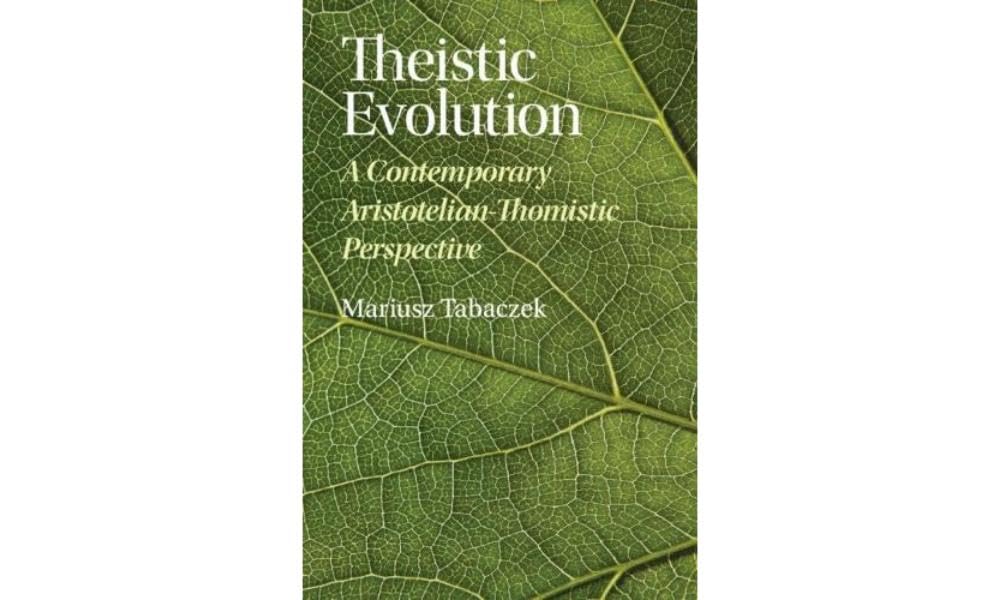Introduzione: una sintesi audace per il XXI secolo
Nel panorama contemporaneo del dialogo tra scienza e religione, poche opere raggiungono l’ambizione e il rigore sistematico di Theistic Evolution: A Contemporary Aristotelian-Thomistic Perspective di Mariusz Tabaczek. Pubblicato da Cambridge University Press nel 2024, questo volume non si limita a un’apologia della compatibilità tra fede e scienza, ma si spinge ben oltre, proponendo una tesi audace: la metafisica aristotelico-tomistica non solo è compatibile con la teoria dell’evoluzione, ma offre il quadro esplicativo più robusto e coerente per una sua comprensione teistica. L’autore, un frate domenicano e accademico con una solida reputazione accademica, avendo già pubblicato opere significative sull’emergenza e l’azione divina, mette a frutto la sua duplice competenza per costruire un argomento monografico che è al contempo filosoficamente denso e teologicamente innovativo.
La tesi centrale del libro è che i recenti sviluppi della biologia evoluzionistica, come l’epigenetica e l’evo-devo (biologia evolutiva dello sviluppo), lungi dal seppellire definitivamente la metafisica classica, ne hanno inaspettatamente riaperto le porte. Tabaczek sostiene che categorie come la causalità formale, la teleologia intrinseca e, soprattutto, l’ilemorfismo (la dottrina della materia e della forma) sono strumenti concettuali indispensabili per dare un senso filosofico profondo ai meccanismi evolutivi. L’obiettivo dichiarato è quello di non abbandonare la lettera della tradizione, ma di riecheggiare lo spirito di Aristotele e Tommaso d’Aquino, “muovendoli in avanti per abbracciare l’aspetto evolutivo della visione contemporanea della realtà”.
Questa recensione si propone di analizzare la complessa architettura argomentativa di Tabaczek, seguendo la struttura bipartita del libro stesso. Nella prima parte, esamineremo le fondamenta filosofiche del suo modello: la sua applicazione della metafisica ilemorfica alla speciazione (Capitolo 1), la sua difesa di un essenzialismo biologico rinnovato (Capitolo 2) e la sua reintegrazione della teleologia e del caso all’interno di un quadro non riduzionista (Capitolo 3). Nella seconda parte, affronteremo la sovrastruttura teologica, che rappresenta forse il contributo più originale e controverso del volume: la sua netta distinzione tra creazione e governo divino (Capitoli 4 e 6), il suo modello tecnico della concorrenza delle cause divine e naturali (Capitolo 7) e la sua applicazione di questi principi all’origine della specie umana (Capitolo 8). Attraverso questa analisi, cercheremo di valutare la coerenza, la forza e le implicazioni di una delle più importanti sintesi contemporanee tra il pensiero classico e la scienza moderna.
Parte I: le fondamenta filosofiche di un mondo in divenire
La prima metà del volume di Tabaczek è dedicata a un compito monumentale: dimostrare che la metafisica aristotelico-tomistica, spesso liquidata come un relitto pre-scientifico, possiede gli strumenti concettuali necessari per fondare filosoficamente una teoria dell’evoluzione. L’autore non si accontenta di affermazioni generiche, ma costruisce un modello dettagliato che affronta le questioni più spinose della filosofia della biologia.
1. Una metafisica ilemorfica per la speciazione (analisi del Capitolo 1)
Il punto di partenza di Tabaczek è la riaffermazione del modello ilemorfico, il cuore della fisica e della metafisica aristoteliche. Ogni sostanza corporea è un composto di due principi co-essenziali: la materia prima (MP) e la forma sostanziale (FS). La MP non è un tipo di “roba” fisica, ma un principio di pura potenzialità, il substrato indeterminato che garantisce la continuità attraverso il mutamento. È la possibilità stessa che qualcosa esista e si trasformi. La FS, d’altra parte, è il principio di attualità, ciò che determina la materia a essere questo tipo di cosa (un cane, una quercia, una molecola d’acqua). È il principio dell’identità, della struttura e dell’operatività di una sostanza.
La genialità dell’applicazione di Tabaczek risiede nel concetto di disposizione della materia (dispositio materiae). L’obiezione classica all’evoluzione da una prospettiva tomista è che una somma di mutamenti accidentali (come le mutazioni genetiche) non può mai produrre un mutamento sostanziale (la nascita di una nuova specie). Tabaczek aggira brillantemente questa difficoltà. Egli sostiene che i mutamenti accidentali (genetici, epigenetici, ambientali) non causano direttamente la nuova specie. Piuttosto, essi agiscono sulla materia dei gameti (sperma e ovulo) di una popolazione lungo molte generazioni, alterandone gradualmente la “disposizione prossima”. Questo significa che la materia diventa sempre più preparata, o “disposta”, a ricevere una forma diversa. La speciazione, quindi, non avviene in un individuo che si trasforma, ma nell’atto di generazione, quando la materia, ora disposta in modo nuovo e radicale, non è più compatibile con la vecchia forma sostanziale (FS) e viene invece attualizzata da una nuova forma sostanziale (FS2), che viene “edotta” dalla potenzialità della materia. In questo modo, il gradualismo empirico dell’evoluzione è reso compatibile con il salto ontologico richiesto dalla metafisica delle sostanze.
Questo modello, tuttavia, deve affrontare la sfida del Principio di Causalità Proporzionata (PCP), secondo cui un effetto non può essere più perfetto della sua causa. Come può una causa inferiore (ad esempio, una popolazione di rettili) produrre un effetto superiore (il primo uccello)? Tabaczek esplora diverse linee di difesa. La prima è l’idea della “causa totale”: non sono i singoli genitori a causare la nuova specie, ma l’intera matrice storica di cause (genetiche, ambientali, selettive) che, nel suo complesso, possiede la perfezione richiesta almeno virtualmente per produrre l’effetto. Una seconda, più speculativa, è la nozione di una “conservazione della perfezione”, per cui l’acquisizione di nuove capacità (come il volo) è spesso bilanciata dalla perdita di altre o dall’insorgere di nuove vulnerabilità, mantenendo un equilibrio complessivo nell’universo. Infine, egli accenna alla gerarchia tomista delle cause, in cui Dio e le cause universali (come i corpi celesti, nel linguaggio medievale) possono operare attraverso le cause seconde per produrre effetti che superano le capacità di queste ultime. Nella loro complessità, queste difese mostrano la serietà con cui Tabaczek affronta le obiezioni più tecniche, cercando soluzioni all’interno del suo sistema piuttosto che ignorare le difficoltà.
2. La questione della specie rivisitata: una difesa dell’essenzialismo (analisi del Capitolo 2)
Il secondo capitolo affronta una delle questioni più controverse nella filosofia della biologia: il concetto di specie. L’ortodossia post-darwiniana ha largamente favorito i Concetti di Specie Relazionali (CSR), che definiscono una specie in base a relazioni esterne, come l’interfecondità (il Biological Species Concept), la nicchia ecologica o la discendenza comune (il Phylogenetic Species Concept). Tabaczek analizza criticamente questi approcci, mostrando i loro limiti operativi (ad esempio, non si applicano agli organismi asessuati) e la loro incompletezza filosofica. Egli sostiene che, per identificare una “popolazione interfeconda” o una “linea ancestrale”, si devono implicitamente presupporre delle proprietà intrinseche condivise che uniscono gli organismi in questione.
Di conseguenza, Tabaczek propone un ritorno a un Concetto Essenzialista di Specie (CES), ma in una versione sofisticata e compatibile con l’evoluzione. L’essenza di una specie non è un’idea platonica fissa e immutabile, ma è radicata nella sua forma sostanziale. Questa forma è un principio dinamico e immanente che guida lo sviluppo (il programma di sviluppo) e il funzionamento di un organismo. È ciò che spiega perché i membri di una specie condividono un insieme di proprietà e tendenze, pur manifestando una notevole variazione individuale.
Tabaczek affronta di petto le due obiezioni classiche all’essenzialismo biologico. La prima è l’accusa di fissismo. A questa, egli risponde che l’essenzialismo aristotelico-tomista non è mai stato fissista nel senso di negare il mutamento. La forma sostanziale è stabile, ma è realizzata in individui la cui materia prima rimane sempre in potenza a ricevere nuove forme. La variazione, quindi, non è una “deviazione” da un tipo ideale, ma il materiale stesso su cui agiscono le forze evolutive per modificare la disposizione della materia e, infine, rendere possibile l’eduzione di una nuova forma.
La seconda obiezione riguarda i confini rigidi tra le specie, che sembrerebbero incompatibili con la gradualità dell’evoluzione. La risposta che qui dà Tabaczek è una delle idee più interessanti che troviamo nel volume: egli opera una distinzione fondamentale tra indeterminatezza epistemologica e determinatezza ontologica. La nostra difficoltà nel tracciare una linea netta tra una specie ancestrale e una discendente è un problema di conoscenza, dovuto alla gradualità del mutamento fenotipico e genetico. Ontologicamente, tuttavia, un organismo o possiede la forma sostanziale di un cavallo o non la possiede; non può essere “un po’ cavallo e un po’ qualcos’altro”. Il salto ontologico avviene a livello di generazione, quando una nuova forma viene edotta, ed è perfettamente compatibile con la continuità empirica che lo precede. Questo approccio ha il grande merito di rispettare sia le esigenze della metafisica, che richiede principi chiari, sia quelle della biologia, che lavora con dati complessi e sfumati, stabilendo tra le due una relazione di corrispondenza e non di conflitto.
3. Reintegrare la teleologia: caso, finalità e selezione naturale (analisi del Capitolo 3)
Nel terzo capitolo, Tabaczek completa la sua fondazione filosofica affrontando il concetto di teleologia. Egli recupera la nozione aristotelica di finalità come un principio immanente e naturale, non come il progetto di un artefice esterno. Il telos di un organismo è il suo bene, il pieno sviluppo e funzionamento secondo la sua natura. L’ala di un uccello non è “progettata” per volare, ma il suo essere un’ala è essere per il volo, una finalità intrinseca alla sua stessa struttura e funzione.
In questo quadro, il caso non è una forza cieca e primordiale che si oppone alla finalità. Al contrario, il caso è una causa per accidens, un evento che risulta dall’intersezione fortuita di due o più catene causali che sono, in sé, teleologicamente dirette. Una mutazione genetica casuale non è un evento senza causa, ma il risultato di un’interazione (es. con radiazioni) che è accidentale rispetto al fine intrinseco del gene, che è quello di replicarsi fedelmente. Il caso, quindi, è ontologicamente parassitario sull’ordine e sulla finalità.
Questa prospettiva permette a Tabaczek di offrire un’interpretazione originale della selezione naturale. Invece di vederla come un meccanismo “creativo”, egli la interpreta come un principio descrittivo. La selezione naturale non causa l’adattamento; piuttosto, descrive il risultato del successo riproduttivo differenziale degli organismi. La vera teleologia, la vera forza motrice, risiede negli organismi stessi: nel loro sforzo intrinseco di sopravvivere, svilupparsi e riprodursi nel loro ambiente. La selezione naturale agisce semplicemente come un “filtro” per le morfologie che non riescono a raggiungere questo fine.
Questa mossa argomentativa è particolarmente potente perché allinea il modello aristotelico-tomistico con le tendenze più recenti della biologia evoluzionistica, in particolare l’Extended Evolutionary Synthesis (EES). L’EES, infatti, ridimensiona il ruolo quasi esclusivo attribuito alla selezione naturale dalla Sintesi Moderna e restituisce un ruolo causale centrale all’organismo, ai suoi processi di sviluppo (evo-devo) e alla sua interazione con l’ambiente (costruzione della nicchia). Il quadro di Tabaczek, con la sua enfasi sulla forma/anima come principio intrinseco di attività e finalità, si rivela così sorprendentemente attuale, dimostrando come un’antica metafisica possa illuminare i dibattiti scientifici più avanzati.
Parte II: la sovrastruttura teologica: creazione, governo e concorrenza
Se la prima parte del libro costruisce le fondamenta filosofiche, la seconda erige su di esse un edificio teologico audace e rigoroso. Qui Tabaczek non si limita a difendere la compatibilità, ma propone una revisione critica di alcuni concetti chiave dell’evoluzionismo teistico contemporaneo, offrendo un modello tomista distintivo e coerente.
4. La creazione ridefinita: oltre il “Creazionismo Evolutivo” (analisi dei Capitoli 4 e 6)
Il cuore della proposta teologica di Tabaczek risiede in una distinzione netta e fondamentale: quella tra Creazione (creatio) e Governo (gubernatio). Per Tommaso d’Aquino, la Creazione in senso stretto è l’atto divino, istantaneo e atemporale, di portare l’intero universo all’esistenza dal nulla (ex nihilo) e di conservarlo continuamente nell’essere (conservatio). Questo atto è esclusivo di Dio e non può essere condiviso. L’Evoluzione, al contrario, è un processo di trasformazione di materia già esistente. Pertanto, essa non appartiene all’atto della creazione, ma al Governo provvidenziale con cui Dio guida il mondo verso il suo compimento. L’evoluzione è parte dell’opus ornatus, l’opera di “adornamento” del mondo descritta nella Genesi, che si dispiega nella storia.
Questa distinzione porta Tabaczek a una critica serrata di concetti oggi molto diffusi come “creazione evolutiva” o “creazione continua”. Egli sostiene che questi termini sono teologicamente imprecisi e potenzialmente fuorvianti, perché confondono due atti divini radicalmente diversi. L’idea che le creature possano “co-creare” con Dio è respinta con forza, sulla base del principio tomista secondo cui solo Dio, che è l’Essere stesso, può dare l’essere. Le creature non creano; agiscono come cause seconde all’interno del mondo creato, partecipando al governo divino, non al suo atto creativo.
La portata di questa distinzione va ben oltre la semplice pignoleria terminologica. Essa ha profonde implicazioni per la teodicea e la comprensione dell’azione divina. Se l’evoluzione è un aspetto del governo divino di un mondo a cui è stata concessa una reale integrità causale, allora la sofferenza, la lotta per la sopravvivenza e l’estinzione non sono atti diretti della “creazione” divina. Dio non “crea” attraverso la sofferenza, ma governa un mondo contingente, con i suoi processi naturali, che includono anche aspetti tragici. Questo permette di formulare una teodicea più robusta, che non attribuisce direttamente a Dio il male fisico presente nell’evoluzione, e preserva la trascendenza divina, evitando i modelli panenteisti in cui Dio sembra essere immanentemente coinvolto e quasi vincolato al processo cosmico.
5. Un modello di concorrenza causale nell’evoluzione (analisi del Capitolo 7)
Per spiegare come Dio governi il mondo attraverso l’evoluzione, Tabaczek sviluppa un modello tecnico della concorrenza delle cause, basato sulla duplice distinzione tomista: causa primaria/secondaria e causa principale/strumentale.
Applicato alla speciazione, il modello funziona così: gli agenti creaturali (i genitori, l’ambiente, i meccanismi genetici) agiscono come cause seconde nell’edurre la nuova forma sostanziale dalla potenzialità della materia. Essi operano secondo le loro nature, ma sempre sotto l’azione della Causa Prima, Dio, che fonda e sostiene ogni causalità. Allo stesso tempo, poiché l’effetto finale (una nuova specie con la sua propria esistenza ed essenza) supera le capacità naturali delle singole cause, esse agiscono anche come cause strumentali nelle mani di Dio, la Causa Principale. Dio non si sostituisce alle cause naturali, ma le muove dall’interno, permettendo loro di produrre effetti che trascendono la loro portata individuale. Questo modello offre una notevole chiarezza concettuale, evitando le trappole del deismo (un Dio orologiaio che abbandona il mondo), dell’occasionalismo (le creature non hanno vera causalità) o di una problematica competizione causale tra Dio e il mondo.
6. L’origine dell’umanità: un’antropogenesi tomista (analisi del Capitolo 8)
L’ultimo capitolo applica questo quadro all’origine dell’uomo, il punto più delicato del dibattito. Tabaczek riafferma l’unicità ontologica dell’essere umano: la sua anima razionale è una forma sostanziale immateriale e sussistente. Per questo motivo, essa non può essere “edotta dalla potenzialità della materia” come le anime degli animali o le forme delle piante.
Il modello di concorrenza causale viene quindi adattato. Il processo evolutivo, guidato da cause seconde, procede naturalmente fino a produrre un organismo ominide con una complessità biologica tale da rendere la sua materia “propriamente disposta” a ricevere un’anima umana. A quel punto, l’anima stessa non emerge dalla materia, ma deve essere creata ex nihilo direttamente da Dio e unita a quella materia per costituire il primo essere umano.
Questo approccio è di grande finezza, perché non postula un “Dio delle lacune” (God of the gaps) che interviene per colmare una lacuna scientifica. La continuità biologica ed evolutiva è pienamente rispettata. La lacuna non è empirica, ma ontologica. L’azione divina non interrompe la catena causale fisica, ma opera su un piano diverso, quello della creazione dell’essere spirituale, per attualizzare la materia che il processo naturale ha preparato. In questo modo, vengono salvaguardate sia la continuità del processo evolutivo descritto dalla scienza, sia l’unicità e la dignità dell’essere umano affermate dalla teologia.
Infine, nella discussione sul monogenismo contro il poligenismo, Tabaczek dimostra un notevole equilibrio accademico. Egli espone con onestà intellettuale sia le prove scientifiche che puntano fortemente verso un’origine poligenetica (da una popolazione ancestrale), sia le ragioni teologiche tradizionali (legate alla dottrina del peccato originale) che hanno storicamente favorito il monogenismo. Analizzando i tentativi contemporanei di conciliare le due posizioni, egli conclude che la questione rimane teologicamente aperta, un segno di rigore intellettuale che evita soluzioni dogmatiche semplicistiche.
Per illustrare la precisione metodologica che sottende l’intero progetto di Tabaczek e che gli permette di navigare in queste acque complesse, è utile riportare la sua classificazione delle diverse categorie di “specie” o “tipo”, che egli distingue attentamente per evitare le confusioni che affliggono gran parte del dibattito.
| Categoria | Definizione | Relazione con le Altre Categorie |
| (1) Forma Sostanziale | Un principio metafisico di attualità che fa sì che una data entità sia ciò che è. Un principio che informa la MP in un’entità individuale. | • Fondamentale per la comprensione di (2). • Correlata a (4) nell’interpretazione che definisce le essenze in riferimento all’ilemorfismo. |
| (2) Specie Metafisica | Una categoria universale che classifica un numero di entità come appartenenti a una stessa classe ontologica, basata su un particolare tipo di FS che le attualizza. | • Fondamentalmente radicata in (1). • Correlata a (3) nell’interpretazione che vede le FS come accessibili attraverso l’analisi delle proprietà strutturali e disposizionali empiricamente tracciabili. • Correlata a (4) nell’interpretazione che definisce le essenze in riferimento all’ilemorfismo. |
| (3) Specie Biologica | Una categoria universale che classifica un numero di organismi viventi come appartenenti a un gruppo sulla base di fenomeni empiricamente osservabili (es. interfecondità, nicchia ecologica, storia evolutiva, ecc.). | • Correlata a (1) e (2) nell’interpretazione che vede i fenomeni osservabili come indicatori di un particolare tipo di FS. • Correlata a (4) nell’interpretazione che aspira a riflettere la struttura oggettiva del mondo. |
| (4) Tipo Naturale | Una categoria universale che classifica un numero di entità come appartenenti a un gruppo sulla base di un’essenza comune e in riferimento a proprietà o strutture intrinseche necessarie e sufficienti. | • Correlata a (1) e (2) nell’interpretazione che fonda l’essenzialismo sull’ilemorfismo. • Correlata a (3) nell’interpretazione che cerca di andare oltre un approccio puramente pragmatico. |
| (5) Tipo Biblico | Le forme di vita originali così come create da Dio, cioè i “tipi” della Genesi (baramin). Categoria basata su una lettura letterale della Genesi. | • Potenzialmente aperta a (1), (2), (3) e (4) da una prospettiva di “fede che cerca l’intelletto”. |
Tabella adattata da Tabaczek, Theistic Evolution, p. 172.
Questa tabella è la chiave di volta metodologica del libro. Essa previene le fallacie categoriali, mostrando come Tabaczek non confonda un concetto biologico operativo (Specie Biologica) con un principio ontologico (Specie Metafisica). Invece, egli costruisce un argomento multi-livello che rispetta l’autonomia di ogni campo del sapere (scienza, filosofia, teologia), integrandoli in una sintesi coerente e rigorosa.
Valutazione critica e conclusione: il contributo di “Theistic Evolution”
Giunti al termine di questa analisi, è possibile formulare una valutazione complessiva dell’opera di Mariusz Tabaczek, evidenziandone i punti di forza e le aree che rimangono aperte al dibattito.
Punti di forza:
L’opera si distingue per una serie di qualità che la rendono un contributo di prim’ordine.
- Rigore Sistematico: A differenza di molte opere sul tema, che sono raccolte di saggi o trattazioni parziali, Theistic Evolution è un’ampia monografia costruita con coerenza e progressione logica, dove ogni capitolo poggia sul precedente.
- Originalità Teologica: La critica al concetto di “creazione evolutiva” e la netta distinzione tra creatio e gubernatio rappresentano un contributo significativo e potenzialmente correttivo al dibattito contemporaneo. Questa mossa teologica permette di affrontare il problema della teodicea evolutiva in modo più robusto, preservando la trascendenza di Dio.
- Profondità Metafisica: L’applicazione dell’ilemorfismo e della teoria della causalità è eccezionalmente dettagliata. Tabaczek non si limita a generiche affermazioni di compatibilità, ma offre un modello esplicativo concreto e tecnicamente sofisticato, in grado di rispondere a obiezioni filosofiche complesse.
- Integrazione con la Scienza Contemporanea: Il libro dimostra un dialogo genuino con la scienza più recente. L’uso informato dei dati provenienti dall’evo-devo e dall’epigenetica per sostenere il recupero delle categorie classiche mostra che non si tratta di un’imposizione di schemi precostituiti, ma di una ricerca di autentica consilienza tra discipline.
Aree di dibattito e potenziali limiti:
Nonostante i suoi innegabili meriti, il libro solleva questioni che meritano ulteriore discussione.
- La distinzione tra creatio e gubernatio, per quanto teologicamente precisa, potrebbe essere percepita come troppo netta. Si potrebbe obiettare che, relegando l’atto creativo di Dio a un singolo istante iniziale, si rischi di avvicinarsi a una forma sofisticata di deismo, anche se l’autore si sforza di evitarlo sottolineando la conservatio divina.
- La complessità tecnica del modello di causalità e della metafisica ilemorfica, pur essendo un punto di forza accademico, potrebbe limitare l’accessibilità e la forza persuasiva del libro per un pubblico non specializzato in filosofia scolastica.
- Sarebbe interessante vedere un confronto più diretto tra il modello di Tabaczek e le più raffinate teorie panenteiste, che cercano di articolare l’immanenza e l’azione divina in modi diversi, per mostrare in modo adeguato come il primo offra una sintesi più soddisfacente tra la trascendenza e l’immanenza di Dio nel mondo evolutivo.
Conclusione finale:
Theistic Evolution: A Contemporary Aristotelian-Thomistic Perspective di Mariusz Tabaczek si impone come un’opera di riferimento nel suo campo specifico. Con la sua profondità filosofica, il suo rigore teologico e la sua seria integrazione con la scienza contemporanea, il libro stabilisce un nuovo standard per chiunque voglia affrontare il tema dell’evoluzione da una prospettiva classica. Pur essendo un’opera che esige un certo sforzo di comprensione da parte dal lettore, il tentativo di Tabaczek di costruire una sintesi coerente, fedele alla grande tradizione e aperta alle sfide del presente, la rende una lettura imprescindibile e un punto di partenza obbligato per le future discussioni accademiche. È un tour de force intellettuale che dimostra la perenne vitalità del pensiero aristotelico-tomista di fronte alle più grandi questioni del nostro tempo.