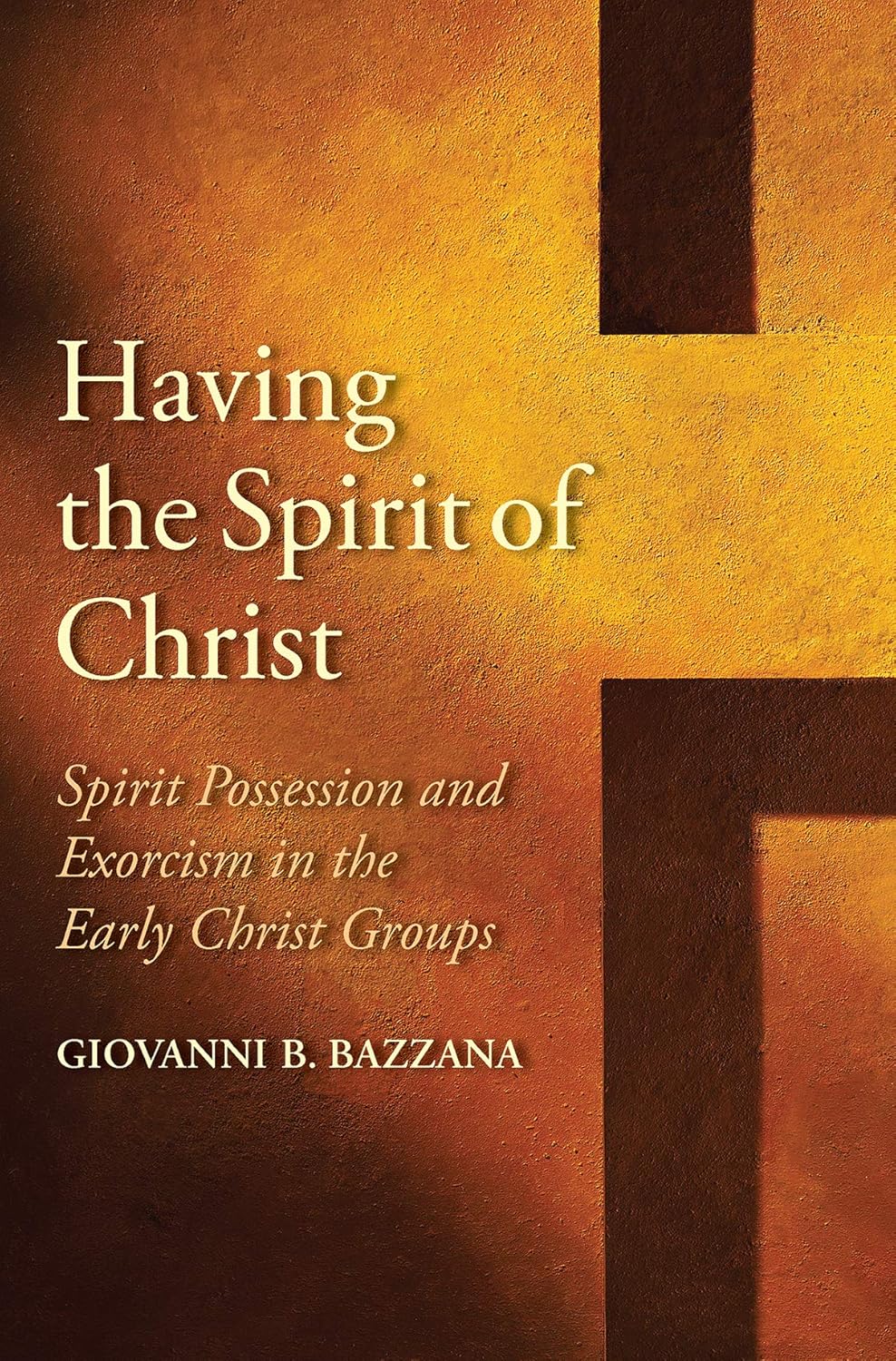Introduzione: oltre la metafora e l’imbarazzo
Il volume di Giovanni B. Bazzana, Having the Spirit of Christ: Spirit Possession and Exorcism in the Early Christ Groups, pubblicato da Yale University Press, si inserisce nel dibattito accademico con la forza di un intervento metodologico tanto necessario quanto radicale. L’opera affronta un tema che la ricerca neotestamentaria ha a lungo trattato con un palpabile “imbarazzo”: la possessione spiritica e l’esorcismo. Bazzana sostiene che la difficoltà non risiede nella scarsità di dati testuali — i Vangeli e le lettere paoline ne sono pervase — ma in un blocco epistemologico radicato nelle ontologie moderne e occidentali che hanno plasmato la disciplina. Partendo da un aneddoto contemporaneo, quello di una donna che cade in trance davanti alla Sindone di Torino, l’autore illustra come ancora oggi la possessione venga esotizzata, medicalizzata o ridotta a spettacolo, perpetuando un fraintendimento che ha profonde radici accademiche. (pp. 1-4)
La critica di Bazzana si rivolge alle due strategie ermeneutiche dominanti con cui la ricerca ha neutralizzato la centralità della possessione. La prima è la marginalizzazione: nonostante la sua evidenza quantitativa, la pratica esorcistica di Gesù viene spesso relegata a un aspetto secondario della sua attività, una concessione alle “superstizioni” del suo tempo. La seconda, più pervasiva, è l’allegorizzazione: gli esorcismi vengono sistematicamente letti come metafore della liberazione dal peccato, dall’oppressione imperiale romana o dalla sofferenza sociale, svuotandoli della loro specificità come pratiche culturali e religiose autonome. (pp. 5-6)
L’analisi di Bazzana non si ferma alla diagnosi, ma scava fino alla radice del problema, individuandola nelle fondamenta illuministiche della critica biblica moderna. Il razionalismo e l’individualismo che hanno definito il pensiero occidentale hanno promosso un modello di soggettività autonoma, indivisibile e non “permeabile” da agenti esterni. Questo paradigma ontologico, assunto acriticamente dalla disciplina, si è rivelato strutturalmente incapace di comprendere un fenomeno come la possessione, che lo sfida frontalmente. L’approccio di Rudolf Bultmann, con la sua “demitizzazione”, e persino quello di storici rigorosi come John P. Meier, che relega la “verità” dei miracoli alla sfera teologica eludendone le implicazioni ontologiche, sono visti come manifestazioni di questo stesso imbarazzo. (pp. 6-9) Il lavoro di Bazzana, quindi, non si limita a proporre un nuovo metodo, ma suggerisce che per studiare adeguatamente il cristianesimo antico, la disciplina deve compiere un passo di auto-riflessione critica: deve “provincializzare” se stessa, riconoscendo le proprie fondamenta ontologiche non come una verità universale, ma come un costrutto culturale storicamente situato.
La tesi centrale del volume emerge con chiarezza da questa critica: la possessione spiritica nei primi gruppi cristiani non deve essere letta come un fenomeno negativo, patologico o marginale, ma come una pratica culturale produttiva, ordinaria e performativa. Essa è stata centrale per la costruzione della soggettività, per la strutturazione delle relazioni sociali, per la formulazione delle dottrine e per la poiesis della memoria storica. (pp. 4, 12, 206) L’obiettivo di Bazzana è di “defamiliarizzare” il lettore dai testi neotestamentari attraverso un dialogo rigoroso con l’antropologia culturale, permettendo di vedere con occhi nuovi ciò che secoli di esegesi teologicamente orientata hanno oscurato.
Un apparato teorico per “defamiliarizzare” il testo
Per realizzare questo progetto di “ridescrizione” — nel senso che Jonathan Z. Smith dà al termine — Bazzana costruisce un solido e sofisticato apparato teorico, attingendo criticamente dalla letteratura antropologica. Il suo primo passo è superare i modelli che, pur avendo aperto la strada, si sono rivelati insufficienti. Riconosce l’importanza del lavoro di Ioan M. Lewis e della sua distinzione tra “possessione centrale” (che rafforza l’ordine sociale) e “possessione periferica” (praticata dai marginalizzati). Tuttavia, ne evidenzia i limiti riduzionisti: il modello di Lewis tende a interpretare la possessione quasi esclusivamente come una “reazione” a pressioni sociali o come una “valvola di sfogo” per le categorie oppresse, trascurandone la capacità di essere una pratica culturalmente produttiva e generativa di per sé. (pp. 10-12, 18)
Il cuore del quadro metodologico di Bazzana risiede invece nell’adozione del paradigma sviluppato da Michael Lambek nei suoi studi sulla possessione in Madagascar. Da Lambek, l’autore mutua una concezione della possessione come:
- Un testo culturale complesso, una polifonia di voci che l’analista può “leggere” per coglierne le grammatiche di produzione e interpretazione. (p. 13)
- Una pratica produttiva (poiesis), capace di generare attivamente conoscenza, moralità e soggettività, e non solo di reagire a condizioni esterne. (pp. 12, 23)
- Un fenomeno ordinario, integrato nella vita quotidiana e non necessariamente relegato allo straordinario, al patologico o alla stregoneria. (p. 12)
- Una performance incarnata e una negoziazione continua tra il medium, lo spirito e il pubblico, la cui partecipazione attiva è fondamentale per la validazione e l’efficacia del rito. (pp. 14, 167-168)
Parte integrante di questo progetto di “ridescrizione” è una meticolosa riflessione terminologica. Bazzana sceglie le sue parole con cura per evitare le trappole ideologiche del linguaggio accademico tradizionale.
- “Spirito” (pneuma): Viene usato sistematicamente tra virgolette per segnalare la sua distanza dalla concezione platonico-occidentale di un’entità puramente immateriale. Nei testi antichi, e in Paolo in particolare, lo pneuma è concepito come una sostanza materiale, potente e attiva. (pp. 16, 29)
- “Possessione”: Il termine viene mantenuto, ma con piena consapevolezza della sua problematica genealogia coloniale (messa in luce da Paul C. Johnson). Bazzana ne sfrutta l’ambiguità produttiva: non solo lo spirito “possiede” l’ospite, ma l’ospite può arrivare a “possedere” e controllare lo spirito. (pp. 16-17)
- Rifiuto di categorie fuorvianti: Vengono deliberatamente evitati termini come “magia”, a causa della sua storica e ideologica opposizione a “religione”, che lo ha reso un’etichetta per designare la “falsità” e l’alterità. Similmente, si evita di ridurre il fenomeno alla “stregoneria”, per non limitare l’analisi alla sola dimensione polemica dell’accusa, trascurando l’ordinarietà della pratica. Infine, viene scartata la categoria di “sciamanesimo”, giudicata troppo vaga, storicamente intrecciata con preconcetti cristiani e a rischio di circolarità argomentativa. (pp. 17-20)
Il cambio di paradigma proposto da Bazzana può essere visualizzato attraverso una tabella comparativa che ne cristallizza il contributo metodologico.
| Aspetto della possessione | Visione tradizionale/riduzionista | Approccio antropologico di Bazzana |
| Natura del fenomeno | Negativa, patologica, metaforica, marginale. | Produttiva, ordinaria, incarnata, centrale. |
| Soggettività del posseduto | Passiva, vittima di un agente esterno. | Attiva, negoziata, in costruzione (da “ostaggio” a “ospite”). |
| Funzione sociale | Reazione a oppressione, valvola di sfogo (Lewis). | Creazione di legami sociali, poiesis della storia, critica culturale. |
| Approccio ermeneutico | Allegorizzazione, medicalizzazione, demitizzazione. | Lettura come performance rituale, testo culturale, esperienza vissuta. |
Questa sintesi visiva chiarisce come il lavoro di Bazzana non sia una semplice applicazione di un nuovo metodo, ma un tentativo di rifondare l’approccio allo studio dell’esperienza religiosa nel cristianesimo antico, liberandolo dai vincoli di un’ontologia che ne ha a lungo impedito la comprensione.
La costruzione della soggettività dell’esorcista: rileggere i Vangeli
Armato di questo apparato teorico, Bazzana si dedica a una rilettura di alcune delle più note pericopi evangeliche, dimostrando la fecondità del suo approccio.
Da ostaggio a ospite nella controversia di Beelzebul
Il primo capitolo affronta la controversia di Beelzebul (Marco 3; Q 11), tradizionalmente interpretata come una semplice accusa di stregoneria rivolta a Gesù. Bazzana la rilegge in modo radicalmente diverso: non come un attacco polemico, ma come la rappresentazione di una negoziazione discorsiva sulla natura della possessione di Gesù stesso. (pp. 24, 33-34) Le accuse “ha Beelzebul” e “opera in Beelzebul” non sono meri insulti, ma riflettono l’ambiguità intrinseca dell’esperienza. La risposta di Gesù (“Come può Satana scacciare Satana?”) non è una negazione della sua relazione con un’entità spirituale potente, ma una sua ridefinizione strategica. Egli ammette implicitamente di utilizzare il potere di uno spirito “straniero” e potente (Beelzebul) per combattere il capo dei demoni (Satana), dimostrando che il regno demoniaco è diviso e quindi vulnerabile.
Questo processo trasforma Gesù da “ostaggio” passivo di uno spirito a “ospite” attivo, che ne controlla e ne dirige il potere per fini terapeutici. (pp. 37-38, 43-44) Questa traiettoria trova paralleli illuminanti in contesti etnografici. Bazzana richiama il caso di Zeinabou, una giovane donna del Niger la cui traumatica possessione da parte dello spirito Rankasso diventa, nel tempo, un’opportunità per rinegoziare la propria identità e il proprio ruolo sociale. Allo stesso modo, cita l’espiritismo cubano, dove la relazione tra il medium e i suoi muertos (spiriti protettori) è un percorso graduale di conoscenza, addomesticamento e costruzione del sé. (pp. 42-44) In questa luce, la pericope di Beelzebul diventa la cronaca di come si “costruisce” la soggettività di un esorcista: non attraverso un potere innato, ma attraverso una pericolosa e produttiva negoziazione con l’alterità spirituale.
Un rituale tra le tombe: l’esorcismo di Gerasa
Il secondo capitolo analizza l’esorcismo del demoniaco di Gerasa (Marco 5) come la trascrizione narrativa di un complesso rituale performativo. (pp. 60, 80) L’identità dello spirito che possiede l’uomo è un amalgama creativo di due tradizioni culturali sull’alterità. Da un lato, la designazione “spirito impuro” (akátharton pneûma) rimanda al mondo mitologico giudaico, in particolare alle tradizioni enochiche sui giganti, i nefasti figli degli angeli caduti, i cui spiriti irrequieti continuano a infestare la terra. (pp. 61, 68-72) Dall’altro, la sua dimora tra le tombe e il suo comportamento violento evocano le credenze pan-mediterranee sui “morti inquieti” (biaiothánatoi), spiriti di persone morte prematuramente o violentemente che non trovano pace. (pp. 72, 74-78)
Questa duplice alterità viene ulteriormente complicata dalla dimensione politica. Il nome “Legione” non è una semplice allegoria anti-romana, ma un elemento chiave della performance rituale. L’esorcismo, culminante nella fine parodica e comica dei demoni che si gettano nel mare con i maiali, diventa uno spazio simbolico per rimodellare immaginativamente le complesse e tese identità etniche (giudaiche, gentili, romanizzate) della regione della Decapoli. Invece di essere solo una fantasia di inversione del potere imperiale, il rituale apre la possibilità di immaginare forme di coesistenza alternative alla dominazione e al conflitto, come suggerito dal comando finale di Gesù all’uomo guarito di rimanere nella sua terra e testimoniare. (pp. 85, 98-101)
In entrambi i capitoli evangelici, Bazzana mette in luce una dinamica fondamentale. Egli individua una traiettoria redazionale che si allontana da una rappresentazione “grezza”, ambigua e performativa della possessione per virare verso una cornice più controllata, polemica e cristologicamente definita. Nel caso di Beelzebul, quella che era probabilmente una negoziazione aperta e comunitaria sull’identità dello spirito di Gesù viene trasformata dai redattori evangelici in una controversia con avversari ben definiti (“scribi”, “farisei”), focalizzata sull’autorità unica di Cristo. (pp. 52-53, 57-58) Similmente, l’esorcismo di Gerasa, un rituale di guarigione e rinegoziazione identitaria, viene inserito da Marco nella sua più ampia narrazione sull’incomprensione del messia. Questo schema suggerisce un processo più generale nel cristianesimo nascente: l’addomesticamento dell’energia carismatica. Le esperienze spirituali dirette, fluide e potenzialmente destabilizzanti vengono progressivamente incanalate, interpretate e controllate attraverso la costruzione di narrazioni autorevoli, gerarchie ecclesiastiche e cornici dottrinali. Il lavoro di Bazzana offre un modello prezioso per tracciare questa dinamica fondamentale.
“Essere in Cristo”: la possessione come cuore dell’esperienza paolina
La seconda parte del volume sposta l’attenzione dai Vangeli alle lettere di Paolo, dimostrando come la stessa logica esperienziale della possessione sia fondamentale per comprendere la teologia, l’etica e la vita comunitaria dei gruppi paolini.
Cristo come pneuma e la cristologia pneumatica
Il terzo capitolo avanza la tesi audace e centrale che l’espressione paolina “essere in Cristo” (en Christôi) non sia una metafora teologica, ma l’idioma tecnico per descrivere l’esperienza di possessione da parte del pneuma di Cristo risorto. (pp. 102, 105-106) L’analisi di 1 Corinzi 15,45 (“L’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita”) è qui decisiva. La risurrezione non è solo un evento salvifico del passato, ma ha operato una trasformazione ontologica: ha reso Cristo un’entità pneumatica, materiale e potente, capace di abitare e “possedere” i corpi dei credenti, garantendo loro la futura trasformazione in “corpi spirituali”. (pp. 111-114, 119)
Per rafforzare questa lettura, Bazzana la confronta con la V Similitudine del Pastore di Erma, un testo del II secolo. Anche in Erma, sebbene con un linguaggio e una concettualizzazione diversi, si trova una cristologia pneumatica in cui il Figlio di Dio preesistente è identificato con lo Spirito Santo che viene a dimorare nella “carne” (Gesù), la quale, servendo fedelmente lo spirito, viene esaltata. Questo parallelo dimostra che l’idea di Cristo come pneuma che interagisce con i credenti non era un’idiosincrasia paolina, ma una concezione diffusa nel cristianesimo antico. (pp. 125-132)
Le funzioni sociali ed etiche della possessione paolina
Il quarto capitolo esplora le conseguenze di questa esperienza. Se i credenti sono posseduti dal pneuma di Cristo, come influenza questo la loro vita? Bazzana, sempre in dialogo con Lambek, sostiene che la possessione permette una “poiesis della storia”. Il passato di Cristo, in particolare la sua morte e risurrezione, non è semplicemente ricordato o commemorato, ma è reso presente e incarnato nei corpi dei credenti. Questo spiega il focus quasi esclusivo di Paolo su questi due eventi: non è dovuto a ignoranza della vita del Gesù storico, ma al fatto che questi sono gli eventi che definiscono la “personalità” e la potenza dello spirito che ora possiede la comunità. (pp. 145-150)
Questa incarnazione del passato di Cristo ha dirette implicazioni etiche. L’azione morale e la soggettività dei credenti non derivano dall’adesione a un codice di leggi, ma dall’esperienza affettiva ed effettiva di “avere lo spirito di Cristo” e di conformare la propria esistenza alla sua. (pp. 160-166)
La negoziazione della performance in 1 Corinzi 12-14
L’ultimo capitolo del libro è dedicato a un’analisi approfondita di 1 Corinzi 12-14. Il dibattito a Corinto non verte sull’opportunità di avere doni carismatici — la cui importanza è data per scontata da entrambe le parti — ma su come eseguire correttamente il rituale di possessione durante le assemblee comunitarie. (pp. 167, 171, 180-181)
Bazzana decodifica la retorica paolina, mostrando come l’apostolo promuova due criteri fondamentali. Il primo è l’edificazione (oikodomé) della comunità, un valore condiviso e retoricamente efficace. Il secondo, più controverso, è quello dell’intelligibilità. Paolo privilegia la profezia sulla glossolalia perché la prima, essendo comprensibile, contribuisce all’edificazione comune. Questo criterio, di natura epistemologica, finisce per valorizzare il contenuto cognitivo delle rivelazioni e, di conseguenza, l’autorità di Paolo stesso come mediatore e interprete qualificato di tali contenuti. (pp. 184-188)
Leggendo il testo “contro-corrente”, Bazzana ipotizza quale potesse essere la posizione dei corinzi. Essi, probabilmente, non distinguevano nettamente tra profezia e glossolalia e potevano valorizzare proprio l’inintelligibilità di quest’ultima (intesa come “lingua degli angeli”) come segno diretto e non mediato della presenza del divino. Per loro, l’incomprensibilità non era un difetto comunicativo da correggere, ma la prova stessa dell’autenticità dell’esperienza, un ponte sull’abisso epistemologico tra umano e divino che Paolo, invece, considerava invalicabile senza la sua mediazione apostolica. (pp. 192-193, 202-205)
In definitiva, l’analisi di Bazzana eleva la possessione a chiave ermeneutica unificante per comprendere aspetti apparentemente disparati del cristianesimo paolino e non solo. La stessa logica esperienziale e incarnata che spiega gli esorcismi di Gesù è alla base della cristologia paolina (“in Cristo”), della sua soteriologia (la risurrezione come trasformazione pneumatica), della sua etica (l’azione morale basata sull’incarnazione dello spirito) e persino delle sue direttive liturgiche (il dibattito a Corinto). Questo approccio ricentra lo studio del cristianesimo antico sulla sua dimensione esperienziale, somatica e affettiva, in opposizione a un’enfasi tradizionale sulla dottrina, il testo e la cognizione. La possessione cessa di essere un “problema” da spiegare per diventare la “soluzione” per comprendere la coerenza interna e la forza propulsiva del movimento di Cristo.
Valutazione complessiva: un contributo fondamentale e le prospettive future
Having the Spirit of Christ è un’opera di eccezionale importanza, destinata a lasciare un segno profondo negli studi sul cristianesimo antico. I suoi meriti sono molteplici e significativi. In primo luogo, il rigore metodologico con cui Bazzana utilizza le fonti antropologiche è esemplare. Il suo non è un “saccheggio” di parallelismi esotici, ma un dialogo teorico maturo e controllato, che usa l’etnografia per porre nuove domande ai testi antichi. In secondo luogo, l’originalità esegetica delle sue riletture di pericopi centrali come quelle di Beelzebul, Gerasa e dei capitoli 12-14 di 1 Corinzi è notevole. Bazzana riesce a gettare una luce nuova su testi ampiamente studiati, aprendo prospettive interpretative feconde. Infine, la coerenza argomentativa del volume è impressionante: la tesi centrale sulla possessione come pratica culturale produttiva viene perseguita con tenacia attraverso l’intero libro, creando un ponte inedito e convincente tra i Vangeli e le lettere paoline.
Naturalmente, un’opera di tale ambizione non è esente da interrogativi e potenziali limiti. La forte, e dichiarata, dipendenza dal modello antropologico di Michael Lambek, per quanto metodologicamente rigorosa e feconda, potrebbe in alcuni momenti mettere in ombra la persistente validità di approcci più funzionalisti, come quello di Ioan M. Lewis, nel dar conto delle dinamiche di potere e marginalizzazione che indubbiamente caratterizzavano anche i primi gruppi cristiani. (pp. 10-12, 18) Allo stesso modo, la ricostruzione della “voce” dei Corinzi, per quanto affascinante e necessaria per superare una lettura paolo-centrica, resta un’ipotesi brillante ma costruita ex silentio. La natura stessa delle fonti, che ci restituiscono quasi unicamente la prospettiva dell’apostolo, impone una certa cautela nel considerare definitiva tale ricostruzione, che pure rimane uno degli spunti più stimolanti del volume. (pp. 192-193, 202-205)
Il contributo del libro alla disciplina è duplice. Da un lato, rappresenta un esempio magistrale di come gli studi neotestamentari possano superare il proprio isolazionismo disciplinare, beneficiando di un confronto serio e non superficiale con le scienze umane. (p. 6) Dall’altro, si inserisce a pieno titolo nel filone della critica post-coloniale, contribuendo in modo decisivo alla “provincializzazione” delle categorie occidentali di soggettività, capacità di agire e religione, e mostrando come queste abbiano storicamente condizionato (e limitato) la comprensione dei testi antichi. (pp. 7, 206-207)
Il lavoro di Bazzana non solo offre nuove risposte, ma apre anche nuove e promettenti vie di ricerca. Come cambierebbe, ad esempio, la nostra comprensione degli Atti degli Apostoli, con il suo pneuma onnipresente ma descritto in modo diverso da Paolo, se letto attraverso questa lente? E come interpretare l’apparente assenza di esorcismi nella letteratura giovannea? È un’elisione polemica o il sintomo di una diversa concettualizzazione dell’esperienza spirituale? (p. 210) Inoltre, il modello di Bazzana potrebbe essere proficuamente esteso allo studio di altri fenomeni religiosi nella tarda antichità, arricchendo i dibattiti sulla costruzione del sé, sulla demonologia e sulle pratiche rituali nel giudaismo del Secondo Tempio, nel cristianesimo monastico e nelle scuole filosofiche. (p. 210)
In conclusione, Having the Spirit of Christ non è semplicemente uno studio sulla possessione. È un intervento metodologico di vasta portata che sfida la disciplina a ripensare le proprie fondamenta. Mostrando come l’esperienza incarnata dello spirito fosse al centro della vita, del pensiero e della prassi dei primi gruppi cristiani, Bazzana restituisce ai testi presi in esame una vitalità e una complessità che l’esegesi tradizionale aveva spesso sopito. È un’opera imprescindibile, destinata a diventare un punto di riferimento per chiunque si occupi seriamente dell’esperienza religiosa nel mondo antico.