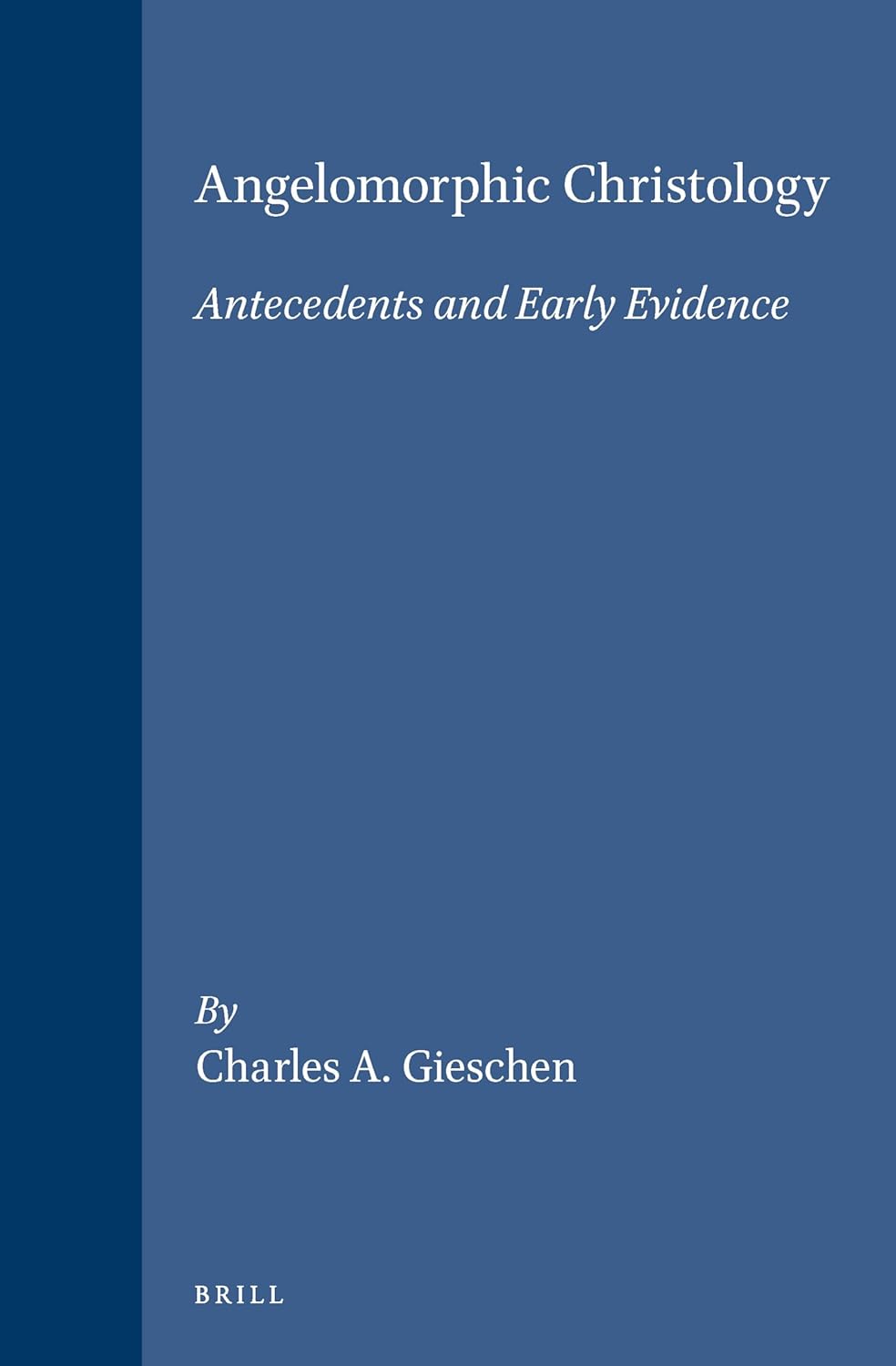Pubblicato nel 1998 dalla prestigiosa casa editrice Brill nella collana “Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums und des Urchristentums”, il volume Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence di Charles A. Gieschen rappresenta uno studio accademico di rara profondità e portata, che ha rimesso profondamente in discussione le fondamenta di decenni di ricerca sulla cristologia delle origini. Con una meticolosità impressionante, Gieschen ha fidato il consenso accademico che aveva a lungo relegato l’identificazione di Cristo con figure angeliche a un fenomeno tardivo, eretico o, nella migliore delle ipotesi, marginale e rapidamente superato dal cristianesimo “ortodosso”. Nel testo l’autore si oppone direttamente a conclusioni perentorie come quella di James Dunn, citata in apertura, secondo cui “nessun autore del Nuovo Testamento ha pensato a Cristo come a un angelo” (p. 3). Gieschen sostiene che questa visione si basa su due fraintendimenti fondamentali: in primo luogo, un’eccessiva attenzione alla mancanza del titolo esplicito “angelo” applicato a Cristo, ignorando una più vasta gamma di descrizioni funzionali e formali; in secondo luogo, un modello evolutivo della cristologia che presuppone uno sviluppo lineare da concezioni “basse” (Gesù come profeta) a concezioni “alte” (Gesù come Figlio preesistente), un modello che Gieschen, sulla scia di Martin Hengel, considera fallace (p. 5).
La tesi centrale del volume, esposta con chiarezza programmatica, è che “le tradizioni angelomorfiche, specialmente quelle derivanti dalle tradizioni dell’Angelo del Signore, ebbero un impatto significativo sulle prime espressioni della cristologia, al punto che l’evidenza di una Cristologia Angelomorfica è discernibile in diversi documenti datati tra il 50 e il 150” (p. 6). Per dimostrare questa affermazione audace, Gieschen costruisce un’argomentazione sistematica in quattro parti: una solida introduzione metodologica, un’analisi enciclopedica degli antecedenti nel pensiero israelitico e giudaico, un esame dettagliato delle prime testimonianze nella letteratura cristiana e una conclusione che ne delinea le profonde implicazioni.
Parte I: Impostazione del problema e strumenti metodologici
La prima parte del libro (pp. 1-47) non è una semplice prefazione, ma una dichiarazione programmatica che funge da fondamento metodologico e intellettuale per l’intera opera. In queste pagine iniziali, l’autore non si limita a introdurre l’argomento, ma costruisce meticolosamente l’apparato concettuale necessario per smantellare un paradigma accademico consolidato e proporne uno alternativo. Gieschen mira a dimostrare che l’approccio tradizionale allo studio delle origini della cristologia è viziato da due “fraintendimenti fondamentali” (p. 4) che hanno sistematicamente sottovalutato o ignorato il ruolo centrale delle tradizioni angelomorfiche giudaiche.
Il primo fraintendimento, secondo Gieschen, è un’eccessiva focalizzazione sulla terminologia esplicita, ovvero sulla constatazione che Cristo non viene quasi mai chiamato “angelo” nei testi del Nuovo Testamento (p. 4). Questo dato, apparentemente incontrovertibile, ha portato studiosi autorevoli come il già citato James Dunn a concludere che l’angelologia non abbia giocato un ruolo significativo nello sviluppo della fede cristologica (p. 3). Gieschen contesta questa conclusione, definendola una “sweeping statement” (p. 3), e introduce il suo concetto chiave: “angelomorfico” (angelomorphic). Questo termine, che Gieschen definisce come “un aggettivo inclusivo che descrive un fenomeno che ha le variegate forme e funzioni di un angelo, anche se la figura potrebbe non essere esplicitamente chiamata ‘angelo’ o considerata avere la natura creata di un angelo” (p. 27), è lo strumento principale per superare questa impasse. Esso sposta l’attenzione dalla mera etichetta (“angelo”) alle caratteristiche funzionali e descrittive. Una figura può essere descritta con attributi angelici – come l’apparire in forma umana, agire come messaggero, mediatore o guerriero divino – senza che questo implichi una sua riduzione a creatura ontologicamente inferiore a Dio. Dopotutto, come Gieschen sottolinea, le stesse Scritture ebraiche presentano casi in cui “Dio e il suo angelo sono equiparati” (p. 4), dimostrando che la forma angelica non preclude la natura divina. Gieschen cita con approvazione il lamento di Christopher Rowland sul fatto che la mancanza di un titolo esplicito abbia “persuaso molti che, se esisteva una cristologia angelica, si trattava semplicemente di un fenomeno periferico” (p. 4).
Il secondo fraintendimento è l’adesione a un modello evolutivo lineare e tardivo per l’alta cristologia (p. 5). Secondo questo modello, la comprensione di Gesù si sarebbe evoluta lentamente, partendo da una concezione “bassa” (Gesù come profeta o messia umano) per arrivare solo alla fine del I secolo a una concezione “alta” (Gesù come Figlio preesistente e divino). Gieschen rigetta categoricamente questo schema, appoggiandosi all’influente tesi di Martin Hengel, secondo cui “nello sviluppo della cristologia è accaduto molto di più durante i primi due decenni dopo la crocifissione di Gesù di quanto non sia avvenuto nei successivi sette secoli” (p. 5). Se si accetta questa prospettiva, la ricerca delle origini della cristologia non deve più tracciare un presunto sviluppo interno al Nuovo Testamento, ma deve piuttosto indagare le “tradizioni formative pre-cristiane israelitiche e giudaiche” (p. 5) che i primi cristiani “adottarono e adattarono” per esprimere la loro comprensione, fin da subito elevata, di Gesù Cristo. In altre parole, la complessità della cristologia primitiva non testimonia tanto “l’inventiva unica dei suoi aderenti”, quanto “la complessità teologica già insita nella religione giudaica contemporanea” (p. 5).
Capitolo 1: Una storia critica della ricerca
Il primo capitolo (pp. 7-25) è una ricostruzione magistrale e critica del dibattito accademico, essenziale per posizionare il contributo di Gieschen. L’autore non si limita a un elenco bibliografico, ma traccia una vera e propria genealogia delle idee. Il punto di partenza è la Scuola Storico-Religiosa (Religionsgeschichtliche Schule) di inizio Novecento, in particolare con l’opera di Wilhelm Bousset. Gieschen riconosce a Bousset il merito di essere stato uno dei primi a documentare estensivamente il concetto di “esseri intermediari” (Mittelwesen) come chiave di volta per comprendere la religione giudaica del periodo (p. 9). Bousset, a differenza dei suoi contemporanei, attinse ampiamente alla letteratura apocrifa, pseudepigrafa e apocalittica, superando la dipendenza quasi esclusiva dalle fonti rabbiniche. Tuttavia, Gieschen ne evidenzia anche i limiti: la tendenza a vedere questo sviluppo come una “degenerazione” del monoteismo e la sua datazione tardiva, influenzata da presunti contatti con i culti imperiali e le religioni orientali (p. 9). A questa visione si oppose la monumentale critica di George Foot Moore, i cui articoli del 1921-22 ebbero un “impatto difficilmente sopravvalutabile” sulla ricerca del XX secolo (p. 11). Moore criticò aspramente l’uso di fonti “non rappresentative” da parte di studiosi cristiani come Bousset, insistendo che il “giudaismo ortodosso” e normativo dell’epoca doveva essere compreso quasi esclusivamente attraverso la letteratura rabbinica (p. 11). Questa posizione, sebbene giustificata in alcuni aspetti, ebbe l’effetto di marginalizzare per decenni lo studio delle tradizioni apocalittiche e mistiche come fonti primarie per la comprensione del contesto del primo cristianesimo.
Gieschen prosegue analizzando il dibattito degli anni ’40. Da un lato, Martin Werner propose la tesi audace che la “Cristologia Angelica” non fosse un’eresia, ma la più antica forma di cristologia cristiana (p. 13). Dall’altro, Wilhelm Michaelis, nel suo Zur Engelchristologie im Urchristentum (1942), sferrò una confutazione così potente e influente da “paralizzare di fatto qualsiasi contributo sostanziale” in questo campo per le generazioni successive (p. 13). L’argomento principale di Michaelis era che la figura messianica, sia nella letteratura giudaica che in quella cristiana, è sempre accuratamente distinta dal rango degli angeli (p. 13). Gieschen osserva che, sebbene questo sia spesso vero, Michaelis non riuscì a cogliere il punto fondamentale: tale distinzione non preclude che la figura messianica possa essere un angelo esaltato e distinto o, per lo meno, descritta in termini angelomorfici (p. 13). L’impatto di questo dibattito fu tale da mettere in ombra persino il lavoro monumentale e meticoloso di Joseph Barbel, Christos Angelos (1941), che documentava la pervasività della cristologia angelica nella letteratura cristiana dal II al IV secolo (p. 14).
La rassegna si conclude con l’emergere di quella che Gieschen, citando Hengel, definisce la “Nuova Scuola Storico-Religiosa” (p. 21). Questa nuova ondata di ricerca, emersa negli ultimi decenni del XX secolo, è caratterizzata da un rinnovato interesse per le fonti giudaiche non rabbiniche e da una maggiore apertura a riconoscere la diversità e la complessità del pensiero giudaico del I secolo. Gieschen situa il proprio lavoro all’interno di questa corrente, dialogando con studiosi come:
- Christopher Rowland, i cui studi pionieristici sulla visione di Ezechiele 1 hanno evidenziato lo sviluppo di una tradizione su un “angelo esaltato” che rappresenta una sorta di “biforcazione di Dio” (p. 18).
- Alan Segal, la cui opera Two Powers in Heaven ha dimostrato, attraverso l’analisi della polemica rabbinica, che la credenza in una seconda figura divina accanto a Dio era una corrente teologica reale e combattuta all’interno del giudaismo (p. 20).
- Jarl Fossum, che ha approfondito le tradizioni sul Nome divino e sull’Angelo del Signore, collegandole alle origini della gnosi e mostrando la loro influenza sulla cristologia del Nuovo Testamento (p. 20).
- Larry Hurtado, che, pur essendo più cauto sull’idea di un “binitarismo” giudaico anteriore alla nascita del cristianesimo, ha sottolineato l’importanza delle tradizioni giudaiche sull'”agente divino” e ha identificato nell’adorazione cultuale di Gesù il tratto distintivo e la “mutazione” decisiva del monoteismo giudaico da parte dei primi cristiani (p. 21).
Capitolo 2: Il motore eetodologico: nomenclatura e criteri
Se il primo capitolo traccia la mappa del territorio intellettuale, il secondo (pp. 26-47) fornisce la bussola e gli strumenti per navigarlo. È qui che Gieschen costruisce il suo apparato metodologico con una precisione quasi chirurgica. Innanzitutto, stabilisce una nomenclatura rigorosa per i gruppi religiosi, utilizzando “Giudaismo” come un termine generico che comprende una varietà di “Giudaismi” (fariseismo, essenismo, cristianesimo primitivo, ecc.), evitando così l’errore anacronistico di considerare il rabbinismo come l’unico erede legittimo del giudaismo del Secondo Tempio (p. 26).
La parte più innovativa del capitolo è la definizione dei cinque “criteri di divinità” (pp. 30-33). Riconoscendo che il solo criterio del culto è insufficiente per cogliere le sfumature dei testi antichi, l’autore propone un approccio multifattoriale per valutare lo status di una figura mediatrice:
- Posizione Divina: Questo criterio si concentra sulla prossimità al centro del potere divino: il trono. Sedere sul trono di Dio, o su un trono accanto ad esso (come suggerito dalla menzione di “troni” in Daniele 7,9), è un indicatore primario di status divino (p. 31). Al contrario, “stare in piedi” è la postura tipica degli angeli e dei giusti glorificati. Gieschen nota però delle ambiguità, come nel caso di Stefano che vede Gesù “stare in piedi” alla destra di Dio (Atti 7,55-56), una postura che potrebbe significare più di un semplice status angelico (p. 31).
- Apparenza Divina: Una figura può essere considerata divina se la sua descrizione fisica riprende quella delle teofanie di Dio. Gieschen elenca esempi specifici: la figura umana con un torso di metallo incandescente e una parte inferiore di fuoco, circondata da un arcobaleno, come la Gloria in Ezechiele 1,26-28; o la figura con vesti bianche come la neve e capelli come lana pura, come l’Antico di Giorni in Daniele 7,9 (p. 32). Include anche la dimensione gigantesca, collegandola alla mistica dello Shi’ur Qomah (“Misura del Corpo [Divino]”) (p. 32).
- Funzioni Divine: Questo criterio distingue tra le funzioni angeliche comuni (proteggere, punire, fare da messaggero) e le prerogative unicamente divine, come “creare il mondo, assolvere i peccati e pronunciare il giudizio escatologico” (p. 32). L’attribuzione di queste ultime a un mediatore è un forte indicatore del suo status divino.
- Nome Divino: Il possesso del Nome sacro di Dio (YHWH) è un criterio di importanza capitale. Poiché nell’antico pensiero semitico il nome esprime l’essenza, “il possesso del Nome divino dovrebbe essere inteso come la condivisione della piena autorità ed essenza di YHWH” (p. 33). Il testo fondativo per questa idea è Esodo 23,21, dove Dio dice del suo angelo: “il mio Nome è in lui”.
- Venerazione Divina: Pur non essendo l’unico criterio, la venerazione rimane fondamentale. Gieschen, dialogando con la ricerca di Stuckenbruck e Arnold, esplora le diverse forme che questa poteva assumere: non solo l’adorazione esplicita, ma anche “l’invocazione di angeli per assistenza”, la “riverenza” verso di loro e le “espressioni di ringraziamento” (p. 34). Esamina anche i contesti che potevano favorire questa pratica, come i momenti di angoscia o le esperienze di ascesa celeste (p. 35).
Infine, Gieschen affronta di petto il termine più spinoso: “ipostasi” (hypostasis) (pp. 36-45). Ne ricostruisce la complessa storia, a partire dal suo uso nella filosofia greca e nel dogma trinitario cristiano, dove finì per indicare le “persone” della Trinità (p. 37). Ne analizza l’adozione nella ricerca biblica da parte di Bousset (per indicare esseri intermediari astratti) e di Ringgren (per indicare la “quasi-personificazione” di attributi divini) (pp. 37-39). Dedica ampio spazio alle critiche, in particolare quelle di Hurtado, che considera il concetto di ipostasi una sovrainterpretazione di ciò che sarebbe in realtà solo un “vivido idioma” o una “personificazione” letteraria (p. 41). Gieschen mostra la debolezza di questa posizione riduttiva, evidenziando come persino l’esempio di “personificazione” portato da Hurtado (la figura della Penitenza in Giuseppe e Aseneth) sia in realtà descritto nel testo con tutti i tratti di un angelo (p. 42). Dopo aver soppesato attentamente le argomentazioni, Gieschen propone la sua definizione ponderata, accompagnata da sei “avvertenze” per un uso corretto del termine (p. 45). Un’ipostasi, per Gieschen, è “un aspetto della divinità che è rappresentato con un grado variabile di personalità indipendente” (p. 45). Questa definizione è cruciale perché permette di riconoscere l’autonomia con cui figure come la Sapienza, la Gloria o il Nome agiscono in certi testi, senza recidere il loro legame essenziale con la divinità unica da cui provengono. Evita così sia il riduzionismo della “mera personificazione” sia le trappole del politeismo, offrendo uno strumento analitico flessibile e adeguato alla complessità dei testi.
Con questo solido arsenale metodologico, Gieschen è pronto a immergersi nell’analisi degli antecedenti, avendo preparato il lettore non solo a ciò che cercherà nei testi, ma anche a come lo interpreterà.
Parte II: Gli antecedenti nel giudaismo del Secondo Tempio
La seconda parte del saggio (pp. 49-183) è il cuore pulsante della sua argomentazione. È in questa sezione monumentale che l’autore assembla, con una pazienza da archeologo, i “mattoni” concettuali e teologici che, a suo dire, costituiranno la materia prima per la costruzione della cristologia angelomorfica nel cristianesimo primitivo. L’obiettivo non è proiettare retroattivamente categorie cristiane su testi giudaici, ma piuttosto dimostrare la preesistenza, la complessità e la disponibilità di un ricco patrimonio di tradizioni su figure mediatrici divine all’interno del pensiero israelitico e giudaico, molto prima dell’avvento di Gesù. Gieschen si propone di mappare questo paesaggio teologico per rendere comprensibile, e persino logicamente conseguente, l’emergere di una cristologia che descrive Cristo con tratti e funzioni angeliche di altissimo rango.
Capitolo 3: Un Dio angelomorfico – Le radici nella teofania
L’indagine di Gieschen inizia dalle radici più antiche e profonde della teologia israelitica: la figura enigmatica dell’“Angelo del Signore” (מלאך יהוה) (pp. 51-69). Questa figura, lungi dall’essere un semplice messaggero, rappresenta una delle sfide esegetiche più complesse dell’Antico Testamento. Gieschen evidenzia come questa entità “non si comporti come nessun altro messaggero conosciuto nel regno divino o umano” (p. 52), poiché i racconti che lo vedono protagonista omettono le caratteristiche tipiche dell’attività di un messaggero per presentare invece attività che si associano direttamente a YHWH.
L’autore identifica due filoni principali e apparentemente contraddittori all’interno di queste tradizioni. Il primo, e probabilmente il più antico, è quello dell’indistinguibilità tra l’Angelo e Dio stesso. In numerose narrazioni chiave, l’Angelo è la manifestazione visibile e udibile di YHWH, un modo in cui la divinità trascendente si rende immanente senza che la sua essenza venga compromessa.
- Nell’incontro con Agar nel deserto (Genesi 16), è l'”Angelo di YHWH” a trovarla e a parlarle, ma lo fa usando la prima persona divina (“Io moltiplicherò grandemente la tua discendenza”), e Agar, nella sua reazione, non ha dubbi: “Così lei chiamò il nome di YHWH che le aveva parlato, ‘Tu sei un El di visione'”, esprimendo la sua meraviglia per essere sopravvissuta dopo aver visto Dio (p. 58).
- L’episodio della lotta di Giacobbe al guado dello Iabbok (Genesi 32) è ancora più esplicito. L’avversario è inizialmente descritto come “un uomo”, ma la natura divina dell’incontro è inequivocabile: conferisce a Giacobbe un nuovo nome, Israele (“colui che contende con Dio”), si rifiuta di rivelare il proprio nome (un tratto tipico della divinità), e Giacobbe stesso commemora l’evento chiamando il luogo Peniel (“volto di Dio”), perché, dice, “ho visto Elohim faccia a faccia, e la mia vita è stata preservata” (p. 60). Gieschen rafforza questa interpretazione citando Osea 12,3-4, in cui il profeta, rievocando l’episodio, usa in parallelo i termini “Elohim” e “angelo”, fondendoli in un’unica identità (p. 61).
- La narrazione che precede la nascita di Sansone (Giudici 13) rappresenta, secondo l’autore, una sintesi matura di queste tradizioni. La figura divina è descritta con una gamma di titoli intercambiabili: “Angelo di YHWH”, “uomo di Dio” e semplicemente “l’uomo”. La sua apparenza è “terribile” e sovrumana (p. 61). Quando Manoach gli chiede il nome, la risposta è elusiva e carica di significato: “Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso” (p. 62), un aggettivo spesso associato a Dio. L’incontro culmina con l’ascensione dell’Angelo nella fiamma del sacrificio, una teofania in piena regola che lascia Manoach con la terrificante certezza: “Moriremo sicuramente, perché abbiamo visto Elohim” (p. 62).
Accanto a questo filone dell’identità, Gieschen ne individua un secondo, quello della distinguibilità qualificata, il cui testo fondativo è Esodo 23,20-21. Qui, Dio promette di inviare un angelo davanti a Israele. Questo angelo è chiaramente distinto da Dio (“Io invio un angelo…”), ma non è un semplice subordinato. Possiede un’autorità divina senza precedenti perché, come Dio stesso dichiara, “il mio Nome è in lui” (כי שמי בקרבו) (p. 66). Viene sottolineata l’importanza capitale di questa affermazione. Nel pensiero antico, il nome non è un’etichetta, ma l’espressione dell’essenza e del potere di qualcuno. Avere il Nome di Dio “dentro di sé” significa essere un’estensione della personalità di YHWH, possederne la piena autorità divina, inclusa la prerogativa di perdonare o non perdonare le trasgressioni (p. 67). Questo testo, secondo Gieschen, fornisce il modello teologico per una concezione di un essere che è al contempo distinto da Dio e partecipe della sua divinità. Sarà questo modello dell’Angelo-portatore-del-Nome a diventare centrale nelle speculazioni successive su figure mediatrici come Metatron e, in ultima analisi, per la cristologia stessa (p. 67).
Capitolo 4: Le ipostasi divine angelomorfiche
Se il capitolo precedente ha stabilito la radice teofanica, il quarto capitolo (pp. 70-122) esplora come questa tendenza a visualizzare la presenza divina si sia estesa a specifici attributi di Dio, che vengono personificati e ipostatizzati fino ad assumere tratti angelomorfici.
- Il Nome (שם) (pp. 70-78): Gieschen dimostra come il “Nome di YHWH” evolva da una semplice designazione a una vera e propria ipostasi. Nella “Teologia del Nome” deuteronomistica, Dio risiede nei cieli, ma il suo Nome “dimora” (לשכן) o è “posto” (לשום) nel santuario terrestre come sua rappresentanza e punto di contatto cultuale (pp. 71-73). In altri contesti, il Nome diventa un agente cosmogonico: “Il nostro aiuto è nel Nome di YHWH, che ha fatto cielo e terra” (Salmo 124:8) (p. 74). Questa idea viene sviluppata in testi come Giubilei e 1 Enoc 69, dove un Giuramento/Nome segreto è responsabile della creazione e del mantenimento dell’universo (p. 75). La fusione decisiva avviene quando questa teologia del Nome si combina con l’angelologia di Esodo 23. Il Nome ipostatizzato non è più solo una presenza nel tempio, ma può essere “incarnato” in una figura angelica, che diventa così il suo portatore. Ciò apre la porta a speculazioni su quale angelo sia questo portatore del Nome: Michele, Gabriele, o figure ancora più esaltate come Yahoel e Metatron (p. 77).
- La Gloria (כבוד) (pp. 78-88): La “Gloria di YHWH” è forse l’ipostasi più visiva e influente. Gieschen ne traccia lo sviluppo da una manifestazione aniconica e atmosferica – la nuvola e il fuoco che guidano Israele nell’Esodo (p. 79) e che riempiono il Tabernacolo (Esodo 40,34) (p. 80) – a una figura pienamente antropomorfa. Sebbene già in Esodo 33 si parli del “dorso” di Dio, suggerendo una forma umana (p. 81), è la visione inaugurale di Ezechiele a rappresentare un punto di non ritorno. Sul trono celeste, il profeta vede “una figura con l’aspetto di un uomo” (דמות כמראה אדם), che il testo stesso identifica come “l’aspetto della somiglianza della Gloria di YHWH” (Ezechiele 1,26-28) (p. 82). Questa è, per Gieschen, una rivelazione sconvolgente: la Gloria di Dio, la sua stessa presenza manifesta, ha forma umana e siede sul trono divino. Questa immagine diventerà il locus classicus per tutta la successiva mistica della Merkavah (il carro-trono divino). Gieschen evidenzia inoltre un altro sviluppo fondamentale in Ezechiele 8, dove questa stessa figura-Gloria appare separata dal trono e agisce come un angelus interpres, trasportando il profeta in visione. Questo dimostra la sua capacità di agire come un mediatore angelico autonomo (pp. 83-84). Tale tradizione della Gloria antropomorfa sul trono sfocia direttamente nella visione di Daniele 7, in cui, accanto all’Antico di Giorni, appare “uno simile a un figlio d’uomo”. La presenza di questa seconda figura divina sul trono (o accanto ad esso) fu così problematica da generare, come documentato da Alan Segal, la controversia rabbinica sulle “Due Potenze in Cielo” (p. 85), una polemica contro coloro che, secondo i rabbini, professavano l’esistenza di un secondo dio.
- Altre Ipostasi (pp. 89-122): Gieschen completa il quadro analizzando altre ipostasi. La Saggezza è una figura preesistente che assiste Dio nella creazione (Proverbi 8), sta accanto al suo trono (Sapienza 9,4) (p. 93) ed è associata all’Angelo del Signore (p. 98). La Parola (Dabar), specialmente nella forma del Memra aramaico nei Targumim, agisce come un’ipostasi che media le azioni di Dio nel mondo, spesso sostituendo YHWH nelle descrizioni antropomorfiche e venendo identificata con l’Angelo del Signore (p. 112). Anche lo Spirito e la Potenza sono analizzati come concetti che, in certi contesti, acquisiscono una personalità quasi indipendente e sono descritti con tratti angelici (pp. 116, 119).
Capitoli 5 e 6: I vertici dell’angelologia e la deificazione umana
Gli ultimi due capitoli di questa sezione esplorano le vette più alte raggiunte da queste speculazioni, mostrando come la linea di demarcazione tra angelo e Dio, e persino tra umano e divino, potesse diventare estremamente sottile.
- Capitolo 5: I principali angeli nominati (pp. 124-151): Gieschen analizza le tradizioni riguardanti i grandi arcangeli, che non sono semplici funzionari celesti, ma veri e propri viceré divini. Michele è il principe celeste di Israele, un guerriero e sommo sacerdote celeste (p. 126). Gabriele è l’angelo della rivelazione e del giudizio. Figure ancora più significative per la tesi di Gieschen sono Yahoel e Metatron. Yahoel, nell’Apocalisse di Abramo, è un angelo il cui nome stesso è una combinazione teoforica (Yaho-El) e che viene esplicitamente identificato come l’angelo di Esodo 23, il mediatore in cui risiede il Nome ineffabile di Dio (p. 142). Metatron, nella mistica successiva (in particolare 3 Enoc), raggiunge l’apice di questa esaltazione: è chiamato “il piccolo YHWH”, siede su un trono simile a quello di Dio e funge da plenipotenziario del cielo (p. 146). Queste figure dimostrano che il pensiero giudaico poteva concepire un essere angelico che condivideva il nome, il trono e le funzioni di Dio.
- Capitolo 6: Umani angelomorfici (pp. 152-183): L’ultimo passo di questa traiettoria è l’angelificazione o deificazione di figure umane. Gieschen documenta una tradizione diffusa in cui patriarchi, profeti o sacerdoti eccezionali vengono elevati a uno status celeste.
- Enoc è l’esempio paradigmatico: rapito in cielo, viene trasformato in un essere celeste, e in alcune versioni della tradizione (come in 2 Enoc o in sezioni di 1 Enoc) viene identificato con il Figlio dell’Uomo o diventa l’angelo Metatron (p. 156).
- Mosè è un’altra figura oggetto di un’intensa esaltazione. Gieschen analizza le tradizioni, presenti in Filone e soprattutto in Ezechiele il Tragico, che descrivono l’ascensione di Mosè al cielo, dove riceve le insegne regali e si siede sul trono di Dio, con le stelle che si prostrano davanti a lui (p. 163).
- Melchisedec, la misteriosa figura sacerdotale di Genesi 14, viene reinterpretato nel frammento di Qumran 11QMelchizedek come un essere celeste, un elohim, che presiede il giudizio finale alla fine dei tempi, compiendo così una funzione tipicamente divina (p. 171).
- Questo schema di esaltazione, nota Gieschen, si estende anche a re davidici, descritti come “l’angelo di Dio” (p. 175), e persino agli apostoli nella letteratura cristiana successiva (p. 176).
Parte III: Le prime testimonianze nella letteratura cristiana
Dopo aver meticolosamente assemblato il vasto e complesso apparato di antecedenti giudaici nella seconda parte del suo saggio, Charles A. Gieschen dedica la terza e più corposa sezione (pp. 185-346) alla dimostrazione della sua tesi centrale. Qui, il “materiale grezzo” teologico – l’Angelo del Signore, le ipostasi divine, gli arcangeli esaltati e gli umani angelomorfici – viene mostrato in azione, applicato e riorientato cristologicamente da una vasta gamma di autori cristiani primitivi. L’approccio di Gieschen non è una superficiale “caccia ai paralleli” (parallelomania), un metodo che egli stesso critica (p. 46), ma una dimostrazione sistematica di come interi complessi di idee, o “costellazioni teologiche”, siano stati impiegati per dare forma e sostanza alla nascente comprensione della persona e dell’opera di Gesù Cristo. Prima di immergersi nei testi del I secolo, Gieschen offre un capitolo introduttivo (Capitolo 7) che funge da ponte, mostrando come la cristologia angelomorfica fosse una corrente viva e vitale nella letteratura cristiana del II e III secolo, con figure come Giustino Martire, Tertulliano e Origene che identificavano esplicitamente Cristo con l’Angelo del Signore delle Scritture ebraiche (pp. 187-199). Questa corrente, sostiene, fu messa a tacere e spinta ai margini solo a seguito delle controversie ariane del IV secolo, che imposero una distinzione ontologica più rigida e resero problematico l’uso del titolo “angelo” per Cristo.
Le testimonianze esplicite: I testi “sub-apostolici” e apocrifi
Seguendo una logica espositiva che va dal più esplicito al più implicito, Gieschen inizia la sua analisi con opere cristiane non canoniche, dove le connessioni con l’angelologia giudaica sono spesso più dirette e meno velate.
- Gli Pseudo-Clementini (Capitolo 8, pp. 201-213): In questo complesso corpus giudeo-cristiano, la cristologia ruota attorno alla figura del “Vero Profeta”. L’autore dimostra come questa figura sia un amalgama di diverse tradizioni relative a figure mediatrici. Il Vero Profeta è identificato con Adamo primordiale e, cosa ancora più significativa, con la Gloria di Dio, l’ipostasi antropomorfa vista da Ezechiele (p. 202). Egli è anche la manifestazione della Saggezza e dello Spirito preesistenti (p. 205). Le identificazioni più dirette emergono quando il Vero Profeta è descritto come il “Capo degli Arcangeli” (p. 209) e, infine, come lo stesso “Angelo del Signore” che guidò Israele (p. 211). Questa letteratura, sebbene tarda nella sua forma finale, è per Gieschen una finestra su una cristologia giudeo-cristiana arcaica che fondeva senza soluzione di continuità la figura di Cristo con le più alte figure mediatrici del giudaismo.
- Il Pastore di Erma (Capitolo 9, pp. 214-228): Quest’opera, notoriamente difficile da interpretare, è un altro testo chiave per la tesi di Gieschen. La cristologia è complessa e intrecciata con la pneumatologia e l’ecclesiologia. La figura centrale è il Figlio di Dio, che appare sotto diverse forme angelomorfiche. Nella Quinta Similitudine, il Figlio è lo Spirito Santo preesistente che ha dimorato nella carne di Gesù. Tuttavia, l’auotre si concentra sulla Nona Similitudine, dove il Figlio di Dio è un “uomo glorioso” e di statura immensa che costruisce la torre (la Chiesa). Egli sostiene che questa figura attinge direttamente alle tradizioni sull’angelo principale e dimostra che, per Erma, “il Figlio è l’Angelo del Signore, il Nome e la Gloria” (p. 225). Il Figlio è “l’angelo glorioso” e “venerabile” che sostiene l’intera creazione, un ruolo che va ben oltre quello di un semplice angelo e che lo colloca nella categoria del mediatore cosmico.
- L’Ascensione di Isaia (Capitolo 10, pp. 229-244): Questo apocrifo cristiano del II secolo offre forse la più chiara espressione di una cosmologia e di una cristologia angelomorfica. Nella sezione visionaria, il profeta ascende attraverso i sette cieli. Nel settimo cielo, egli vede la “Grande Gloria” (Dio Padre) e, seduti su troni alla sua destra e alla sua sinistra, due figure gloriose. Queste sono identificate come il “Diletto” (il Cristo preesistente) e l’“Angelo dello Spirito Santo” (pp. 231, 236). Gieschen vede in questa scena una diretta cristianizzazione delle tradizioni giudaiche su due angeli principali o due ipostasi divine (come i due cherubini sull’Arca o le figure di Michele e Gabriele). La natura angelomorfica di Cristo è ulteriormente sottolineata durante la sua discesa (katabasis) attraverso i cieli per incarnarsi: ad ogni livello, egli si trasforma per assumere l’aspetto degli angeli di quel cielo, un motivo classico di mimetismo angelico (p. 236). È fondamentale notare che sia il Diletto sia l’Angelo dello Spirito sono oggetto di adorazione da parte degli angeli del settimo cielo, soddisfacendo così uno dei criteri di divinità di Gieschen (p. 241).
L’evidenza nel Nuovo Testamento: L’adattamento cristologico
Il cuore dell’argomentazione di Gieschen risiede nella dimostrazione che queste stesse categorie teologiche sono operative, sebbene talvolta in modo più sottile, all’interno dei testi canonici del Nuovo Testamento.
- L’Apocalisse di Giovanni (Capitolo 11, pp. 245-269): Il libro dell’Apocalisse e è, per Gieschen, un terreno fertile per la cristologia angelomorfica. La visione inaugurale del Cristo risorto in Apocalisse 1 lo descrive come “uno simile a un figlio d’uomo”. Gieschen analizza meticolosamente ogni dettaglio di questa figura – i capelli bianchi come lana, gli occhi come fiamma di fuoco, i piedi come bronzo splendente, la voce come il fragore di molte acque – e dimostra come questi tratti siano un mosaico composito, attingendo direttamente alla descrizione dell’Antico di Giorni in Daniele 7 e a quella della Gloria antropomorfa in Ezechiele 1 (p. 246). Cristo, quindi, non è semplicemente “come” il figlio d’uomo, ma è una figura che assorbe in sé le caratteristiche delle due supreme manifestazioni divine dell’apocalittica giudaica. Inoltre, in Apocalisse 10, Cristo appare come un “angelo potente” (angelos ischyros). La descrizione è cosmica e teofanica: è avvolto in una nuvola, con un arcobaleno sul capo, il volto come il sole e i piedi come colonne di fuoco (p. 256). Per l’autore, questa non è una creatura angelica subordinata, ma Cristo stesso che si manifesta in una forma angelica di suprema maestà e autorità cosmica, come indicato dalla sua postura con un piede sul mare e uno sulla terra. Infine, Gieschen esplora il ruolo di Cristo come portatore della Parola e del Nome divini (Apocalisse 19), in cui il cavaliere celeste è chiamato “La Parola di Dio” e porta un nome segreto che nessuno conosce, riecheggiando le tradizioni sull’Angelo del Nome (p. 252).
- Il Vangelo secondo Giovanni (Capitolo 12, pp. 270-293): Gieschen sostiene che la cristologia giovannea, spesso interpretata attraverso una lente ellenistica, è profondamente radicata nel patrimonio delle ipostasi giudaiche. Il Logos di Giovanni 1 non è primariamente il Logos filosofico degli stoici, ma la sintesi e l’incarnazione della Parola (Dabar/Memra), del Nome e della Gloria (Kabod) di Dio (p. 271). L’affermazione “il Logos si fece carne e pose la sua tenda (eskēnōsen) in mezzo a noi, e noi contemplammo la sua gloria” (Giovanni 1,14) è un riferimento diretto alla “Teologia della Gloria” e alla “Teologia del Nome”, secondo cui la presenza di Dio (la sua Shekhinah) dimorava nel Tabernacolo. Gesù è colui che rivela il Nome del Padre perché egli stesso è il portatore del Nome divino, l’Angelo di Esodo 23 incarnato. Anche il titolo “Figlio dell’Uomo” in Giovanni è interpretato da Gieschen alla luce delle tradizioni mistiche e apocalittiche. Quando Gesù dice: “vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo” (Giovanni 1,51), si presenta come il mediatore cosmico, la Scala di Giacobbe personificata, il nesso tra cielo e terra, una concezione pienamente angelomorfica (p. 280).
- L’Epistola agli Ebrei (Capitolo 13, pp. 294-314): A prima vista, l’Epistola agli Ebrei sembra argomentare contro una cristologia angelica, affermando la superiorità del Figlio sugli angeli. Gieschen, tuttavia, mostra con un’analisi sottile che l’autore di Ebrei combatte una visione “bassa” degli angeli, ma lo fa utilizzando proprio le categorie dell’esaltazione angelomorfica per descrivere Cristo. Il Figlio è superiore perché ha ereditato un “nome più eccellente” (Ebrei 1,4), un’eco diretta della tradizione del Nome divino (p. 295). Egli è “irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza” (Ebrei 1,3), un linguaggio che lo identifica con l’ipostasi della Gloria (p. 295). Il punto culminante dell’argomentazione di Gieschen riguarda la figura di Melchisedec. L’autore di Ebrei stabilisce il sacerdozio di Cristo “secondo l’ordine di Melchisedec”. Gieschen dimostra, sulla base di testi come 11QMelchizedek, che Melchisedec era già concepito nel giudaismo del Secondo Tempio come una figura celeste, quasi divina, un elohim che presiede al giudizio. Elevando Cristo a questo ordine, Ebrei lo inserisce in una tradizione di mediazione sacerdotale angelomorfica di altissimo rango (p. 307).
- Le Epistole Paoline (Capitolo 14, pp. 315-346): Infine, Gieschen affronta il corpus paolino, dimostrando come la sua cristologia sia intrisa di queste categorie, spesso date per scontate.
- Cristo è identificato direttamente con le ipostasi divine: è “la Potenza di Dio e la Saggezza di Dio” (1 Corinzi 1,24) (p. 331).
- La connessione con la Gloria è centrale. In 2 Corinzi 4,4-6, Cristo è l’“immagine di Dio” (eikōn tou theou), e nel suo volto risplende la conoscenza della “gloria di Dio” (p. 333). Questa concezione dell’immagine e della gloria, secondo Gieschen, non è astratta, ma si riferisce alla figura antropomorfa della Gloria vista da Ezechiele sul trono divino.
- La figura dell’“uomo celeste” in 1 Corinzi 15, contrapposto all’uomo terrestre Adamo, è un riferimento diretto alle tradizioni giudaiche sull’Adamo primordiale glorioso o sull’Enoc esaltato, che diventa una figura angelica celeste (p. 329).
- L’inno cristologico di Filippesi 2 culmina con Dio che dona a Gesù “il Nome che è al di sopra di ogni altro nome”. Gieschen interpreta questo non come un semplice titolo onorifico, ma come il conferimento del Nome divino stesso (YHWH/Kyrios), ponendo Cristo nel ruolo dell’Angelo del Nome che riceve la massima esaltazione e la venerazione universale (p. 337).
- L’autore esamina anche passaggi più enigmatici, come 1 Corinzi 10,4, in cui la “roccia spirituale” che seguiva Israele nel deserto è identificata con Cristo, e Giuda 5-7, dove alcune varianti testuali attribuiscono a “Gesù” il ruolo di salvatore e distruttore di Israele nell’Esodo, funzioni tipiche di YHWH o del suo Angelo (p. 325). Questi testi suggeriscono una tradizione che vedeva il Cristo preesistente attivo nella storia di Israele, proprio nel ruolo dell’Angelo del Signore.
Conclusione e implicazioni: La riscoperta di una via maestra della cristologia primitiva
Nella sua breve ma densa conclusione (pp. 349-351), Charles A. Gieschen tira le somme del suo imponente lavoro, non limitandosi a riassumere i risultati, ma delineando le profonde implicazioni che la sua ricerca comporta per lo studio delle origini cristiane. La tesi, dimostrata attraverso un’analisi capillare di centinaia di testi, emerge con una forza quasi lapidaria: la Cristologia Angelomorfica non fu, come si è a lungo pensato, un’aberrazione marginale, un’eresia giudeo-cristiana destinata a soccombere, o un prodotto tardo di sincretismi fantasiosi. Al contrario, essa rappresentò una delle vie maestre e più antiche attraverso cui i primi cristiani, attingendo a un ricco e variegato patrimonio teologico giudaico, articolarono la loro fede nella divinità di Gesù e nella sua relazione unica con Dio Padre. L’impatto di questa conclusione è di vasta portata, poiché costringe a una radicale riconsiderazione delle narrazioni tradizionali sullo sviluppo della cristologia.
Il contributo più significativo e duraturo del lavoro di Gieschen è forse il suo attacco frontale al modello evolutivo che ha dominato per decenni gli studi cristologici. Questo modello presupponeva uno sviluppo lineare da una cristologia “bassa” – in cui Gesù era visto principalmente come un profeta o un messia umano – a una cristologia “alta”, in cui gli venivano attribuiti preesistenza e statuto divino. Gieschen rovescia questa prospettiva, dimostrando che i mattoni per costruire una “alta cristologia” non solo erano già disponibili nel giudaismo del Secondo Tempio, ma erano anche ampiamente utilizzati per descrivere figure mediatrici supreme. Le sue analisi nella seconda parte del libro hanno dimostrato l’esistenza di un robusto quadro teologico che includeva:
- Un Dio che poteva manifestarsi in forma angelica e umana, come testimoniato dalle tradizioni sull’Angelo del Signore (pp. 51-69).
- Ipostasi divine come la Gloria, la Saggezza e il Nome, che agivano come agenti quasi-indipendenti di Dio, spesso con sembianze antropomorfiche (pp. 70-122).
- Arcangeli supremi, come Metatron o Yahoel, che portavano il Nome divino, sedevano su un trono e fungevano da viceré celesti (pp. 142-148).
- Tradizioni consolidate su umani angelomorfici, come Enoc e Mosè, che venivano esaltati a uno status quasi divino dopo la loro vita terrena (pp. 156-167).
Alla luce di questo vasto repertorio, l’alta cristologia del Nuovo Testamento non appare più come un’invenzione radicale o un’importazione da contesti ellenistici (come i culti degli imperatori), ma come l’applicazione coerente e creativa a Gesù di un modello teologico preesistente. I primi cristiani, per dare un senso alla loro esperienza del Cristo risorto e alla sua relazione con il Padre, non dovettero creare dal nulla le categorie di preesistenza, mediazione nella creazione, condivisione del trono e del Nome divino. Trovarono queste categorie già pronte e vibranti all’interno della loro stessa eredità giudaica. Il genio del primo pensiero cristiano, suggerisce Gieschen, non fu tanto l’invenzione, quanto l’identificazione: riconoscere in Gesù di Nazaret la realizzazione ultima e l’incarnazione di quella figura mediatrice suprema che il giudaismo aveva a lungo contemplato e descritto.
Un’altra implicazione fondamentale del lavoro di Gieschen riguarda la “genealogia delle idee” teologiche. La sua metodologia storico-tradizionale non si limita a giustapporre testi, ma ricostruisce il percorso di specifici complessi di idee attraverso i secoli. Ad esempio, egli mostra in modo convincente come l’immagine della Gloria di YHWH (כבוד) nasca nelle teofanie aniconiche del Pentateuco, acquisisca una forma umana e regale sul trono nella visione di Ezechiele (p. 82), si sviluppi ulteriormente nella figura del “Figlio dell’Uomo” di Daniele (p. 85), e venga infine applicata sistematicamente a Cristo nell’Apocalisse di Giovanni e nelle epistole di Paolo (pp. 246, 333). Questa meticolosa ricostruzione dimostra che le descrizioni cristologiche non sono metafore isolate, ma il punto di arrivo di una lunga e coerente traiettoria teologica. Gieschen sostiene che alla radice di molte di queste “cristologie” (Saggezza, Spirito, Nome, Gloria, Figlio dell’Uomo) si trovi la tradizione fondamentale dell’Angelo del Signore, l’archetipo della manifestazione visibile di Dio (p. 5).
La forza del saggio risiede nella sua solidità metodologica, delineata nella prima parte. L’introduzione del termine “angelomorfico” si rivela uno strumento analitico potente, capace di superare le sterili dispute ontologiche (p. 28). Ancora più importanti sono i suoi cinque “criteri di divinità” (Posizione, Apparenza, Funzioni, Nome, Venerazione) (pp. 30-33), che forniscono un quadro robusto per analizzare lo status delle figure mediatrici, andando oltre il solo, e talvolta ambiguo, criterio del culto. Questa chiarezza metodologica permette a Gieschen di navigare con sicurezza un corpus di testi estremamente eterogeneo, identificando schemi e connessioni che altrimenti rimarrebbero invisibili.
Le implicazioni della ricerca di Gieschen si estendono anche al nostro modo di comprendere la relazione tra giudaismo e cristianesimo e le successive controversie teologiche. In primo luogo, il suo lavoro è un potente correttivo alla tendenza, ereditata da una certa storiografia, di considerare il giudaismo del Secondo Tempio attraverso la lente restrittiva del successivo giudaismo rabbinico “normativo”. Gieschen dimostra in modo inequivocabile che la letteratura apocalittica e mistica non era un fenomeno marginale, ma una fucina di idee teologiche creative che hanno nutrito direttamente il pensiero cristiano primitivo. In secondo luogo, il suo studio offre una nuova prospettiva sulla controversia ariana del IV secolo. Invece di vedere l’arianesimo come una semplice deviazione filosofica, l’opera in esame suggerisce che esso possa essere compreso come una riproposizione tardiva e radicalizzata di questa antichissima tradizione di cristologia angelomorfica, in cui il Figlio, pur essendo un mediatore divino ed esaltato, era visto come una creatura ontologicamente subordinata al Padre (p. 7). La reazione nicena, in quest’ottica, non fu solo una formulazione dogmatica, ma anche l’atto finale di soppressione di una tradizione cristologica che era stata, per secoli, una via legittima e feconda.
In definitiva, “Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence” è un’opera di erudizione straordinaria, destinata a rimanere un punto di riferimento imprescindibile. Sebbene la sua densità e il suo rigore la rendano una lettura impegnativa, adatta a un pubblico specialistico, la sua importanza non può essere sottovalutata. Gieschen non solo presenta una tesi provocatoria e ben argomentata, ma offre anche un modello di ricerca storico-religiosa che ricostruisce la genealogia delle idee con una coerenza ammirevole. Per chiunque si occupi seriamente delle origini del cristianesimo, della letteratura del Secondo Tempio o della complessa e affascinante continuità teologica tra giudaismo e cristianesimo, il libro di Gieschen è un contributo fondamentale che sfida le narrazioni consolidate e apre nuove, feconde prospettive di ricerca.
Per chi volesse acquistare il volume https://amzn.to/44k9rSw