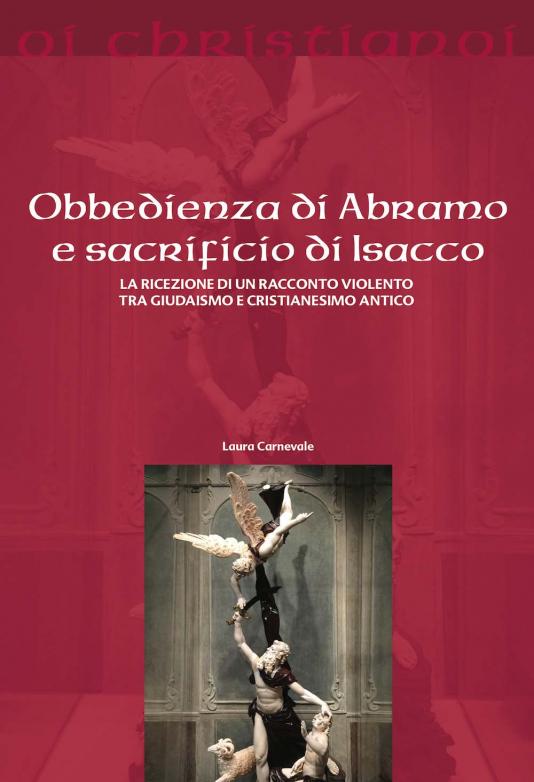Introduzione: un’indagine sulla ricezione di un racconto violento
Nel panorama degli studi sulla storia del cristianesimo e del giudaismo antico, il volume di Laura Carnevale, Obbedienza di Abramo e sacrificio di Isacco: La ricezione di un racconto violento tra giudaismo e cristianesimo antico (Il pozzo di Giacobbe, 2020), si presenta come un contributo di notevole interesse. L’opera si inserisce nel solco della Überlieferungsgeschichte, o storia della ricezione, un approccio storiografico che indaga le trasformazioni di un testo attraverso le sue letture e interpretazioni nel tempo (p. 12). L’oggetto di questa meticolosa indagine è il ventiduesimo capitolo del libro della Genesi, una narrazione che l’autrice definisce fin da subito “intensa e inquietante nella sua violenta solennità” (p. 9).
La tesi centrale che anima l’intero lavoro è che la carica violenta e paradossale della ‘aqedah – la “legatura” di Isacco – non sia mai stata completamente neutralizzata dalle sue innumerevoli riletture. Al contrario, proprio i suoi “picchi tragici” e la sua apparente assenza di scopo hanno generato una perenne tensione ermeneutica (p. 9). Secondo Carnevale, questa tensione è stata la forza motrice che ha spinto giudaismo e cristianesimo a confrontarsi incessantemente con il testo, trasformandolo in un racconto fondativo per lo sviluppo di dottrine soteriologiche decisive. Il volume si propone di ricostruire come la ‘aqedah abbia nutrito il theologoumenon secondo cui “il sacrificio di un singolo arriva a garantire la redenzione di un’intera collettività” (p. 12). La violenza del testo, quindi, non è un ostacolo da superare, ma il motore stesso della sua ricchezza teologica. È proprio la difficoltà etica e concettuale del comando divino – un ordine che contraddice la promessa e che appare fine a se stesso – a creare un vuoto di significato che ogni tradizione successiva si è sentita in dovere di colmare, generando così una complessa e stratificata storia della ricezione.
Per condurre questa indagine, l’autrice adotta una metodologia rigorosamente diacronica, diatopica e interdisciplinare, analizzando un “fronte ampio e variegato di fonti, prevalentemente – ma non unicamente – testuali” (p. 12). La struttura del libro riflette questo approccio, articolandosi in quattro capitoli che guidano il lettore in un percorso logico e progressivo. Si parte dalle origini e dalla composizione del testo biblico, per poi esplorare la sua ricezione nel giudaismo del Secondo Tempio e rabbinico, analizzare la costruzione della tipologia cristologica nel cristianesimo antico, e infine approdare alla “spazializzazione del sacro”, ovvero all’ancoraggio iconografico e topografico del racconto nella geografia sacra di Gerusalemme e non solo (pp. 11-12).
Capitolo primo: alle origini di un testo inquietante
Il primo capitolo del volume è dedicato a un’analisi del testo di Genesi 22, esplorandone la complessa genesi redazionale e il contesto culturale in cui affonda le radici. Carnevale muove dalla constatazione che il racconto, pur essendo un capolavoro narrativo, presenta numerose aporie e stratificazioni che ne tradiscono una lunga e complessa storia compositiva (p. 16).
Analisi testuale di Genesi 22
L’autrice prende le mosse dalla classica ipotesi documentaria, che attribuiva il racconto prevalentemente alla fonte “Elohista”, per poi superarla a favore di modelli più recenti che riconoscono nel testo la fusione di blocchi narrativi indipendenti (pp. 18-19). Vengono distinti almeno tre livelli redazionali: uno strato più antico, di carattere eziologico-cultuale, legato alla fondazione di un santuario; un secondo livello, di natura liturgica, che esprime la condanna del sacrificio di bambini e la sua sostituzione con il riscatto o l’obbedienza; e infine un livello più tardo, agiografico, che rilegge l’episodio come prova suprema della fede di Abramo (pp. 19-20). Questa stratificazione spiega le incongruenze presenti nel testo, come l’uso di nomi divini differenti (‘Elohim e YHWH), la problematica assenza di Isacco al momento del ritorno di Abramo a Bersabea (Gen 22,19), e le significative discrepanze lessicali tra le versioni antiche (pp. 21, 35).
Particolare attenzione è dedicata all’analisi comparata delle diverse versioni del testo: il Testo Masoretico ebraico, la traduzione greca dei Settanta (LXX), la Vetus Latina e la Vulgata di Gerolamo. Una delle divergenze più signific(ative riguarda l’identificazione del luogo del sacrificio. Mentre il Testo Masoretico ordina ad Abramo di recarsi nella “terra di Moria” (′eretz hammōriyyāh), la versione dei LXX, cronologicamente anteriore, riporta un più generico “terra elevata” (gēhypsēlē) (p. 24). Carnevale, seguendo l’ipotesi di Hermann Gunkel, sostiene che l’introduzione del toponimo “Moria” sia un intervento redazionale tardo, posteriore alla stesura del Secondo Libro delle Cronache, dove il Monte Moria è esplicitamente identificato con il sito del Tempio di Gerusalemme (2Cr 3,1) (pp. 25-27). Questa modifica non è un semplice dettaglio topografico, ma un’operazione teologica di grande portata: essa collega retroattivamente la vicenda fondativa del patriarca al luogo più sacro del giudaismo, conferendo al Tempio un’ulteriore e significativa legittimazione sacrale.
Contestualizzazione storica: il sacrificio di figli nel Mediterraneo
La seconda parte del capitolo situa il racconto di Genesi 22 nel più ampio contesto culturale dei sacrifici di bambini nel bacino del Mediterraneo antico (p. 35). L’autrice passa in rassegna un’ampia mole di testimonianze testuali, epigrafiche e archeologiche, dimostrando come tale pratica fosse diffusa in area fenicio-punica (il rito del molk), cananaica e persino giudaica, come attestato da numerose condanne profetiche e da episodi biblici quali il sacrificio della figlia di Iefte (Gdc 11,29-39) (pp. 36-43). L’analisi si estende poi al mondo greco-romano, con i celebri miti di Ifigenia e Idomeneo (pp. 43-47).
Questa vasta comparazione non serve a ridurre la narrazione biblica a una semplice variante di un topos culturale, ma, al contrario, a metterne in luce la specifica unicità. Mentre i sacrifici pagani e cananaici sono quasi sempre di natura utilitaristica – un “dare per avere” (p. 13) volto a placare una divinità, vincere una guerra o salvare una collettività – il comando imposto ad Abramo è, come sottolinea Carnevale fin dall’introduzione, “priva di scopo, fine a se stessa” (p. 9). Non solo non serve a un obiettivo concreto, ma contraddice la promessa divina della discendenza, apparendo come un atto teologicamente paradossale. È proprio questa assenza di una logica transazionale a rappresentare una significativa evoluzione teologica: il sacrificio viene spogliato della sua funzione strumentale per diventare una pura e terribile prova della relazione tra l’uomo e Dio, un dramma fondato unicamente sull’obbedienza e sulla fede.
Capitolo secondo: la ‘aqedah nel pensiero giudaico, dall’obbedienza del padre al merito del figlio
Nel secondo capitolo, Carnevale traccia l’evoluzione dell’interpretazione della ‘aqedah all’interno del giudaismo, mostrando un progressivo spostamento del baricentro ermeneutico dall’obbedienza del padre alla partecipazione consapevole e al merito salvifico del figlio. Questo processo, che si intensifica dopo la distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C., trasforma la ‘aqedah in un pilastro della teologia e dell’identità giudaica (p. 49).
Il giudaismo del Secondo Tempio
L’analisi prende avvio dalla letteratura giudaica intertestamentaria, dove emergono i primi, significativi ampliamenti del racconto biblico.
- Nel Libro dei Giubilei (II sec. a.C.), la ‘aqedah è esplicitamente definita come la decima e ultima “prova” di Abramo. Per risolvere la difficoltà teologica di un Dio che tenta al male, la responsabilità dell’ordine viene attribuita a un’entità terza, il “principe Mastema”, che agisce da accusatore celeste, in un chiaro parallelismo con il prologo del libro di Giobbe (pp. 51-52). Il testo, inoltre, colloca l’evento il 15 di Nisan, giorno dei sacrifici pasquali, e lo localizza sul “Monte Sion”, fondando così un legame indissolubile tra la ‘aqedah, la Pasqua e il culto del Tempio di Gerusalemme (pp. 52-53).
- Il Quarto Libro dei Maccabei (I sec. d.C.) segna un passaggio significativo: in un contesto influenzato dallo stoicismo, dove il martirio acquista valore espiatorio per i peccati di Israele, Isacco è presentato come il protomartire per eccellenza. Egli non è più una vittima passiva, ma un giovane che accetta consapevolmente e coraggiosamente il proprio destino. È questo consenso a rendere il suo sacrificio meritorio e a spostare l’attenzione dalla fede del padre alla volontarietà del figlio (pp. 53-54).
- Questa tendenza è confermata e sviluppata da altri testi. Lo Pseudo Filone (Liber Antiquitatum Biblicarum) sottolinea il consenso “gioioso” e “festante” di Isacco, il cui sangue versato (anche se solo metaforicamente) diventa il fondamento dell’elezione di Israele (pp. 56-58).
- Filone Alessandrino interpreta l’episodio in chiave allegorica e filosofica, esaltando l’imperturbabilità (apatheia) stoica di Abramo e definendolo un “sacerdote” (hiereus) che offre una vittima perfetta (pp. 60-62).
- Flavio Giuseppe, infine, consolida questa tradizione specificando l’età di Isacco a venticinque anni, rendendolo così un co-protagonista pienamente responsabile dell’atto di obbedienza (p. 64).
Il giudaismo rabbinico
L’analisi di Carnevale prosegue con la letteratura rabbinica, dove le interpretazioni precedenti vengono sistematizzate e arricchite di nuovi dettagli narrativi (aggadah).
- L’esegesi targumica: Le parafrasi aramaiche della Bibbia, come il Targum Neofiti e lo Pseudo Yonathan, introducono elementi che diventeranno canonici: Isacco, ormai trentasettenne, chiede esplicitamente al padre di legarlo saldamente, per timore che un movimento involontario possa invalidare il sacrificio, rendendolo imperfetto (pp. 72, 75). In alcune versioni, Isacco riceve una visione celeste, mentre Abramo prega che il merito (zechut) di questo atto sia ricordato per le generazioni future come fonte di perdono per i peccati di Israele (p. 73).
- L’esegesi midrashica: Testi come Genesi Rabbah e i Pirqei de-Rabbi Eliezer portano a compimento questa evoluzione (pp. 78-81). La ‘aqedah viene saldamente collegata alla liturgia di Rosh ha-Shanah (il corno dell’ariete diventa lo shofar) e di Yom Kippur (il giorno dell’Espiazione). Vengono introdotte tradizioni ancora più audaci: Satana (Samael) tenta di dissuadere padre e figlio lungo il cammino; Isacco muore di spavento alla vista del coltello e viene immediatamente risuscitato; le sue ceneri vengono simbolicamente raccolte e poste sotto l’altare del Tempio come perenne memoriale di espiazione (pp. 78, 81-82).
In questa evoluzione, Carnevale individua una profonda risposta teologica a un trauma storico. La distruzione del Tempio nel 70 d.C. aveva privato il giudaismo del suo centro rituale e del principale mezzo di espiazione nazionale: il sacrificio animale. L’esegesi rabbinica, elevando la ‘aqedah a sacrificio per eccellenza – un atto perfetto proprio perché spiritualmente compiuto anche se fisicamente sospeso – ha di fatto creato una nuova base per la teologia dell’espiazione. Il “merito di Isacco” e le “ceneri di Isacco” divennero una sorta di capitale spirituale, un tesoro a cui il popolo di Israele poteva attingere attraverso la preghiera e la memoria liturgica, sostituendo così il culto templare perduto. La ‘aqedah divenne un sacrificio portatile, fondato sulla narrazione e sulla memoria, un atto di notevole resilienza religiosa di fronte a una catastrofe storica.
Capitolo terzo: Isacco e Gesù, la costruzione di una tipologia “nuova”?
Il terzo capitolo è dedicato alla complessa e stratificata ricezione cristiana di Genesi 22, un processo che trasforma la ‘aqedah in una delle più importanti prefigurazioni (typos) del sacrificio di Cristo. Carnevale naviga con perizia il dibattito storiografico sull’origine di questa interpretazione, propendendo per l’idea che la teologia cristiana non abbia creato ex nihilo il valore soteriologico della ‘aqedah, ma abbia attinto a un theologoumenon già presente e circolante nel giudaismo del Secondo Tempio, riorientandolo in chiave cristologica (pp. 83-85).
Le radici neotestamentarie
L’autrice osserva una “apparente reticenza” nei testi del Nuovo Testamento, dove le allusioni a Genesi 22 sono più implicite che esplicite (p. 86). Questa reticenza, tuttavia, non indica un disinteresse, ma piuttosto la notorietà del racconto e del suo significato, che non necessitava di essere spiegato in dettaglio.
- L’apostolo Paolo è la figura centrale. In Romani 8,32 (“Egli che non risparmiò il proprio figlio, ma lo diede per tutti noi”), Carnevale individua un’appropriazione diretta della grammatica teologica della ‘aqedah (Gen 22,16, “non mi hai rifiutato tuo figlio, l’unico tuo”) per spiegare l’azione salvifica di Dio Padre (pp. 86-87). Il sacrificio di Cristo è presentato come il compimento di ciò che il sacrificio di Isacco aveva solo adombrato.
- La Lettera agli Ebrei presenta Abramo come un exemplum fidei, la cui obbedienza si fonda sulla fede nella risurrezione, una convinzione che gli permette di offrire il figlio sapendo che “Dio è capace di far risorgere anche dai morti” (Eb 11,17-19) (p. 89).
- La Lettera di Giacomo, in polemica con una certa interpretazione del paolinismo, rovescia la prospettiva, citando la ‘aqedah come prova che Abramo fu giustificato “per le opere” e non “solo dalla fede” (Gc 2,21-24) (pp. 89-90).
L’elaborazione patristica
È con i Padri della Chiesa che la tipologia Isacco-Cristo viene sviluppata in modo sistematico e teologicamente denso.
- Un momento di svolta è rappresentato da Melitone di Sardi (II sec.), che introduce un’innovazione davvero importante. Nei suoi frammenti, non solo Isacco (che porta la legna come Cristo porta la croce) è typos di Cristo, ma anche l’ariete assume un ruolo tipologico distinto (p. 95). Melitone sottolinea che “Cristo soffrì, Isacco invece non soffrì” (Fr. IX) (p. 95). L’ariete, impigliato nel cespuglio (figura della croce) e immolato al posto di Isacco, diventa la prefigurazione della natura umana di Cristo, che soffre e muore, mentre Isacco, risparmiato, prefigura la sua natura divina, che rimane impassibile. Questa lettura segna un punto di divergenza fondamentale rispetto all’esegesi giudaica, che insisteva sulla completezza spirituale del sacrificio di Isacco; per Melitone, la sua incompletezza fisica è essenziale per preservare l’unicità del sacrificio di Cristo, l’unico realmente compiuto e salvifico (pp. 96-97).
- Questa duplice tipologia viene ripresa e approfondita da autori successivi. Tertulliano vede nell’ariete impigliato per le corna (cornibus) una prefigurazione di Cristo coronato di spine e appeso alle estremità (cornua) della croce (p. 99). Origene, nella sua ottava omelia sulla Genesi, sistematizza questa interpretazione in modo organico: Isacco, che non muore, è figura del Logos-Dio, mentre l’ariete, che viene ucciso, è figura di Cristo-uomo (p. 107). Ambrogio di Milano e Agostino di Ippona consolidano questa tradizione esegetica in Occidente, arricchendola di dettagli allegorici e utilizzandola in chiave pastorale e antigiudaica (pp. 110-116). Agostino, in particolare, nel Contro Fausto manicheo, offre una testimonianza preziosa della diffusione di questa narrazione, ricordando che era “cantata in tante lingue e dipinta in tanti luoghi” (p. 114).
Capitolo quarto: la spazializzazione del sacro, dall’altare al luogo santo
L’ultimo capitolo del volume esplora una dimensione importante e talvolta trascurata della ricezione: la “spazializzazione del sacro” (p. 131). Carnevale dimostra come l’appropriazione di un racconto biblico non si limiti alla sua interpretazione testuale, ma implichi anche il suo ancoraggio a luoghi fisici, che vengono così investiti di una nuova e potente sacralità. La ricerca del luogo dell’altare di Abramo diventa un processo dinamico di costruzione di memorie collettive e di mappe mentali.
L’iconografia come esegesi visiva
Prima di affrontare la topografia, l’autrice analizza la ricezione iconografica della ‘aqedah, intesa come una forma di esegesi visiva.
- Gli affreschi della sinagoga di Dura Europos (III sec. d.C.) rappresentano una delle sue più antiche testimonianze visive. La scena si concentra sull’obbedienza di Abramo e sull’intervento divino (la mano di Dio che ferma il coltello), offrendo una narrazione fedele alla comprensione giudaica dell’episodio come prova di fede superata (pp. 136-138).
- Il mosaico pavimentale della sinagoga di Beth Alpha (VI sec. d.C.) presenta una raffigurazione unica, in cui l’ariete è mostrato legato a un albero da una cordicella rossa (p. 139). Carnevale discute la duplice interpretazione di questa immagine: da un lato, potrebbe riflettere l’influenza dell’iconografia cristiana, dove l’ariete appeso all’albero è un chiaro typos di Cristo sulla croce. Dall’altro, potrebbe essere un’illustrazione di tradizioni rabbiniche, come quelle presenti nei Targumim, secondo cui l’ariete, creato alla vigilia del primo sabato, era stato “tenuto in serbo” e legato fino al momento del sacrificio (pp. 139-140). Questo caso emblematico mostra la complessità e la potenziale permeabilità delle tradizioni visive giudaiche e cristiane.
La costruzione dei luoghi santi
Il cuore del capitolo è dedicato alla localizzazione dell’altare del sacrificio, un processo che rivela strategie identitarie e polemiche. Ogni tradizione abramitica ha ancorato l’evento al proprio centro sacro, rivendicandone l’eredità.
- Giudaismo: Come già emerso nel primo capitolo, la tradizione giudaica identifica in modo definitivo il monte Moria con il Monte del Tempio a Gerusalemme. La ‘aqedah diventa così l’evento sacrificale fondativo che precede e legittima tutti i sacrifici che verranno offerti sul sito più sacro del giudaismo (p. 142).
- Islam: La tradizione islamica opera una duplice traslazione. Il figlio del sacrificio viene identificato non con Isacco ma con Ismaele, capostipite del popolo arabo. Di conseguenza, il luogo dell’evento viene spostato da Gerusalemme alla Mecca, presso la Ka’ba. Questo atto di ri-localizzazione è fondamentale per fondare la narrazione nella geografia sacra dell’Islam (pp. 146-148).
- Cristianesimo: La tradizione cristiana compie un’operazione ancora più complessa e audace. Carnevale la ricostruisce attraverso le testimonianze dei pellegrini dei secoli IV-VI. Mentre la tradizione giudaica legava l’altare al Tempio, i pellegrini cristiani, come l’Anonimo di Bordeaux (333) e Egeria (fine IV sec.), iniziano a localizzare l’altare del sacrificio di Isacco non più sul Monte del Tempio, ma sul Golgota, in prossimità del Santo Sepolcro (pp. 149-152). Il Breviarius de Hierosolyma (ca. 530) è esplicito: l’altare di Abramo si trova nello stesso luogo della crocifissione (p. 152). Questa “translatio mnemostorica” (p. 155) è un atto teologico di grande portata: il typos (l’altare di Isacco) viene fisicamente collocato accanto all’antitypos (la croce di Cristo). In questo modo, la geografia sacra di Gerusalemme viene riscritta in chiave cristiana, subordinando la narrazione giudaica a quella della passione di Cristo e stabilendo il Santo Sepolcro come nuovo “ombelico del mondo”. Questo processo non è una semplice devozione, ma una vera e propria appropriazione polemica dello spazio sacro, in cui la competizione per l’eredità di Abramo si manifesta sulla mappa stessa della Città Santa.
Conclusione: un’eredità condivisa e contesa
In conclusione, il lavoro di Laura Carnevale si rivela un’indagine accurata e di estremo interesse. La sua analisi illustra come il racconto della ‘aqedah abbia funzionato come un “giacimento culturale” condiviso da giudaismo e cristianesimo (p. 158). Per i primi due secoli dell’era volgare, le frontiere interpretative erano porose, e le tradizioni si sviluppavano in un dialogo, spesso implicito, e in un contesto di mutua permeabilità. È solo a partire dalla seconda metà del II secolo, con il progressivo consolidarsi delle rispettive identità, che le letture iniziano a divergere in modo più netto, cristallizzandosi in narrazioni teologiche distinte e, a tratti, apertamente polemiche (p. 159).
Il volume offre un contributo storiografico di rilievo, non solo per la sua sintesi di un vasto corpus di fonti, ma soprattutto per la sua capacità di illustrare, attraverso un caso di studio esemplare, i complessi meccanismi di formazione delle identità religiose. Carnevale mostra come queste identità non nascano in un vuoto, ma si costruiscano attraverso la continua reinterpretazione, appropriazione e, talvolta, contesa dei testi fondativi.
Obbedienza di Abramo e sacrificio di Isacco è, pertanto, un’opera di riferimento per gli studiosi della ricezione biblica, delle relazioni giudeo-cristiane e della storia delle religioni abramitiche. Con un approccio rigoroso e chiaro, l’autrice mostra come un “racconto violento” sia potuto diventare una pietra angolare della fede, dell’identità e della soteriologia per milioni di persone, e come la sua significativa eredità continui, ancora oggi, a essere un patrimonio tanto condiviso quanto conteso (p. 161).
Il pregio maggiore del volume di Laura Carnevale risiede nella sua capacità di orchestrare una narrazione storiografica complessa e multiforme, governando con sicurezza una mole imponente di fonti testuali, iconografiche e materiali. L’approccio interdisciplinare permette all’autrice di non limitarsi a una semplice rassegna di interpretazioni, ma di svelare l’incessante lavorio ermeneutico che ha trasformato un racconto biblico in un pilastro teologico per diverse tradizioni religiose. Il contributo più significativo dell’opera è la dimostrazione di come la ricezione non sia un processo passivo, bensì un’arena dinamica di appropriazione, risemantizzazione e, talvolta, di aperta contesa. Carnevale illustra in modo efficace come le identità religiose si definiscano non solo attraverso l’esegesi, ma anche mediante la costruzione di geografie sacre e la visualizzazione del racconto, in un dialogo costante tra testo, immagine e territorio. Superando una visione lineare dei rapporti tra giudaismo e cristianesimo, il saggio mette in luce una fase iniziale di osmosi e un successivo, progressivo irrigidimento delle frontiere interpretative, offrendo così un modello di analisi valido per comprendere più ampi fenomeni di interazione culturale e religiosa. Ne risulta un’opera solida e ben argomentata, che si qualifica come uno strumento prezioso non solo per gli specialisti della Bibbia e della patristica, ma per chiunque sia interessato a comprendere le radici profonde e le complesse dinamiche di sviluppo delle religioni abramitiche.
Per chi volesse acquistare il volume: https://amzn.to/4mjLbWF