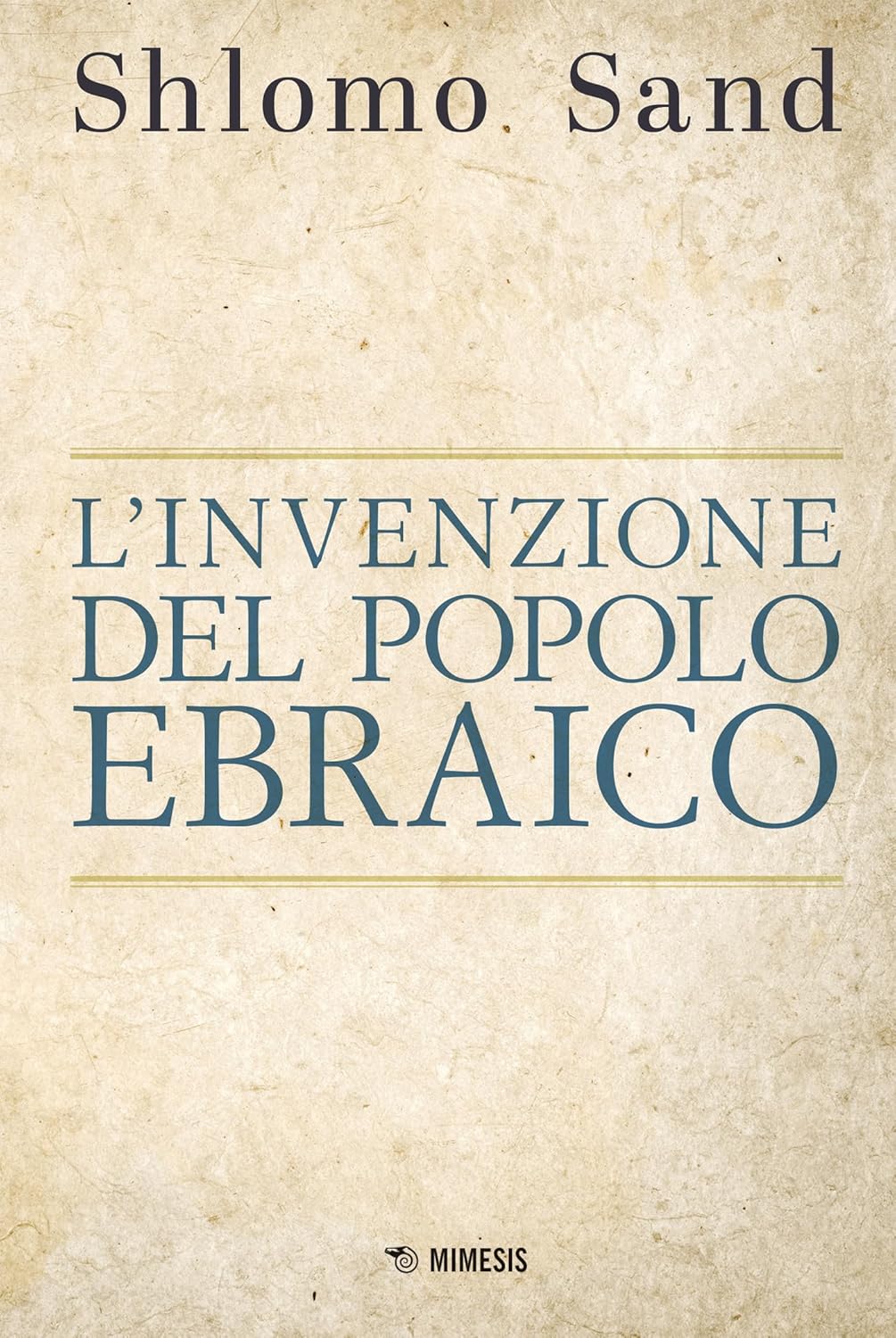Shlomo Sand, L’invenzione del popolo ebraico, traduzione di Elisa Carandina, Rizzoli, Milano, 2010 (Riedito da Mimesis nel 2024)
Lo storico come iconoclasta
Pochi saggi storici recenti hanno generato un dibattito tanto acceso e polarizzato quanto L’invenzione del popolo ebraico di Shlomo Sand. Pubblicato originariamente in ebraico nel 2008, il volume si è rapidamente imposto all’attenzione internazionale, venendo acclamato da storici di fama come Eric Hobsbawm e Tony Judt come un’opera fondamentale e coraggiosa, e al contempo denunciato da numerosi accademici come un pamphlet politicamente motivato e storicamente inaccurato. Il libro si presenta come un atto di iconoclastia intellettuale, il cui scopo dichiarato è smantellare sistematicamente quelli che Sand considera i miti fondativi del nazionalismo ebraico e, di conseguenza, le basi ideologiche su cui poggia lo Stato d’Israele.
La tesi centrale di Sand è tanto semplice nella sua formulazione quanto radicale nelle sue implicazioni: il “popolo ebraico”, inteso come un ethnos continuo e omogeneo, con un’origine biologica comune e una storia ininterrotta di esilio dalla propria patria, non è una realtà storica millenaria, bensì un’invenzione del XIX secolo. Secondo l’autore, gli ebrei contemporanei non discendono dagli antichi abitanti della Giudea, ma sono in gran parte i discendenti di popolazioni eterogenee convertitesi all’ebraismo nel corso dei secoli, tra cui i Berberi in Nord Africa, gli Himyariti nella penisola arabica e, soprattutto, i Cazari nel Caucaso, da cui deriverebbe la maggior parte degli ebrei ashkenaziti. Eventi cardine della memoria collettiva, come l’esilio imposto dai Romani nel 70 d.C., vengono declassati a mito, una narrazione creata a posteriori senza alcuna base in un evento di deportazione di massa.
Questa recensione si propone di offrire una valutazione critica ed equilibrata del saggio di Sand. Ne verranno riconosciuti i meriti indiscutibili, in particolare la capacità di applicare le moderne teorie sul nazionalismo a una storia spesso trattata come eccezionale e di portare alla luce fenomeni storici fondamentale, come il proselitismo, a lungo trascurati. Allo stesso tempo, verranno analizzate criticamente la metodologia dell’autore, il suo utilizzo delle fonti e la sua impostazione polemica. Il filo conduttore di questa analisi, la filigrana che la percorre, sarà l’esplorazione della tensione fondamentale tra l’invenzione di una narrazione nazionale e la forza storica duratura della memoria collettiva e dell’autopercezione di un popolo. Si argomenterà che, sebbene le narrazioni possano essere costruite, la coscienza di un popolo è ben più di un mero costrutto teorico che può essere semplicemente “liquidato”.
Decostruire la nazione – l’impalcatura teorica di Sand
Applicazione delle teorie sul nazionalismo
Il punto di forza metodologico de L’invenzione del popolo ebraico risiede nell’applicazione sistematica della scuola di pensiero “costruttivista” allo studio della storia ebraica. Sand attinge esplicitamente alle opere di studiosi come Ernest Gellner e Benedict Anderson per sostenere che la nazione non è un’entità primordiale e organica, ma un prodotto della modernità. Secondo questa prospettiva, sono le necessità dello Stato moderno – un’economia industriale, un sistema educativo di massa, una cultura omogenea – a generare il nazionalismo, il quale a sua volta “inventa” le nazioni, dotandole di un passato glorioso, di un’origine comune e di una continuità storica spesso fittizia.
Sand applica questo schema al caso ebraico, sostenendo che intellettuali ebrei del XIX secolo, in particolare storici come Heinrich Graetz, influenzati dal nazionalismo romantico tedesco, abbiano retroattivamente proiettato le categorie moderne di nazione e razza su comunità religiose antiche e medievali, trasformando la storia di una fede nella storia di un ethnos. Il pregio di questo approccio è innegabile. Rifiutando di considerare la storia ebraica come sui generis e analizzandola invece attraverso la stessa lente critica utilizzata per gli altri nazionalismi, Sand compie un’operazione intellettualmente necessaria, in linea con l’appello di Marcel Detienne a “denazionalizzare le storie nazionali”. Questo permette di demistificare narrazioni date per scontate e di interrogare le fondamenta ideologiche della storiografia tradizionale.
Il popolo come fatto storico, non solo costrutto teorico
Tuttavia, è proprio nell’applicazione di questo quadro teorico che emerge una delle principali debolezze del saggio. L’analisi di Sand, a tratti, appare eccessivamente meccanicistica, quasi deterministica. Se è corretto affermare che la narrazione nazionalista e l’ideologia dello Stato-nazione ebraico siano invenzioni del XIX secolo, l’autore sottovaluta la potenza e la realtà storica delle materie prime pre-nazionaliste su cui tale invenzione si è innestata. La costruzione non è avvenuta ex nihilo.
Il modello costruttivista di Sand fatica a spiegare perché l'”invenzione” del popolo ebraico sia stata così straordinariamente efficace e abbia trovato una risonanza così profonda in comunità tanto disparate geograficamente e culturalmente. La risposta risiede in un potente senso di collettività preesistente, una “peoplehood” (o coscienza di popolo) forgiata nel corso di secoli di storia condivisa, che, pur non essendo una nazione moderna, era infinitamente più di una semplice affiliazione religiosa. Mentre Sand vede un’invenzione quasi totale, un’analisi più attenta rivela piuttosto un processo di modernizzazione e nazionalizzazione di un’identità collettiva preesistente.
Questa coscienza di popolo si fondava su elementi concreti e condivisi che trascendevano i confini geografici: una tradizione testuale comune e centrale (la Bibbia, il Talmud), una lingua liturgica e di studio condivisa (l’ebraico), un calendario rituale unificante e, soprattutto, una memoria collettiva strutturata attorno a un paradigma di creazione, rivelazione, esilio e redenzione. In particolare, la profonda e interiorizzata coscienza del Galut (esilio) ha funzionato per secoli come un potentissimo collante identitario. Questi elementi hanno creato un senso tangibile e trans-regionale di appartenenza a un’entità collettiva distinta, che gli intellettuali del XIX secolo non hanno inventato dal nulla, ma hanno reinterpretato secondo le nuove categorie del nazionalismo. L’errore di Sand sta nel non distinguere adeguatamente tra l’antico senso di popolo e la nazione moderna, finendo per liquidare il primo come una mera finzione ideologica anziché riconoscerlo come una potente forza storica a se stante.
La “mitostoria” delle origini – una critica alla narrazione biblica
La Bibbia come “mitostoria”
Una parte considerevole del saggio è dedicata alla decostruzione della Bibbia come libro di storia. Sand sostiene, correttamente, che il testo biblico non possa essere letto come una cronaca fattuale e affidabile del passato. Egli analizza la storicità di quelli che definisce “miti fondativi” – le narrazioni sui patriarchi, l’Esodo dall’Egitto, la conquista di Canaan e la monarchia unita di Davide e Salomone – e conclude, in linea con il consenso della moderna ricerca biblica e archeologica, che si tratta di costruzioni letterarie e teologiche elaborate in epoche successive, prive di conferme extrabibliche o archeologiche significative.
Il pregio di questa sezione non risiede tanto nell’originalità delle scoperte, quanto nella sua efficacia come opera di divulgazione. Sand rende accessibile a un vasto pubblico decenni di ricerca accademica specialistica, sfidando con forza la lettura fondamentalista della Bibbia che ancora oggi informa in modo significativo la narrazione nazionale popolare e il sistema educativo in Israele. In questo senso, il suo lavoro svolge una funzione critica essenziale, costringendo a un confronto con la discrepanza tra il mito nazionale e l’evidenza storica.
Critica di un “uomo di paglia”
È qui, tuttavia, che si manifesta una delle più significative critiche mosse al metodo di Sand, in particolare dallo storico Israel Bartal. Sand presenta le sue conclusioni come una rivelazione rivoluzionaria di verità a lungo soppresse da una “storiografia sionista” monolitica, dogmatica e disonesta, che avrebbe deliberatamente nascosto le prove per sostenere il mito di una continuità etnica e di un esilio di massa. Bartal e altri critici sostengono che questa rappresentazione sia un “uomo di paglia” (straw man): la storiografia ebraica e sionista, in realtà, è sempre stata molto più complessa, sfaccettata e critica di quanto Sand voglia far credere.
L’aspetto più paradossale è che la prova di questa critica si trova all’interno del libro stesso di Sand. La sua analisi è minata da una profonda contraddizione interna. Da un lato, la sua cornice polemica necessita di un avversario semplice e dogmatico da demolire. Dall’altro, i capitoli in cui ricostruisce la storia della storiografia ebraica moderna documentano meticolosamente proprio il contrario. Sand stesso mostra come Isaak Markus Jost, pioniere della storiografia ebraica moderna, escludesse deliberatamente il periodo biblico dalla sua analisi. Descrive in dettaglio le posizioni sfumate e in evoluzione di Heinrich Graetz, le cui inclinazioni protonazionaliste si svilupparono nel tempo. Analizza le complesse teorie di Simon Dubnow e Salo Baron, che avevano visioni tutt’altro che semplicistiche della diaspora e delle conversioni. Cita persino i padri della storiografia sionista gerosolimitana, Yitzchaq Baer e Ben Zion Dinur, i quali, ben consapevoli dell’assenza di un esilio di massa sotto i Romani, posticiparono l’inizio del “vero” Galut alla conquista araba del VII secolo.
In breve, Sand documenta con perizia un campo di studi diversificato e internamente conflittuale, per poi concludere affermando di aver demolito un dogma monolitico che la sua stessa ricerca dimostra non essere mai esistito in quella forma semplicistica. Questa dissonanza rivela una tensione irrisolta tra Sand lo storico, che porta alla luce la complessità, e Sand il polemista, che ha bisogno di un avversario caricaturale per affermare il carattere rivoluzionario della propria opera. L’impatto del libro deriva quindi non solo dalla sostanza delle sue argomentazioni, ma anche da una cornice retorica che travisa deliberatamente la storia del dibattito che lo ha preceduto.
Il mito dell’esilio e la realtà della conversione
Decostruzione dell’esilio romano
L’argomento forse più noto e dirompente del libro è la negazione dell’esilio di massa del popolo giudeo per mano dei Romani dopo la distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C. Sand sostiene che questa narrazione sia un mito di origine cristiana, concepito per presentare l’evento come una punizione divina per il rifiuto di Gesù, e solo in seguito adottato dalla tradizione ebraica stessa. La sua contro-narrazione afferma che la maggior parte della popolazione rurale giudea rimase nella propria terra, si convertì progressivamente all’Islam dopo la conquista araba e divenne così il nucleo ancestrale del popolo palestinese moderno.
Il pregio di questa tesi è duplice. In primo luogo, corregge una credenza popolare diffusa ma storicamente inaccurata: nessun documento d’epoca attesta una politica romana di deportazione di massa dell’intera popolazione della Giudea. In secondo luogo, Sand evidenzia con abilità una notevole ironia storica, mostrando come la sua tesi sulla continuità tra antichi Giudei e moderni fellahin palestinesi fosse condivisa da importanti figure del primo sionismo, come David Ben-Gurion e Yitzhak Ben-Zvi, prima che il conflitto nazionale rendesse tale connessione politicamente insostenibile.
Il significato profondo del Galut
La debolezza fondamentale dell’argomentazione di Sand, tuttavia, risiede in un fondamentale errore categoriale. Egli riduce il concetto complesso di “esilio” a un singolo evento fisico, una deportazione di massa, la cui assenza fattuale gli permette di dichiarare l’intero concetto un “mito”. In questo modo, il suo approccio positivista ignora completamente la dimensione più profonda e storicamente più potente del Galut come condizione teologica, culturale e psicologica.
Il Galut non è semplicemente la diaspora o la dispersione fisica. È un concetto che esprime la condizione di una nazione “sradicata dalla sua patria e soggetta a un dominio straniero”. Implica un sentimento di alienazione, una nostalgia per un centro politico-etnico perduto e una costante interrogazione sul significato della sofferenza storica. Nella mistica ebraica, assume una dimensione cosmica, diventando “l’esilio della Divina Presenza” (Galut ha-Shekhinah), una frattura nell’ordine divino stesso. Questa coscienza di essere in Galut è una forza storica reale: ha plasmato per quasi due millenni l’identità ebraica, la liturgia, la pratica rituale e la speranza messianica. Esisteva prima del 70 d.C. e si è intensificata enormemente dopo la perdita del centro cultuale e politico di Gerusalemme. Concentrandosi esclusivamente sulla confutazione di un evento fisico, Sand demolisce una versione semplificata della storia, ma ignora completamente la realtà storica, ben più significativa, della coscienza dell’esilio come elemento fondante e persistente della “peoplehood” ebraica. Questo dimostra come la narrazione che un popolo fa di se stesso possa diventare una forza storica più potente dei “fatti” che uno storico potrebbe cercare di accertare.
La diaspora come conversione: i regni dimenticati
La contro-narrazione di Sand alla diaspora per esilio è quella di una diaspora per conversione. Questa è una delle sezioni più solide e convincenti del libro. Sand documenta in modo esteso come l’ebraismo, per diversi secoli, sia stato una religione attivamente proselitista, un fatto spesso minimizzato o ignorato nella moderna autopercezione ebraica. Egli ricostruisce le conversioni forzate degli Idumei sotto gli Asmonei e analizza la diffusione dell’ebraismo nel mondo ellenistico-romano. Soprattutto, porta alla luce la storia di interi regni e popolazioni che adottarono l’ebraismo, come il regno di Himyar nella penisola arabica, le tribù berbere in Nord Africa e, in modo centrale per la sua tesi, il vasto e potente Impero dei Cazari nel Caucaso tra il VII e il X secolo. Il recupero di questa “storia dimenticata” rappresenta un contributo vitale, che complica in modo necessario la narrazione semplicistica di una discendenza puramente biologica e ininterrotta dagli antichi Israeliti.
Valutazione critica e il dibattito contemporaneo
L’ipotesi cazara contro l’evidenza genetica
La tesi più provocatoria e, al contempo, empiricamente più debole di Sand è che la stragrande maggioranza degli ebrei ashkenaziti non discenda da ebrei migrati dalla Renania, ma dai Cazari convertiti. È su questo punto che il suo metodo di reinterpretazione storica si scontra frontalmente con un corpus di prove di natura diversa: la genetica delle popolazioni.
Negli ultimi due decenni, numerosi studi genetici indipendenti, condotti da team di ricerca internazionali guidati da scienziati come Harry Ostrer e Doron Behar, hanno analizzato il genoma di diverse popolazioni ebraiche. Utilizzando marcatori del DNA autosomico, del cromosoma Y (linea paterna) e del DNA mitocondriale (linea materna), questi studi sono giunti a un consenso scientifico schiacciante: le principali comunità ebraiche (ashkenazita, sefardita e mizrahi) condividono una sostanziale ascendenza genetica comune, che le colloca saldamente nel Levante, ovvero nel Vicino Oriente.
Questi studi non negano l’esistenza di un admixture (mescolanza) con le popolazioni ospitanti – anzi, la quantificano. Per gli ebrei ashkenaziti, l’ascendenza non mediorientale risulta essere prevalentemente sud-europea, in particolare italiana, il che è coerente con un modello migratorio dal Levante, attraverso l’Italia, fino alla Renania, e da lì verso l’Europa orientale. Le analisi non hanno trovato alcuna prova significativa di un’ascendenza turco-caucasica su larga scala, come l’ipotesi cazara richiederebbe.
Sand, per sostenere la sua tesi, si basa su studi minoritari e controversi, come quelli di Eran Elhaik. Tuttavia, il lavoro di Elhaik è stato pesantemente criticato dalla comunità scientifica per gravi difetti metodologici, in particolare per l’uso di popolazioni moderne (come armeni e georgiani) come “proxy” genetici per gli estinti Cazari, un’assunzione priva di fondamento storico e genetico.
Di fronte a questo consenso scientifico, la reazione di Sand è stata quella di respingere in blocco la ricerca genetica come un’impresa intrinsecamente razzista, una mossa retorica che gli permette di evitare un confronto diretto con dati che falsificano una delle colonne portanti del suo libro. Su questa specifica questione, la sua ipotesi storica non è semplicemente dibattuta; è in gran parte smentita dalle migliori prove scientifiche disponibili.
Critiche metodologiche e storiografiche generali
Oltre alla controversia genetica, il libro di Sand ha ricevuto numerose critiche di carattere metodologico. Una delle accuse più ricorrenti è quella di “cherry-picking”, ovvero l’uso selettivo delle fonti. Diversi recensori hanno sottolineato come Sand tenda a selezionare le fonti che supportano le sue tesi, ignorando o minimizzando sistematicamente quelle che le contraddicono, come la vasta letteratura talmudica sul concetto di Galut.
Particolarmente incisiva è stata la critica mossa dallo storico Israel Bartal dell’Università Ebraica di Gerusalemme. In una celebre recensione intitolata “L’invenzione di un’invenzione”, Bartal ha sostenuto che Sand costruisce una caricatura della storiografia sionista — presentandola come monolitica e dogmatica — per poterla poi facilmente demolire. Secondo Bartal, nessun storico sionista accademico serio ha mai negato l’importanza delle conversioni o sostenuto un’espulsione fisica totale nel 70 d.C. Il dibattito sulla natura della diaspora e sulle origini delle diverse comunità ebraiche è sempre stato complesso e sfaccettato all’interno della stessa storiografia ebraica. Sand, quindi, non starebbe combattendo la storiografia accademica reale, ma, come si è già accennato sopra, un vero e proprio “uomo di paglia” da lui stesso creato per scopi polemici.
Infine, molti critici hanno evidenziato come la mancanza di specializzazione di Sand in storia antica e medievale — il suo campo di ricerca è la storia europea moderna — lo porti a commettere errori fattuali e a interpretare in modo superficiale fonti e contesti storici complessi.
La politica dell’invenzione – sionismo e stato etnocratico
Dalla storia alla politica
Nella parte finale del suo saggio, Sand collega esplicitamente la sua decostruzione storica a una critica politica radicale dello Stato d’Israele contemporaneo. Egli sostiene che il mito “inventato” di un ethnos metastorico, esiliato e biologicamente unito funge da giustificazione ideologica per quella che definisce una “etnocrazia”. Questo regime, secondo Sand, privilegia strutturalmente i cittadini ebrei rispetto a quelli non ebrei, in particolare la minoranza arabo-israeliana, e definisce lo Stato non come la repubblica dei suoi cittadini, ma come la proprietà del “popolo ebraico” mondiale.
La critica all'”etnocrazia”
Sand contesta la formula “Stato ebraico e democratico” come un ossimoro. Leggi come la Legge del Ritorno, che garantisce la cittadinanza automatica a qualsiasi ebreo nel mondo ma la nega ai profughi palestinesi, e la definizione stessa dello Stato come appartenente a un’entità transnazionale piuttosto che alla sua cittadinanza sovrana, sono per lui intrinsecamente antidemocratiche.
Il pregio di questa critica è la sua lucidità e la sua urgenza. Sand contribuisce in modo significativo al dibattito, tanto in Israele quanto all’estero, sulla tensione irrisolta tra l’identità particolarista ed etnica dello Stato e le sue aspirazioni universaliste e democratiche. Queste sue domande, come hanno riconosciuto anche i suoi critici, “meritano una discussione seria”. Sollevando il velo retorico, queste infatti costringono a confrontarsi con le contraddizioni legali e politiche che definiscono la realtà israeliana.
La semplificazione del nesso causale
Il difetto dell’analisi politica di Sand, tuttavia, risiede in una sorta di determinismo storiografico. Egli traccia una linea causale diretta e quasi esclusiva dalla storiografia nazionalista del XIX secolo alle politiche statali del XXI secolo. La sua argomentazione implicita è che Israele è un’etnocrazia perché si fonda su un mito storico inventato.
Questa visione, però, semplifica eccessivamente la complessa logica del potere politico. Se è vero che i miti storici sono strumenti potenti di legittimazione, le politiche di uno Stato sono anche il prodotto di una fitta rete di fattori contemporanei. Il carattere etnocentrico di Israele è inseparabile da un secolo di conflitto nazionale con i palestinesi, da persistenti dilemmi di sicurezza, da complesse dinamiche geopolitiche regionali e da equilibri politici interni, in particolare tra fazioni laiche e religiose.
Suggerire che una revisione della narrazione storica possa, da sola, risolvere la realtà politica significa fraintendere la natura del potere. La narrazione storica funge da giustificazione per la realtà politica, ma non ne è l’unica causa. L’analisi di Sand, pur sollevando questioni certamente imporatanti, attribuisce un potere causale eccessivo all'”invenzione” che ha decostruito, sottovalutando le forze non storiografiche, materiali e politiche, che sostengono l’attuale identità politica di Israele. La sua proposta di soluzione – una repubblica laica, “Stato di tutti i suoi cittadini” – è una logica estensione della sua critica, ma la sua fattibilità è una questione eminentemente politica, non solo storica.
Invenzione, memoria e il fardello della storia
In sintesi, L’invenzione del popolo ebraico si presenta come un’opera duale, i cui meriti sono tanto significativi quanto i suoi difetti. Tra i pregi, spiccano il coraggio di sfidare i dogmi nazionalisti, l’applicazione salutare della teoria critica a un campo spesso considerato eccezionale, l’importante rivalutazione del ruolo delle conversioni nella storia ebraica e una potente critica politica della natura etnocentrica dello Stato israeliano. Tra i difetti, emergono una tendenza alla polemica che porta alla costruzione di “uomini di paglia”, una semplificazione di concetti complessi come il Galut, un problematico rigetto delle prove scientifiche che contraddicono la sua tesi sui Cazari e un’analisi politica a tratti storicamente deterministica.
Tornando al filo conduttore di questa analisi, si può concludere che Shlomo Sand ha ragione su un punto assolutamente fondamentale: il “popolo ebraico” come ethnos puro, biologicamente continuo e immutabile è, in larga misura, un’invenzione moderna. Tuttavia, egli commette un errore speculare nel liquidare la potente realtà storica della “peoplehood” ebraica: una coscienza collettiva forgiata attraverso millenni di interpretazione testuale condivisa, pratica rituale, memoria storica e, soprattutto, una profonda e duratura coscienza dell’esilio.
Un popolo non è semplicemente un “costrutto teorico” che può essere inventato o disinventato a piacimento dagli storici e dagli ideologi. È anche, e soprattutto, il prodotto della sua stessa, ostinata e continua narrazione di sé. Questa auto-narrazione, per quanto possa discostarsi dai “fatti” accertabili da un osservatore esterno, diventa essa stessa un fatto storico, una forza che modella l’identità, la cultura e l’azione collettiva. Shlomo Sand ha brillantemente dissezionato il cadavere della storiografia nazionalista del XIX secolo, ma nel farlo ha forse perso di vista l’anima vivente, per quanto complessa e contraddittoria, del soggetto che intendeva studiare.
Per chi volesse acquistare il libro recensito: https://amzn.to/439hFvt