Introduzione. Rivelazione ed evoluzione culturale
Rodney Stark (1934-2022), sociologo della religione presso la Baylor University, si è affermato nel panorama accademico come una figura intellettuale tanto influente quanto provocatoria. Noto per la sua critica sistematica alle teorie della secolarizzazione e per l’applicazione di modelli di mercato allo studio dei fenomeni religiosi, con La Scoperta di Dio: L’origine delle grandi religioni e l’evoluzione della fede, si è lanciato in quella che è stata la sua impresa scientifica più ambiziosa: una rilettura completa della storia religiosa dell’umanità. La tesi centrale, esposta fin dalle prime pagine del volume, si pone in netto contrasto con il pensiero accademico dominante. Per Stark, la storia delle religioni non è la cronaca di un’invenzione umana, ma una progressiva e faticosa “scoperta di Dio” (p. 10). L’opera si configura come una sfida diretta all'”ateismo militante” di biologi e psicologi evolutivi come Richard Dawkins, i quali riducono la fede a una mera “illusione” nata dalla paura e sostenuta dall’ignoranza (p. 7). Il testo si presenta dunque come una storia interpretativa delle origini delle grandi religioni, un’analisi dell’evoluzione della concezione umana di Dio che, nell’ottica dell’autore, equivale a una scoperta, a patto di assumere l’esistenza stessa di Dio (p. 10).
L’autore non nasconde il suo intento polemico. Fin dall’introduzione, critica aspramente quegli studiosi che, confrontando le diverse fedi, ne deducono la falsità intrinseca, riecheggiando il monaco apostata Jean Bodin secondo cui “tutte confutano tutte” (p. 8). Allo stesso modo, si scaglia contro l’approccio di James Frazer, la cui monumentale opera Il ramo d’oro utilizzava le somiglianze tra i miti — come i racconti di crocifissioni e risurrezioni — come “prova” dell’origine puramente umana e fantasiosa delle narrazioni religiose (p. 8). Frazer, secondo Stark, si limitò a postulare una rapida “diffusione” di miti e rituali tra le culture, senza mai considerare la possibilità che la loro fonte comune potesse essere di natura spirituale (p. 9). L’autore lamenta anche la scarsa attenzione che le scienze sociali hanno dedicato al fenomeno dell'”Età Assiale”, quel VI secolo a.C. che vide la contemporanea fioritura di figure come Budda, Confucio, Lao-Tzu, Zoroastro e i profeti israeliti, un evento che la maggior parte degli studiosi ha liquidato come mera coincidenza o ha analizzato negandone qualsiasi dimensione spirituale (p. 9).
Per sostenere questa imponente architettura argomentativa, Stark si avvale di due strumenti concettuali fondamentali, uno teologico e uno sociologico, che adatta per i suoi scopi analitici. Il primo è il concetto di accomodazione divina. Prendendo a prestito dalla teologia giudaico-cristiana, Stark sostiene che le rivelazioni divine sono sempre state limitate dalla capacità di comprensione degli esseri umani in un dato momento storico (p. 12). Citando Agostino, Tommaso d’Aquino e Giovanni Calvino, l’autore afferma che Dio, per comunicare con l’uomo, è costretto a usare una sorta di “linguaggio per bambini” (p. 12). Questo principio ermeneutico permette a Stark di spiegare le apparenti contraddizioni e l’evoluzione delle Scritture non come prova della loro falsità, ma come un progressivo disvelamento della verità divina, adattato a un’umanità in crescita. Se Mosè, ad esempio, redasse la Genesi in modo “rozzo”, fu perché si rivolgeva a un popolo “ignorante e primitivo” (p. 13).
Il secondo pilastro è una teoria dell’evoluzione culturale basata sul principio della “sopravvivenza dei più adatti” di Herbert Spencer (p. 15). Stark applica questo modello non alla biologia, ma alle idee e alle pratiche culturali. Gli esseri umani, agendo come attori razionali, tendono ad adottare e conservare quegli elementi culturali, incluse le immagini di Dio, che sembrano offrire “maggiore appagamento, sia soggettivo che materiale” (p. 17). Questa evoluzione delle concezioni divine segue, secondo l’autore, una traiettoria precisa: si preferiscono Dei personali a essenze impersonali, Dei con un vasto raggio d’azione a divinità locali, e soprattutto Dei razionali e amorevoli a entità capricciose o indifferenti (p. 17-18). Questo processo evolutivo, tuttavia, non culmina in un monoteismo assoluto. Per risolvere il problema del male — come può un Dio buono e onnipotente permettere la sofferenza? — la concezione più “soddisfacente” è quella di un monoteismo dualistico. In questo modello, che Stark vede pienamente realizzato in fedi come lo zoroastrismo, l’ebraismo e il cristianesimo, la responsabilità del male non è attribuita a Dio, ma a un essere soprannaturale inferiore e malvagio, come Satana (p. 19). Ciò permette di preservare l’immagine di un Dio amorevole e razionale, che alla fine trionferà sul male.
L’intero progetto di Stark non è, quindi, una semplice storia delle religioni, ma una vera e propria apologetica sociologica. Utilizzando concetti come “accomodazione divina” e “scelta razionale”, egli costruisce un quadro teorico che gli consente di trattare la rivelazione come un dato analizzabile sociologicamente, sfidando così il presupposto di ateismo metodologico che domina il suo campo di ricerca. La sua critica a James Frazer, che interpretava le somiglianze tra le religioni come prova della loro origine umana (pp. 8-9) , o a Émile Durkheim, che riduceva Dio a un'”espressione figurativa della società” (p. 20) , non è un semplice disaccordo accademico. È un tentativo di “rompere l’incantesimo” del secolarismo nelle scienze sociali. Il concetto di accomodazione divina, in particolare, gli permette di spiegare le differenze tra le fedi senza dover concludere, à la Hume, che queste si confutino vicendevolmente. In questo modo, Stark può sostenere che molte religioni contengano frammenti di verità, pur mantenendo una traiettoria evolutiva che, come si vedrà, culmina inequivocabilmente nel cristianesimo.
1. Gli Dei nelle società primitive
Il primo capitolo del libro è dedicato a smontare le teorie classiche sulle origini della religione e a proporre un modello alternativo. Stark passa in rassegna e confuta sistematicamente le quattro principali scuole di pensiero ottocentesche e primo-novecentesche: il naturismo di Max Müller, l’animismo di Edward Burnett Tylor, la teoria degli spiriti di Herbert Spencer e il totemismo di William Robertson Smith e Émile Durkheim (p. 38). Il filo conduttore della sua critica è che tutte queste teorie si basano sul pregiudizio di una presunta inferiorità mentale degli uomini primitivi, considerati alla stregua di “ritardati mentali” incapaci di concezioni teologiche complesse (p. 46). Müller viene criticato per aver ignorato la letteratura etnografica (p. 39) , mentre Durkheim per aver ridotto la religione a un mero rituale sociale, svuotandola del suo contenuto teologico e della sua relazione con il soprannaturale (pp. 48-50).
In opposizione a questa visione, Stark riabilita e sposa la tesi del “monoteismo primordiale” (Urmonotheismus), formulata originariamente da Andrew Lang e sviluppata in modo enciclopedico dal sacerdote e antropologo Wilhelm Schmidt (pp. 75-76). Basandosi su quelli che considera i resoconti etnografici più affidabili, Stark (che purtroppo dimostra di non conoscere il lavoro di Raffaele Pettazzoni) sostiene che le culture umane più “primitive” a noi note, come i pigmei dell’Africa, gli abitanti della Terra del Fuoco e gli aborigeni australiani, non praticavano forme rozze di animismo, ma credevano in un Sommo Dio (p. 76). Questo Dio era concepito come un essere eterno, onniveggente, creatore del mondo e custode della moralità. Secondo questa prospettiva, il politeismo e l’animismo non rappresentano gli stadi iniziali dell’evoluzione religiosa, ma forme successive di “degenerazione” da una fede originaria più pura e sofisticata.
La scelta di fondare la propria argomentazione sulla controversa e, da molti antropologi, superata teoria dell’Urmonotheismus di Schmidt non è casuale, ma strategica. Sebbene possa apparire come un passo metodologicamente debole, è narrativamente essenziale per l’impalcatura del libro. Il modello evolutivo classico (animismo → politeismo → monoteismo) mal si adatta a una narrazione di “scoperta” di un Dio complesso; suggerirebbe piuttosto un’invenzione progressiva. Adottando la teoria di Schmidt, Stark può invece affermare che l’umanità ha iniziato con una concezione elevata di Dio. Questo gli permette di inquadrare il politeismo delle grandi civiltà non come un passo evolutivo in avanti, ma come una “regressione” (Capitolo 2), e la successiva ascesa del monoteismo non come un’invenzione, ma come una “rinascita” (Capitolo 4), un ritorno alla verità primordiale. Sebbene gli antropologi moderni considerino la teoria di Schmidt speculativa e teologicamente orientata (per cui anche lì dove osservano correttamente che le credenze religiose dei “primitivi” sono assai più sofisticate di come le si spesso presentate, non si azzardano ad etichettarle come forme di “monoteismo”), per Stark essa costituisce il cardine su cui poggia l’intera sua costruzione storica.
2. Le religioni di tempio delle antiche civiltà
Nel secondo capitolo, Stark analizza le religioni delle prime grandi civiltà — Sumer, Egitto, Grecia e Mesoamerica — definendole “religioni di tempio” (p. 89). Questi sistemi religiosi sono caratterizzati da tre elementi principali: un clero professionale e spesso ereditario che serve una “clientela” piuttosto che una “congregazione” di fedeli; un monopolio religioso strettamente controllato e sussidiato dallo stato; e un’enfasi schiacciante sul corretto svolgimento dei rituali piuttosto che sulla fede o sulla moralità individuale (p. 90).
Secondo l’autore, queste civiltà rappresentano una profonda “regressione” teologica rispetto al monoteismo primordiale. I “Sommi Dei” vengono messi da parte e sostituiti da un “lussureggiante politeismo” (p. 128). Le divinità diventano antropomorfe, con poteri limitati e, soprattutto nel caso greco-romano, con un carattere capriccioso e palesemente amorale (pp. 111, 129). Questi Dei, pur essendo teologicamente meno sofisticati, risultano psicologicamente più attraenti e “vicini” all’uomo, più facili da propiziare tramite sacrifici (p. 129). Un elemento centrale di queste religioni era la credenza che le immagini degli Dei, o “idoli”, fossero letteralmente vive, animate attraverso complessi rituali sacerdotali (pp. 97-98).
Questo sistema religioso, strettamente intrecciato con il potere politico, porta a una profonda stagnazione. Il clero, godendo di uno status privilegiato e di immense ricchezze derivanti dalle terre dei templi (p. 99) , diventa ferocemente contrario a qualsiasi innovazione teologica, cristallizzando la tradizione e ripetendo per millenni gli stessi rituali e le stesse preghiere (pp. 130-131). La moralità individuale non è una preoccupazione centrale: gli Dei non sono modelli etici e le offese morali non sono considerate peccati contro di loro (p. 129). Di conseguenza, manca una dottrina della salvezza individuale basata sulla virtù. L’aldilà, per la maggior parte delle persone, è immaginato come un luogo tetro e spiacevole, un’esistenza grigia nelle “malsane sale di Ade” (p. 129).
3. Roma, un antico mercato religioso
Il terzo capitolo segna una svolta nell’analisi di Stark, introducendo il suo modello teorico più noto: l’economia religiosa. L’autore applica la teoria della scelta razionale alla vita religiosa dell’Impero Romano, descrivendolo come un “mercato religioso notevolmente libero e affollato” (p. 159). A differenza dei rigidi monopoli di tempio di Egitto e Mesopotamia, Roma permetteva una notevole competizione tra una vasta gamma di culti. Questo pluralismo, secondo Stark, ha stimolato un livello di partecipazione religiosa generale molto più elevato (p. 160).
Le nuove fedi importate dall’Oriente — i culti di Bacco, Cibele, Iside, Mitra — e successivamente l’ebraismo e il cristianesimo, ebbero un enorme successo perché offrivano un “prodotto” religioso superiore a quello della religione tradizionale greco-romana. Stark identifica diversi vantaggi competitivi principali (pp. 177-182):
- Emotività e Comunità: Offrivano esperienze cariche di emotività e un forte senso di comunità attraverso congregazioni attive, in netto contrasto con i freddi e impersonali rituali di stato (p. 178).
- Moralità e Salvezza Individuale: Mettevano al centro la moralità personale, l’espiazione dei peccati e, soprattutto, la promessa di una salvezza individuale e di una vita ultraterrena felice (p. 178).
- Status per le Donne: Conferivano alle donne uno status e ruoli attivi molto più significativi rispetto alla società patriarcale romana e ai culti tradizionali (pp. 179-180).
- Raffinatezza Teologica: Erano “religioni di libro”, basate su scritture e teologie complesse che attraevano anche gli intellettuali (p. 179).
- Organizzazione: A differenza dei culti tradizionali che avevano solo “clienti”, le nuove fedi creavano “congregazioni”, comunità unite e attive che diventavano il centro della vita sociale dei loro membri (pp. 181-182).
Stark applica questo modello anche per spiegare la logica della persecuzione romana. Sostiene che le repressioni, come quella contro i Baccanali nel 186 a.C. (pp. 183-186) o successivamente contro ebrei e cristiani, non avevano una radice primariamente teologica. Lo stato romano non temeva gli Dei stranieri, ma i gruppi religiosi altamente coesi, organizzati e devoti, che percepiva come una potenziale minaccia politica al proprio potere e alla stabilità sociale (p. 182).
Sebbene il modello del mercato religioso offra una spiegazione sociologicamente potente per la dinamica della competizione e della diffusione delle fedi, esso corre il rischio di essere riduzionista. Ridurre la fede a un “prodotto” e i credenti a “consumatori razionali” che operano un calcolo di costi e benefici (p. 161) potrebbe non cogliere appieno le dimensioni emotive, identitarie e talvolta irrazionali che guidano l’impegno religioso. Va qui osservato che sono state correttamente sollevate alcune critiche al modello economico in ambito religioso, le quali hanno evidenziato come esso fatichi a spiegare fenomeni come il martirio, l’altruismo disinteressato (che Stark stesso cita come un vantaggio competitivo cristiano (p. 423) ) o l’adesione a fedi “costose” e ad alta tensione con la società circostante. Il modello spiega efficacemente come un movimento si diffonde in un mercato, ma forse meno esaurientemente perché le persone sono disposte a “pagare” prezzi così alti per la loro fede.
4. La «rinascita» del monoteismo
Nel quarto capitolo, Stark analizza l’emergere di movimenti religiosi che sfidarono il politeismo dominante e proposero un ritorno al monoteismo. Dopo aver brevemente esaminato il tentativo fallito del faraone Akhenaton (pp. 221-224), che del resto molti storici delle religioni oggi non identificano più come avente una riforma monoteistica in senso stretto, l’autore si concentra su due casi principali: lo zoroastrismo e l’ebraismo.
Lo zoroastrismo viene presentato come il primo monoteismo dualistico pienamente sviluppato. La sua dottrina, rivelata al profeta Zoroastro, postula l’esistenza di un unico Dio buono e creatore, Ahura Mazda, in perenne lotta con uno spirito malvagio inferiore, Angra Mainyu. Questa visione, secondo Stark, offre una soluzione razionale e soddisfacente al problema del male, liberando Dio dalla responsabilità della sofferenza e ponendo l’accento sulla scelta morale individuale (p. 227).
L’analisi dell’ebraismo è più complessa. Stark ne traccia l’evoluzione da una religione essenzialmente politeista, in cui YHWH era un Sommo Dio tra tanti altri (p. 240) , a un monoteismo etico e rigoroso. Questa trasformazione, sostiene, non fu un processo lineare e naturale, ma il risultato della lunga e difficile lotta di una “setta” elitaria e fortemente devota — che Stark identifica con i profeti e i redattori deuteronomisti — contro il politeismo radicato nel popolo e persino nel clero del Tempio di Gerusalemme (p. 243). La scoperta del “Libro della Legge” durante il regno di Giosia nel VII secolo a.C. è vista come il momento catalizzatore di questa rivoluzione monoteista, che impose la Legge come fondamento della vita ebraica (pp. 248-249).
Un punto cruciale dell’argomentazione di Stark è la sua vigorosa contestazione dell’idea che l’ebraismo antico fosse una religione esclusivamente etnica e non missionaria (p. 263). Citando un’ampia gamma di fonti bibliche (Isaia, Salmi), rabbiniche e storiche (Filone di Alessandria, Flavio Giuseppe), l’autore dimostra che l’ebraismo della Diaspora fu una fede attivamente proselitista, che ottenne un notevole successo nel mondo greco-romano, creando una vasta comunità di “timorati di Dio”, gentili che abbracciavano il monoteismo ebraico senza convertirsi completamente (pp. 264-265).
Questa tesi di un ebraismo missionario è fondamentale per la coerenza del modello di mercato proposto da Stark. Essa permette di spiegare l’ascesa del cristianesimo non come un evento unico e isolato, ma come l’ingresso di un concorrente più efficace in un mercato monoteista già esistente. In questa prospettiva, l’ebraismo aveva già “creato la domanda” per un Dio unico ed etico tra i gentili, offrendo un “prodotto” desiderabile ma con un “costo di ingresso” molto alto (la circoncisione, le rigide leggi alimentari). Il cristianesimo, quindi, poté trionfare entrando in questo mercato con un’offerta simile (lo stesso Dio di Abramo) ma con costi di adesione drasticamente ridotti, catturando così l’enorme “quota di mercato” dei timorati di Dio e di altri pagani insoddisfatti.
5. Ispirazioni indiane & 6. Divinità cinesi e fedi «atee»
Nei capitoli dedicati all’India e alla Cina, Stark analizza l’origine e lo sviluppo di induismo, buddhismo, giainismo, taoismo e confucianesimo. Egli interpreta la straordinaria fioritura religiosa del VI secolo a.C. non come una scoperta di Dio, ma come la “scoperta del ‘peccato’ e della coscienza, collegando la moralità alla trascendenza” (p. 28).
Nelle loro forme originali e elitarie, Stark classifica queste fedi orientali come sistemi essenzialmente “atei” o filosofici. L’induismo delle Upanishad, le prime forme di buddismo e giainismo, il taoismo e il confucianesimo si concentrano su essenze divine impersonali e inconsapevoli (come il Brahman o il Tao), sul raggiungimento del vuoto (nirvana), o su sistemi etici e politici, relegando le divinità personali a un ruolo marginale o del tutto irrilevante per la salvezza (pp. 299, 305, 311, 345, 357).
Tuttavia, Stark osserva un modello evolutivo comune a tutte queste fedi. Il fatto che Budda, Lao-Tzu e Confucio siano stati successivamente deificati e che le loro religioni, nelle forme popolari, abbiano sviluppato pantheon ricchi e complessi è, per l’autore, la prova definitiva della sua tesi centrale: le filosofie “atee” e le essenze impersonali sono teologicamente insoddisfacenti per la maggior parte delle persone. Le masse, sostiene Stark, preferiscono e “scelgono” Dei personali, consapevoli e amorevoli, con cui poter interagire. La successiva deificazione dei fondatori e l’integrazione di innumerevoli divinità sono viste come una concessione inevitabile alle esigenze del “mercato religioso popolare” (pp. 320, 350, 361).
| Fase Evolutiva | Caratteristiche Principali della Divinità | Esempi Storici (secondo Stark) |
| Monoteismo Primordiale | Unico Dio supremo, creatore, etico, onnisciente. | Religioni dei popoli “primitivi” (pigmei, andamani). |
| Regressione Politeista | Pantheon di Dei antropomorfi, amorali, di ambito limitato. | Religioni di tempio (Sumer, Egitto, Grecia). |
| Filosofie “Atee” (Età Assiale) | Essenze divine impersonali, inconsapevoli; Dei irrilevanti. | Induismo delle Upanishad, Buddhismo, Taoismo. |
| Rinascita Monoteista | Unico Dio trascendente, etico, fonte della Legge. | Zoroastrismo, Ebraismo deuteronomista. |
| Monoteismo Dualistico | Dio buono e razionale opposto a un principio del male inferiore. | Zoroastrismo, Ebraismo, Cristianesimo. |
| Monoteismo Trascendente e Incarnato | Dio al contempo trascendente (Padre) e immanente/accessibile (Figlio). | Cristianesimo. |
7. L’ascesa del cristianesimo
Il settimo capitolo è dedicato all’ascesa del cristianesimo, che Stark considera il culmine del processo di scoperta di Dio. Il suo successo è attribuito a una serie di vantaggi competitivi decisivi. Teologicamente, il cristianesimo ha offerto una sintesi unica, fondendo “l’attrattiva intellettuale del monoteismo con quella emotiva delle divinità antropomorfe” attraverso la figura di Cristo, un Dio al tempo stesso trascendente e accessibile (pp. 26, 392). Socialmente, ha promosso un’etica della carità che si è tradotta in un vero e proprio “stato assistenziale in miniatura” (p. 423) , migliorando tangibilmente la qualità e la durata della vita dei suoi aderenti, un fatto reso drammaticamente evidente durante le grandi pestilenze che colpirono l’Impero. Inoltre, il cristianesimo ha offerto uno status e una protezione senza precedenti alle donne, condannando pratiche diffuse come l’infanticidio femminile e l’aborto, e promuovendo un modello di matrimonio più equo (pp. 425-426).
La crescita del movimento non fu il risultato di conversioni di massa improvvise, ma un processo graduale e organico, basato sulla diffusione attraverso le reti sociali di parenti e amici (p. 415). Tuttavia, il trionfo del cristianesimo con l’imperatore Costantino e la sua trasformazione in una chiesa di stato monopolistica e sussidiata segnò, paradossalmente, l’inizio del suo lungo declino in Europa. Privato dello stimolo della competizione, il clero divenne compiacente e negligente, e per oltre un millennio le chiese europee rimasero in gran parte vuote, un fenomeno che Stark usa per sfatare il mito della “Dark Age” come epoca di fede universale (pp. 436-437). In questo contesto, l’autore sottolinea il ruolo fondamentale dei monasteri nella conservazione del sapere classico e l’innovazione tecnologica del Medioevo, elementi che contraddicono la narrazione di un’epoca “buia”.
Infine, Stark liquida lo gnosticismo come un tentativo sincretistico di matrice pagano-filosofica di assorbire il cristianesimo. I vangeli gnostici, con la loro cosmologia “mitica” e non storica e la loro dottrina di un Dio creatore malvagio (il Demiurgo platonico), vengono scartati come teologicamente e storicamente incompatibili con il nucleo della fede cristiana (pp. 432-433).
8. Islam: Dio e stato
L’ultimo capitolo analitico è dedicato all’islam. Stark descrive Maometto non solo come un profeta, ma anche come un abile e spregiudicato capo militare e politico, che riuscì a unificare le tribù arabe e a fondare uno stato teocratico attraverso una combinazione di rivelazioni, diplomazia e guerra (pp. 472-473). Le grandi conquiste arabe che seguirono non furono, secondo l’autore, il risultato di un fervore missionario, ma imprese militari finalizzate al bottino e al dominio; la conversione delle popolazioni sottomesse fu un processo lento, durato secoli (pp. 494, 499).
Dal punto di vista teologico, Stark considera l’islam una regressione rispetto al cristianesimo. La concezione di Allah nel Corano è quella di un Dio talmente trascendente e sovrano da risultare arbitrario, imprevedibile e, in ultima analisi, inconoscibile. La sua volontà non è vincolata dalla ragione, il che, secondo Stark, ha reso impossibile lo sviluppo di una teologia sistematica paragonabile a quella cristiana, in cui si ragiona sulla natura e le intenzioni di un Dio razionale (p. 505). L’autore contesta anche aspramente il mito della convivencia nella Spagna moresca come un’età dell’oro di tolleranza interreligiosa, sostenendo che le fonti storiche dimostrano che i governanti musulmani non furono meno intolleranti dei loro successori cristiani (p. 500).
Conclusione. Scoprire Dio?
Nelle pagine conclusive, Stark abbandona la descrizione sociologica per avanzare una tesi apertamente teologica. Propone tre criteri per giudicare l’autenticità divina di una religione (pp. 525-529):
- Rivelazione: La fede deve affermare di basarsi su una rivelazione diretta di Dio. Questo criterio esclude le fedi “filosofiche” orientali, i cui fondatori non hanno mai preteso di essere portavoce divini.
- Coerenza: Le rivelazioni autentiche devono essere fondamentalmente compatibili tra loro. Stark vede una sostanziale coerenza tra zoroastrismo, ebraismo e cristianesimo.
- Complessità Progressiva: In base al principio dell’accomodazione divina, le rivelazioni successive dovrebbero mostrare una comprensione di Dio teologicamente più sofisticata, non regressiva. Questo esclude sia il politeismo di tempio sia l’islam, la cui concezione di Allah è giudicata teologicamente regressiva.
Il nucleo di fedi “ispirate” si riduce così a un percorso che culmina nel cristianesimo. Ma l’argomento finale di Stark va oltre. Egli sostiene che la prova definitiva dell’esistenza del Dio giudaico-cristiano non risiede nelle Scritture, ma nella storia della scienza (p. 530). La scienza moderna, afferma, è nata una sola volta nella storia: nell’Europa cristiana. Questo perché solo la teologia cristiana forniva i presupposti intellettuali necessari: la fede in un universo creato da un Dio unico e razionale, governato da leggi naturali uniformi e immutabili, che la mente umana, creata a immagine di Dio, poteva scoprire e comprendere (p. 531). Citando il filosofo Alfred North Whitehead, Stark conclude che la fede nella possibilità della scienza era un “derivato della teologia medievale” (p. 531). Altre grandi civiltà, come la Cina o il mondo islamico, pur avendo notevoli successi tecnologici e matematici, non svilupparono la scienza perché le loro concezioni del cosmo (o come caotico e misterioso, o come soggetto al volere arbitrario di un Dio imperscrutabile) rendevano l’indagine scientifica sistematica un’impresa futile (p. 531).
L’universo stesso, con il suo ordine e la sua comprensibilità — un fatto che Albert Einstein definì “miracoloso” (p. 533) — diventa così la prova di un Disegno Intelligente e la rivelazione ultima di Dio. La scienza, in questo senso, non è nemica della fede, ma è essa stessa una forma di teologia, uno strumento per scoprire Dio (p. 534).
L’intero libro si rivela così essere una complessa e ambiziosa costruzione argomentativa che conduce inesorabilmente a questa conclusione. Stark utilizza gli strumenti della sociologia per sgombrare il campo dalle teorie atee e materialiste, reinterpreta la storia delle religioni per tracciare una narrazione di progresso teleologico verso il cristianesimo, e infine usa la storia della scienza come prova quasi-empirica per la sua tesi teologica. La Scoperta di Dio non è quindi solo un saggio di sociologia storica, ma un manifesto intellettuale che mira a dimostrare quella che l’autore, in un’altra sua opera celebre, ha chiamato “la vittoria della ragione” cristiana. Sebbene le sue tesi siano spesso brillanti e supportate da una vasta erudizione, il suo approccio teleologico e la sua conclusione apertamente apologetica rimangono, come confermato da numerose recensioni critiche, gli aspetti più controversi e dibattuti della sua opera.
Per acquistare il volume: https://amzn.to/3U11YBA

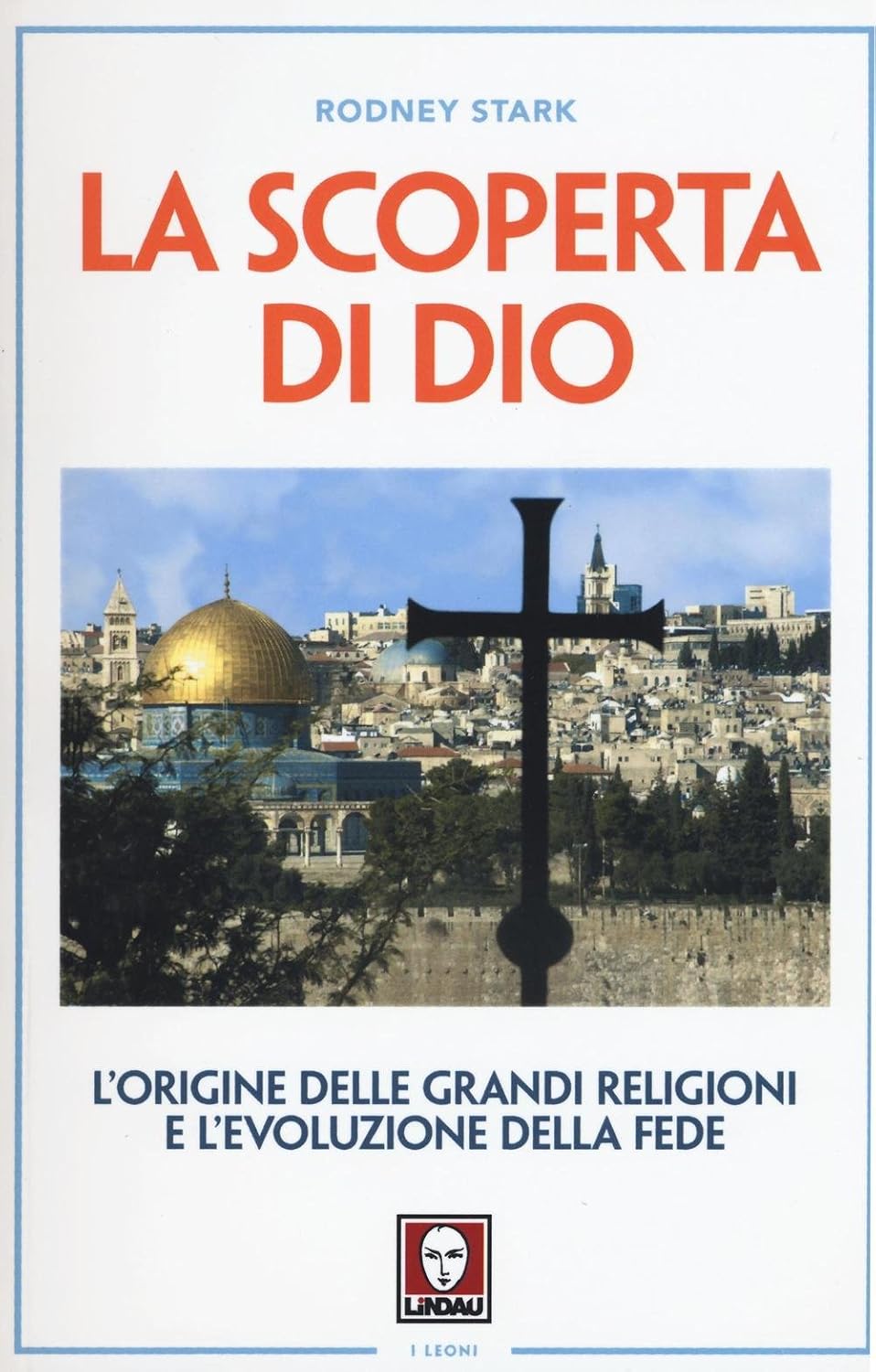
Alcuni punti delle tesi di Stark mi lasciano perplesso, Dichiaro subito il mio punto di patenza: io credo che la religiosità venga suscitata nell’uomo dalla consapevolezza del mistero della Vita, e che dunque sia un tentativo di dare una risposta a questo mistero. Inoltre credo che le tre grandi religioni monoteistiche siano state spesso usate per scopi di potere, di dominio, di conquista: su base etnica l’ebraismo e l’islamismo, e su base politica il cristianesimo. Ma un punto critico nelle tesi di Stark lo indiviuo nella spiegazione dell’esistenza del male. Come si può pensare che esista un Diavolo, seppur inferiore a Dio, che si oppone, riuscendoci, alla volontà di bene di Dio? Prendiamo la sofferenza degli animali vittime della predazione dei carnivori: bisogna pensare che esista anche per loro una forza maligna che li fa soffrire, ad onta della paciosa benevolenza del Creatore? Un secondo punto riguarda la scienza: Stark sembra dimenticare i progressi scientifici dei matematici e dei fisici dell’antica Grecia, e pure le fiorenti scuole scientifiche del Medioevo arabo, in entrambi i casi del tutto indipendenti dal cristianesimo. Insomma la tesi di Stark di vedere nel cristianesimo il punto d’arrivo e di convergenza della ricerca del senso morale e della razionalità non mi convincono per niente. La ringrazio per i suoi contributi sul sito che trovo sempre interessanti, anche se talvolta non mi trovano d’accordo.
Stark mi ricorda i positivisti ottocenteschi che spiegavano tutto a partire da una loro precompressione. Religioni orientali: non so quale sia la nostra comprensione di quei testi fuori dal loro contesto ma la lettura di Stark non mi convince. Egli assume come modello e metro di lettura il cristianesimo. Anche sull’Islam non mi convince e se le religioni si misurano dal successo, beh, l’Islam ha molto successo. Personalmente la considero una grande religione e visitando paesi islamici ho visto quanto essa ancora formi i gruppi sociali. Convengo sul fatto che la scienza sia nata non a caso in area cristiana. La matematica non c’entra perchè è teorica mente la scienza nasce dall’esperimento e dall’induzione. Il cristianesimo ha desacralizzato la natura e valorizzato la ragione, due condizioni necessarie e sufficienti per favorire la scienza. Recensione interessante ma per ora non metto il libro in lettura. Di Stark lessi e apprezzai invece un lavoro più sociologico: “Ascesa e affermazione del Cristianesimo. Come un movimento oscuro e marginale è diventato in pochi secoli la religione dominante dell’Occidente”.