Introduzione
Tra gli episodi più enigmatici e dibattuti nei rapporti tra il nascente cristianesimo e l’Impero Romano, spicca la narrazione contenuta nel capitolo 5 dell’Apologeticum di Tertulliano. Scritta intorno al 197, l’opera riporta che l’imperatore Tiberio, informato da un rapporto di Ponzio Pilato sugli eventi miracolosi legati a Cristo in Palestina, avrebbe proposto al Senato di riconoscere ufficialmente la divinità di Gesù e di ammetterne il culto a Roma. Secondo il racconto, il Senato respinse la proposta, geloso della propria prerogativa di approvare nuove divinità, stabilendo così, secondo Tertulliano, il fondamento giuridico per la successiva illegalità del cristianesimo.
Questa notizia, isolata e priva di conferme dirette in fonti pagane coeve, è stata quasi universalmente rigettata dalla critica storica moderna, che la considera una leggenda apologetica. Tuttavia, in un panorama accademico largamente concorde, la voce della storica italiana Marta Sordi si è distinta per aver dedicato studi approfonditi a difendere un nucleo di storicità dell’evento, proponendone una lettura alternativa e complessa. Questo articolo si propone di analizzare tale controversia storiografica, ponendo a confronto le ragioni dello scetticismo maggioritario con la minoritaria tesi della Sordi.
Il percorso argomentativo si svilupperà attraverso quattro passaggi. Il primo analizzerà le fonti primarie cristiane, Tertulliano ed Eusebio, per definirne il contenuto e l’intento. Il secondo esporrà sistematicamente le obiezioni della critica moderna, basate sull’argomento del silenzio, sull’inverosimiglianza storica e giuridica, e sulla generale inaffidabilità di Tertulliano come storico. Il terzo passo sarà un’esposizione dettagliata e critica della tesi di Marta Sordi. Infine, il quarto passo offrirà una valutazione comparativa e una sintesi storiografica, cercando di determinare lo statuto più probabile della narrazione tiberiana: resoconto storico o costruzione retorica?
1. La fonte primaria e la sua tradizione: Tertulliano ed Eusebio
1.1. Analisi del passo dell’Apologeticum (5.2)
Il racconto di Tertulliano non è un inciso casuale, ma un tassello fondamentale inserito in una più ampia e sofisticata argomentazione legale e retorica. Tertulliano, avvocato di formazione e polemista ardente , si rivolge direttamente ai magistrati dell’Impero Romano per denunciare l’illogicità e l’ingiustizia dei processi contro i cristiani, basati sulla sola confessione del nome (nomen ipsum) e non sull’esame dei crimini (examinatio criminis). In questo contesto, l’episodio di Tiberio serve a creare un precedente illustre e giuridicamente potente. Il testo latino riporta che Tiberio, avendo ricevuto un rapporto dalla Palestina (de Syria Palaestina), sottopose la questione al Senato con il suo voto favorevole (cum praerogativa suffragii sui), una formula che indica una proposta formale e autorevole. Il Senato, tuttavia, respinse la mozione quia non ipse probaverat (“perché non l’aveva approvata lui stesso”, cioè di propria iniziativa), affermando la propria antica prerogativa in materia religiosa. Nonostante il rifiuto, l’imperatore mantenne la sua posizione favorevole e minacciò di morte gli accusatori dei cristiani (comminatus mortem accusatoribus Christianorum).
La funzione di questo racconto è eminentemente apologetica. Lo scopo non è la storiografia imparziale, ma la persuasione. Tertulliano vuole dimostrare che solo gli imperatori “malvagi” e tirannici, come Nerone, citato subito dopo come l’iniziatore delle persecuzioni imperiali, si opposero al cristianesimo. Al contrario, Tiberio, fondatore del principato, non solo non era ostile, ma si era mostrato favorevole a Cristo. Questa narrazione serviva a legittimare il cristianesimo agli occhi dell’autorità romana, presentandolo non come una superstitio nova et malefica (una superstizione nuova e dannosa), ma come una fede antica e degna di rispetto, la cui illegalità derivava non da un’intrinseca ostilità allo Stato, ma da un puntiglio di orgoglio del Senato. L’uso di una terminologia giuridica precisa è una strategia retorica deliberata, mirata a conferire un’aura di autenticità documentale al racconto, facendo appello alla mentalità legale dei suoi destinatari. In questo modo, Tertulliano non si limita a un appello morale, ma costruisce un vero e proprio “precedente Tiberio” per delegittimare la base giuridica delle persecuzioni a lui contemporanee.
1.2. La testimonianza di Eusebio di Cesarea (Storia ecclesiastica, II.2)
Circa un secolo e mezzo dopo, lo storico ecclesiastico Eusebio di Cesarea riprende la narrazione nel secondo libro della sua Storia ecclesiastica. Egli afferma che Pilato, secondo un’antica consuetudine dei governatori provinciali, informò Tiberio della risurrezione e dei miracoli di Cristo, e che l’imperatore riferì la questione al Senato. La testimonianza di Eusebio, tuttavia, non è indipendente. Egli cita esplicitamente Tertulliano come sua fonte principale, definendolo un uomo illustre e profondo conoscitore delle leggi romane, e ne riporta un lungo brano dell’Apologeticum per corroborare il suo racconto.
Eusebio non aggiunge prove autonome o dettagli fattuali nuovi. Al contrario, inquadra l’episodio in una prospettiva teologica e provvidenzialistica, tipica del suo approccio storiografico. Il rifiuto del Senato, commenta, dimostra che “l’insegnamento salutare del messaggio divino non aveva bisogno né della conferma né dell’appoggio degli uomini”, mentre la successiva protezione offerta da Tiberio fu un atto della Divina Provvidenza per permettere la libera e iniziale diffusione del Vangelo. La sua opera, pur essendo una fondamentale collezione di documenti per la storia del cristianesimo primitivo, in questo caso specifico agisce come una cassa di risonanza per la tradizione apologetica inaugurata da Tertulliano. Lungi dal confermare la notizia con nuove prove, la ripresa di Eusebio ne rivela, implicitamente, la debolezza storiografica. Dovendo ricorrere a un apologeta cristiano del secolo precedente come unica e sola fonte per un evento di tale portata, Eusebio dimostra l’assenza di qualsiasi altra attestazione, pagana o cristiana, a lui nota, radicando così la narrazione unicamente nell’opera polemica di Tertulliano.
2. Le obiezioni della critica: le ragioni dello scetticismo maggioritario
La quasi totalità della storiografia moderna considera il racconto di Tertulliano una costruzione leggendaria. Questo scetticismo diffuso non si basa su un singolo argomento, ma su un insieme di obiezioni convergenti che formano un “caso cumulativo” difficilmente sormontabile.
2.1. L’argumentum e silentio: il silenzio assordante delle fonti pagane
L’argomento più pesante contro la veridicità del racconto è il silenzio completo e totale delle fonti pagane. Nessuno degli storici romani che scrissero diffusamente del regno di Tiberio — tra cui figure di primo piano come Tacito, Svetonio o Cassio Dione — menziona un evento così singolare e potenzialmente dirompente. Un dibattito formale in Senato sulla proposta di divinizzare un uomo giustiziato in Giudea per ordine di un prefetto romano sarebbe stato un episodio eccezionale, che avrebbe certamente attirato l’attenzione di storici meticolosi e attenti ai rapporti, spesso tesi, tra il princeps e l’assemblea senatoria.
Questo silenzio non può essere attribuito a disinteresse o ignoranza. Tacito, negli Annali, menziona esplicitamente Cristo, la sua esecuzione sotto Ponzio Pilato durante il regno di Tiberio, e la diffusione della “esiziale superstizione” (exitiabilis superstitio) a Roma, che portò alla persecuzione neroniana. Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, scrisse all’imperatore Traiano proprio per chiedere istruzioni su come procedere legalmente contro i cristiani. Il loro silenzio, quindi, non deriva da una mancanza di conoscenza del fenomeno cristiano, ma, con ogni probabilità, dal fatto che l’evento descritto da Tertulliano non accadde mai. L’inverosimiglianza storica della vicenda fornisce la spiegazione più logica per l’assenza di riscontri nelle fonti che, per prime, avrebbero dovuto registrarla.
2.2. Inverosimiglianza storica e giuridica
La proposta attribuita a Tiberio appare in stridente e quasi inspiegabile contraddizione con la sua nota politica religiosa e con il contesto storico degli anni ’30 del I secolo. Tiberio era un conservatore, legato al mos maiorum e profondamente rispettoso della tradizione religiosa romana. Solo pochi anni prima dei fatti narrati, nel 19, aveva promosso una dura repressione contro i culti stranieri a Roma, in particolare quelli egizi e giudaici, ritenuti fonti di disordine e incompatibili con la morale romana. In quell’occasione, migliaia di loro seguaci furono espulsi dall’Italia o deportati in Sardegna. Appare storicamente implausibile che lo stesso imperatore, così ostile alle superstitiones externae, proponesse pochi anni dopo di accogliere ufficialmente nel pantheon romano una figura proveniente dalla Giudea, una provincia percepita come turbolenta e culla di fanatismo religioso.
Anche dal punto di vista dei rapporti istituzionali la vicenda è poco credibile. Sebbene il Senato mantenesse formalmente la prerogativa di approvare nuovi culti (sacra peregrina) , è altamente improbabile che un imperatore del calibro di Tiberio, noto per il suo saldo controllo del potere dietro una facciata di rispetto per le forme repubblicane, avrebbe rischiato un’umiliazione pubblica su una questione così delicata, per poi subire un rifiuto e limitarsi a una blanda minaccia contro gli accusatori dei cristiani.
Infine, l’argomento più dirimente è la marginalità assoluta del cristianesimo in quel decennio. Negli anni immediatamente successivi alla morte di Gesù, il suo seguito era un fenomeno minuscolo, geograficamente confinato alla Palestina e percepito, al massimo, come una delle tante sette interne al giudaismo. È estremamente improbabile che avesse raggiunto una risonanza tale da giungere all’attenzione diretta dell’imperatore, ritirato a Capri, e da giustificare una deliberazione formale del Senato a Roma. Le fonti storiche e archeologiche indicano che una comunità cristiana organizzata a Roma è attestata con certezza solo in epoca più tarda, sotto l’imperatore Claudio (41-54), e che l’attenzione delle massime autorità romane si manifesterà in modo significativo solo con la persecuzione di Nerone nel 64, decenni dopo.
2.3. L’inaffidabilità di Tertulliano come fonte storica: un metodo apologetico
L’analisi del modus operandi di Tertulliano in altre sue opere fornisce la chiave di volta per comprendere l’origine del racconto. Il suo obiettivo primario non è l’accuratezza storiografica, ma la difesa appassionata e polemica del cristianesimo. Il suo metodo, tipico di un avvocato più che di uno storico, consiste nel mescolare abilmente storia, leggenda e interpretazione teologica, presentando l’insieme come un blocco unico di verità fattuali per sostenere le proprie tesi.
Un primo esempio emblematico è il racconto della “Legione Fulminata”, contenuto nello stesso Apologeticum. Tertulliano attribuisce a una legione interamente composta da soldati cristiani il merito di aver salvato l’esercito di Marco Aurelio da una terribile siccità durante le guerre marcomanniche (ca. 172-174), ottenendo la pioggia con le loro preghiere. L’episodio della pioggia provvidenziale è storicamente attestato, ma le fonti pagane lo attribuiscono a cause completamente diverse: le fonti romane lo imputano alle preghiere dell’imperatore o all’intervento di un mago egiziano, mentre la Colonna di Marco Aurelio raffigura la divinità pagana Giove Pluvio. La versione di Tertulliano è una chiara riscrittura cristiana di un evento noto, un’appropriazione apologetica per dimostrare la potenza del Dio cristiano e la lealtà dei suoi fedeli all’Impero.
Un secondo caso si trova nella sua opera De resurrectione carnis. Per argomentare a favore della risurrezione dei corpi, Tertulliano utilizza il mito della Fenice, descrivendone il ciclo di morte e rinascita non come una metafora o una leggenda, ma come un fenomeno naturale e documentato, una “prova” oggettiva che dovrebbe rendere credibile il dogma cristiano. Mentre fonti pagane come Plinio il Vecchio trattano la Fenice come una favola (fabulosum), Tertulliano la presenta come un fatto zoologico per sostenere per analogia la sua tesi teologica.
Questo schema argomentativo, che privilegia la persuasione sulla fedeltà storica, è una costante. Nel De corona militis, ad esempio, prende spunto da un fatto di cronaca — un soldato cristiano che rifiuta di indossare la corona d’alloro durante una cerimonia di premiazione — per sostenere la tesi radicale dell’incompatibilità tra la fede cristiana e il servizio militare, una posizione estremista che non rifletteva la prassi comune di molti cristiani dell’epoca. Le sue opere polemiche, come l’Adversus Iudaeos o lo Scorpiace (un “antidoto” contro l’eresia) , confermano la sua indole di polemista, più interessato a sconfiggere l’avversario che a fornire un resoconto equilibrato. Quando gli storici valutano il racconto su Tiberio, lo inquadrano inevitabilmente in questo contesto più ampio, vedendo un autore la cui priorità non è la cronaca accurata, ma la vittoria nella controversia.
3. La tesi di Marta Sordi: una difesa della storicità
In netto contrasto con la visione maggioritaria, la storica Marta Sordi ha dedicato una parte significativa della sua ricerca a contestare la liquidazione della notizia di Tertulliano come pura invenzione. Nella sua opera fondamentale I cristiani e l’impero romano e in diversi articoli specialistici, pur riconoscendo l’evidente intento apologetico dell’autore, Sordi sostiene che esso si innesti su un solido nucleo di verità storica, proponendo una ricostruzione basata su una rilettura del contesto politico e giuridico dell’epoca.
3.1. La ricostruzione della Sordi: oltre la leggenda apologetica
Il punto di partenza della Sordi è il rifiuto di considerare l’argumentum e silentio come decisivo. A suo avviso, l’argomento è intrinsecamente debole e, in questo caso specifico, inapplicabile. Ella nota, infatti, che Tacito, per l’anno 35, dichiara esplicitamente nei suoi Annali (VI.38) di volersi occupare solo di politica estera per “riposarsi l’anima dai mali interni” (animum requiescere a domesticis malis), lasciando così aperta la possibilità che eventi di politica religiosa interna non siano stati da lui registrati.
Sordi, come detto, non nega l’intento apologetico di Tertulliano, ma propone di separare il fatto storico dalla sua successiva elaborazione retorica. La sua tesi si fonda sull’idea che l’iniziativa di Tiberio non fu un atto di simpatia religiosa, ma una lucida mossa di Realpolitik.
3.2. Il contesto politico: un atto di Realpolitik
Secondo la ricostruzione della storica italiana, l’interesse di Tiberio per il cristianesimo fu eminentemente pragmatico. Informato da Ponzio Pilato (che Sordi, basandosi su altre fonti come Filone, non considera un governatore intrinsecamente ostile) della nascita in Giudea di una nuova setta giudaica, caratterizzata da un messianismo non politico e non anti-romano, l’imperatore avrebbe intravisto in essa un potenziale fattore di stabilizzazione per una provincia notoriamente turbolenta.
L’obiettivo strategico di Tiberio sarebbe stato quello di concedere al cristianesimo uno status giuridico autonomo, quello di religio licita, alla pari del giudaismo stesso. Questo avrebbe avuto un duplice vantaggio: da un lato, avrebbe sottratto i seguaci di Cristo alla giurisdizione e alle persecuzioni del Sinedrio di Gerusalemme, che li considerava eretici; dall’altro, avrebbe depotenziato il conflitto religioso interno alla Giudea, contribuendo a pacificare la regione. In questa prospettiva, la proposta formale al Senato non era un capriccio, ma il passo istituzionale necessario, secondo il diritto romano, per ottenere il riconoscimento ufficiale di un nuovo culto e renderlo legale all’interno dell’Impero.
3.3. L’argomento giuridico: il processo di Apollonio come chiave di lettura
Il punto cardine e più originale della tesi della Sordi è l’identificazione della fonte da cui Tertulliano avrebbe attinto la sua notizia. Non si tratterebbe di una tradizione orale o di un’invenzione, ma di un documento ufficiale: gli Atti del processo contro il senatore cristiano Apollonio, martirizzato a Roma sotto l’imperatore Commodo (ca. 183-185).
Sordi evidenzia come Eusebio di Cesarea, nella sua Storia ecclesiastica (V.21.4), affermi che Apollonio fu condannato a morte “in base a un senatoconsulto”. Gli Atti greci di quel martirio, a noi pervenuti, riportano la formula precisa di tale decreto: “Il senatoconsulto dice che non è lecito essere cristiani”. Sordi ipotizza che questo senatoconsulto, citato come base giuridica per una condanna nel 185, non fosse una legge recente, ma proprio l’antico decreto emesso in seguito al rifiuto della proposta di Tiberio nel 35.
La logica di questa ingegnosa ricostruzione è la seguente: Tertulliano, scrivendo pochi anni dopo il processo di Apollonio, avrebbe avuto accesso a questi atti processuali. In essi, avrebbe trovato la prova documentale di un antico senatus consultum che rendeva illegale la professione di fede cristiana. Avrebbe quindi collegato questo decreto negativo all’episodio originario della proposta di Tiberio, di cui forse aveva notizia da altre tradizioni, ricostruendo così l’intera vicenda. In questo modo, il racconto di Tertulliano non sarebbe un falso, ma una ricostruzione storica basata su una fonte giuridica reale, anche se conosciuta attraverso un contesto molto più tardo. Questa argomentazione sposta il carico della prova, costringendo la critica non solo a dimostrare l’inaffidabilità di Tertulliano, ma anche a spiegare l’origine del riferimento al senatus consultum nel processo di Apollonio.
4.Valutazione critica e sintesi storiografica
L’analisi comparata delle tesi contrapposte permette di valutare la solidità delle rispettive argomentazioni e di giungere a una sintesi storiografica equilibrata sulla natura del racconto di Tertulliano.
4.1. Confronto tra le tesi: ponderare le prove
La forza della tesi di Marta Sordi risiede senza dubbio nella sua ingegnosità e nella sua capacità di offrire una spiegazione razionale e politicamente plausibile per l’agire di Tiberio, allontanandosi da interpretazioni semplicistiche. Il suo collegamento con gli Atti di Apollonio fornisce una potenziale fonte documentale che eleva il dibattito, sfidando la liquidazione della notizia come una mera “menzogna” apologetica. Il suo approccio metodologico, che cerca sempre la logica interna agli eventi storici, è intellettualmente stimolante.
Tuttavia, questa costruzione erudita non riesce a superare in modo convincente il peso schiacciante e cumulativo delle obiezioni tradizionali. Il silenzio delle fonti pagane rimane un ostacolo massiccio. L’incoerenza con la politica religiosa di Tiberio a Roma e l’estrema marginalità del cristianesimo negli anni ’30 rendono lo scenario da lei dipinto, per quanto logicamente coerente al suo interno, storicamente molto improbabile. Inoltre, la premessa di fondo di una parte del suo pensiero, ovvero una sorta di “naturale sintonia” tra il cristianesimo e la cultura romana, è fortemente contestata da studiosi come Giancarlo Rinaldi, i quali vedono invece un conflitto insanabile tra due visioni del mondo antitetiche, dove il cristianesimo era percepito come una minaccia per le strutture sociali e religiose dell’impero.
4.2. Il processo di Apollonio: chiave di lettura o falsa pista?
Il collegamento con il processo di Apollonio, che costituisce il fulcro della tesi della Sordi, può essere interpretato in modo radicalmente diverso. Invece di provare la storicità dell’evento, potrebbe spiegare l’origine della leggenda in un altro modo. La debolezza fondamentale dell’argomentazione della Sordi risiede in un’ipotesi non dimostrata: che il senatus consultum menzionato nel processo di Apollonio sia necessariamente quello dell’epoca di Tiberio. Si tratta di un ponte gettato tra due eventi separati da 150 anni, la cui solidità si basa interamente su un’inferenza, per quanto dotta.
Un’interpretazione alternativa, e decisamente più economica, è che Tertulliano abbia operato una “retro-proiezione giuridica”. Vivendo in un’epoca (fine II secolo) in cui la base legale per la persecuzione era ormai consolidata, egli potrebbe aver proiettato questa realtà del suo tempo all’indietro. Il non licet esse christianos, menzionato nel processo di Apollonio, rappresentava la situazione legale de facto sotto Commodo. Tertulliano, da abile retore, avrebbe dato a questa prassi una “data di nascita” illustre e controversa — il Senato che si oppone al parere di un buon imperatore — per rendere la sua argomentazione apologetica più efficace e drammatica.
In quest’ottica, il processo di Apollonio non è la prova della storia di Tertulliano, ma ne è, molto più probabilmente, l’ispirazione. La condanna di un senatore richiedeva una base giuridica formale, e il riferimento a un senatus consultum serviva a questo scopo. Ma questo non prova l’antichità di tale decreto. Prova, piuttosto, che il sistema legale operava con una sua inerzia “burocratica”, risultato di un’evoluzione giuridica durata oltre un secolo.
Questa evoluzione non partì da una legge specifica. Il primo, violento scontro sotto Nerone (64) fu un atto di polizia arbitrario, usando i cristiani come capri espiatori per l’incendio di Roma, non l’applicazione di uno statuto. Fu Traiano, nel suo celebre rescritto a Plinio (ca. 112), a dare una prima, fondamentale forma giuridica: stabilì che il nomen ipsum (il solo “nome” di cristiano) era punibile, ma introdusse garanzie cruciali, vietando la ricerca attiva dei cristiani (conquirendi non sunt) e le denunce anonime.
Il suo successore, Adriano, affinò ulteriormente il quadro in un modo che ha generato un intenso dibattito storiografico. Nel suo rescritto a Minucio Fundano (ca. 124), egli ordinò che i cristiani fossero puniti solo se si dimostrava che avessero agito “contro le leggi” (aliquid contra leges). A prima vista, questo sembrerebbe aver abolito la punibilità del solo nome. Tuttavia, molti storici sostengono che Adriano non depenalizzò il nomen, ma intese semplicemente che l’accusa di “essere cristiano” (l’atto contra leges) dovesse essere provata in un processo formale, non basata su acclamazioni di piazza. L’effetto pratico e indiscutibile del suo rescritto fu un altro: minacciando severe punizioni per i calunniatori, rese estremamente rischioso presentare accuse false o pretestuose. Dunque, più che abolire la base giuridica, ne rese l’applicazione molto più difficile e garantista.
Era questo il complesso sistema legale in azione al tempo di Apollonio: una procedura matura che puniva il cristiani per il solo fatto di essere tali qualora però si fosse dimostrato che lo fossero. La notizia tramandata da Tertulliano, quindi, non sarebbe un resoconto di quanto effettivamente avvenuto nel 35, ma un’invenzione retorica che riflette le strategie legali e le autopercezioni dei cristiani sotto gli Antonini e i Severi. Il nesso causale si inverte: non è il senatoconsulto di Tiberio a spiegare il processo di Apollonio, ma è la realtà giuridica del processo di Apollonio — prodotto di una lunga evoluzione giuridica — a spiegare l’origine della costruzione retorica di Tertulliano. Il suo racconto non è storia, ma un’arringa difensiva brillante, mascherata da cronaca storica per attaccare la legittimità stessa delle leggi usate contro la sua gente.
Conclusione
Al termine di questa analisi, la profonda complessità della notizia riportata da Tertulliano emerge in tutta la sua evidenza. Da un lato, le obiezioni basate sul silenzio delle fonti, sull’inverosimiglianza storica e sul comprovato metodo apologetico di Tertulliano formano un caso quasi insormontabile contro la storicità dell’evento. La narrazione si inserisce perfettamente nello stile retorico dell’autore, che non esita a piegare la storia, la leggenda e il diritto per i suoi scopi difensivi.
Dall’altro lato, la tesi di Marta Sordi rappresenta un tentativo erudito e intellettualmente affascinante di salvare un nucleo di verità, offrendo una spiegazione politica pragmatica e una possibile fonte documentale. Tuttavia, la sua costruzione, per quanto ingegnosa, si regge su inferenze e collegamenti che rimangono ipotetici e non riescono a neutralizzare il peso schiacciante delle prove contrarie.
Il verdetto storiografico più probabile è che l’episodio del senatus consultum di Tiberio sia una leggenda apologetica. Non si tratta, però, di una semplice menzogna, ma di una sofisticata costruzione retorico-giuridica, creata da Tertulliano alla fine del II secolo. Il suo scopo era fornire al cristianesimo un nobile precedente di approvazione imperiale e spiegare l’origine della sua illegalità non come un fatto intrinseco alla politica romana, ma come il risultato della gelosia di un Senato superbo. Più che una finestra sugli eventi del 35, il racconto di Tertulliano è uno specchio prezioso delle battaglie ideologiche, legali e identitarie che la Chiesa affrontava alle soglie del III secolo, nel suo complesso e conflittuale rapporto con il potere di Roma.
Bibliografia
Barnes, T. D. (1971). Tertullian: A Historical and Literary Study. Clarendon Press, Oxford.
Bastiaensen, A. A. R. et al. (a cura di) (1987). Atti e passioni dei martiri. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, Milano.
Cassio Dione, C. (1995-2018). Storia romana. 9 voll. A cura di G. Norcio. BUR, Milano.
Eusebio di Cesarea (1979). Storia ecclesiastica. A cura di F. Maspero e M. Ceva. Rusconi, Milano.
Jossa, G. (1980). Gesù e i movimenti di liberazione della Palestina. Paideia, Brescia.
Momigliano, A. (2012). Essays in Ancient and Modern Historiography. University of Chicago Press, Chicago.
Orosio, P. (1882). Historiarum adversum paganos libri VII. A cura di K. Zangemeister. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 5. Teubner, Vienna.
Ovidio Nasone, P. (2015). Le metamorfosi. A cura di L. Koch. Einaudi, Torino.
Plinio il Vecchio (1982-1988). Storia naturale. 5 voll. A cura di G. B. Conte et al. Einaudi, Torino.
Rinaldi, G. (1991). ‘Procurator Felix’. Rivista Biblica, 29, pp. 452ss.
Sordi, M. (2004). I cristiani e l’impero romano. Jaca Book, Milano.
Svetonio Tranquillo, G. (1982). Vite dei Cesari. 2 voll. A cura di F. Dessì. BUR, Milano.
Tacito, P. C. (1981). Annali. 2 voll. A cura di B. Ceva. BUR, Milano.
Tertulliano, Q. S. F. (1984). Apologia del cristianesimo. A cura di C. Moreschini e L. Rusca. BUR, Milano.
Tertulliano, Q. S. F. (2013). Opere scelte. UTET, Torino.

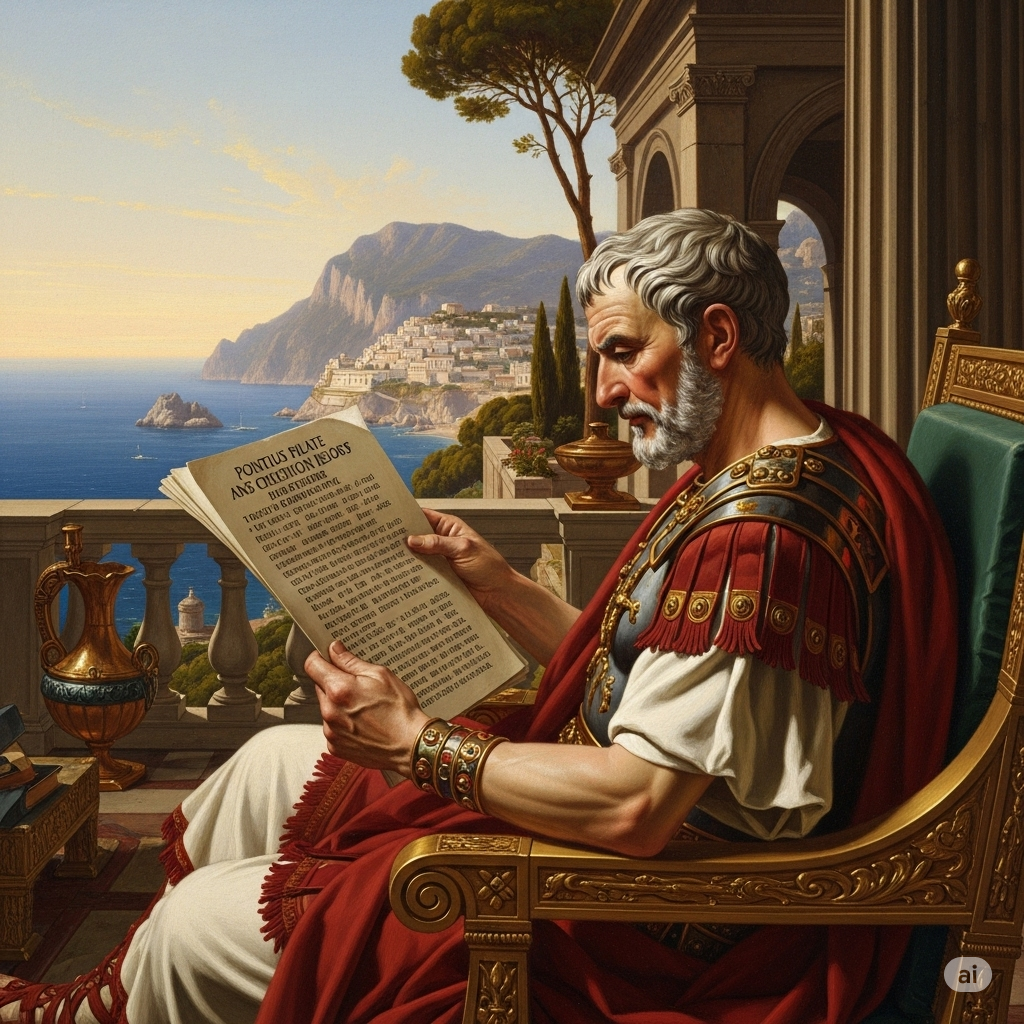
Concordo pienamente, anche perché su Tiberio e Ponzio Pilato disponiamo di una ampia documentazione apocrifa tesa a scaricare sul sinedrio e sui Giudei l’accusa di deicidio, e questa poteva ben essere nota a Tertulliano.
Tra le altre cose, Tertulliano sembra, nel riportare la notizia, fa un velato riferimento alla “conversione” di Pilato, un tema caro al filone orientale del ciclo apocrifo noto appunto come “Ciclo di Pilato”.
Ottimo articolo, che fornisce una affascinante ricostruzione di quel periodo storico