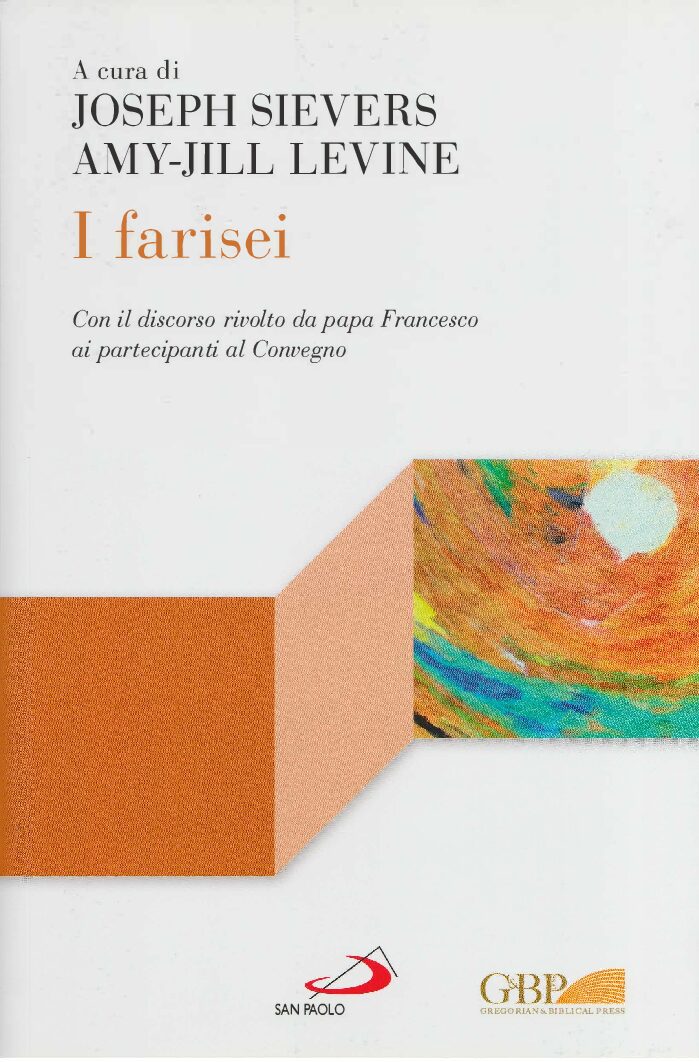Un’opera necessaria e un gesto profetico
La pubblicazione del volume I farisei, a cura di Joseph Sievers e Amy-Jill Levine, rappresenta un evento di eccezionale importanza nel panorama degli studi biblici e del dialogo ebraico-cristiano. Frutto di un convegno internazionale tenutosi presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma nel 2019, quest’opera non è una semplice raccolta di saggi accademici, ma un progetto organico e programmatico con una missione chiara: decostruire sistematicamente uno degli stereotipi più antichi, persistenti e dannosi della cultura occidentale. La scelta di aprire il volume con il discorso rivolto da papa Francesco ai partecipanti al convegno è un gesto di grande valore simbolico e teologico. Le parole del pontefice inquadrano l’intera impresa non come un mero esercizio erudito, ma come un imperativo etico e pastorale. Definendo il termine “fariseo” come “uno degli stereotipi più antichi e più dannosi”, Francesco collega direttamente la sua rappresentazione negativa alle radici dell’antisemitismo e invoca la ricerca accademica affinché contribuisca ad “acquisire una visione più veritiera” di questo gruppo. Questo avallo pontificio eleva lo scopo del libro da dibattito specialistico a tappa fondamentale nel dialogo ebraico-cristiano inaugurato dalla dichiarazione conciliare Nostra Aetate.
Il volume affronta di petto la schizofrenia culturale che circonda i farisei. Da un lato, nell’immaginario cristiano, essi incarnano la caricatura dell’ipocrita legalista, avido e xenofobo, simbolo di un giudaismo fossilizzato che Gesù avrebbe superato. Dall’altro, nella memoria ebraica, sono i maestri venerati del giudaismo del Secondo Tempio, gli innovatori che hanno esteso la santità dal Tempio alla vita quotidiana del popolo e che, con la loro apertura, hanno permesso alla tradizione di sopravvivere alla catastrofe del 70 a.C., ponendo le basi per il giudaismo rabbinico. Come esplicitato nella prefazione, l’obiettivo dei curatori è quello di colmare il divario tra la ricerca accademica e la percezione popolare, correggendo i “pregiudizi più nocivi” che ancora oggi infettano la predicazione, la catechesi, i libri di testo e persino la cultura secolare. Attraverso un approccio rigorosamente interdisciplinare e interreligioso, che riunisce studiosi ebrei, cattolici e protestanti, il libro si propone come un manuale indispensabile per chiunque voglia comprendere chi fossero realmente i farisei e come la loro immagine sia stata costruita e distorta nel corso di due millenni.
La decostruzione storica – chi erano i farisei?
La prima sezione del volume si addentra nel complesso e talvolta frustrante compito della ricostruzione storica. Il messaggio centrale che emerge è che i farisei storici sono una figura sfuggente, la cui comprensione può essere raggiunta solo attraverso una lettura critica e sfumata di fonti disparate, spesso frammentarie e quasi sempre ostili.
Le fonti e le sfide metodologiche: una ricerca in un terreno infido
Il percorso di ricerca inizia con la demolizione di false certezze. Il saggio di Craig Morrison sull’etimologia del nome “fariseo” dimostra in modo convincente come questa sia incerta e, in ultima analisi, non un’euristica utile per comprendere l’identità del gruppo. La traduzione più comune, “i separati”, solleva immediatamente la domanda: “separati da chi o da cosa?”. Morrison mostra come la ricerca di un significato etimologico sia stata spesso un esercizio di “irresponsabilità linguistica”, utilizzato per rafforzare pregiudizi preesistenti piuttosto che per illuminare la realtà storica.
Questa incertezza è aggravata dalla natura delle fonti, un punto sottolineato con forza da Vasile Babota. Non possediamo documenti scritti direttamente dai farisei, con la fondamentale eccezione delle lettere di Paolo. Le nostre fonti principali – Flavio Giuseppe, il Nuovo Testamento e la letteratura rabbinica successiva – sono tutte tendenziose e offrono ritratti parziali, modellati dalle loro agende teologiche o politiche. Un’ulteriore e fondamentale sfida metodologica riguarda il legame, spesso dato per scontato, tra i farisei del Secondo Tempio e i rabbini successivi. Günter Stemberger, nel suo contributo, invita a una visione “minimalista” di questa continuità. Egli mette in dubbio che figure centrali come Hillel o Jochanan ben Zakkai fossero identificate come farisei nelle prime fonti rabbiniche e suggerisce che molte delle pratiche ritenute “farisaiche” fossero in realtà parte di un più ampio “giudaismo comune”. Questa analisi critica mette in guardia contro la pratica anacronistica di proiettare retroattivamente le categorie del giudaismo rabbinico sul periodo del Secondo Tempio.
Un’immagine poliedrica dalle fonti antiche
Nonostante queste difficoltà, una lettura critica incrociata delle fonti permette di far emergere un’immagine dei farisei molto più complessa e sfaccettata dello stereotipo tradizionale.
L’archeologia, come illustra Eric Meyers, fornisce un correttivo materiale fondamentale. L’analisi della diffusione di miqva’ot (bagni rituali) e di vasellame in pietra calcarea (che non contrae impurità rituale) in Giudea e Galilea dimostra che le pratiche di purità erano estremamente diffuse in tutti gli strati della società ebraica, non un’esclusiva di un gruppo elitario o separatista. Questa evidenza materiale rafforza potentemente l’idea di un “giudaismo comune”, suggerendo che la peculiarità dei farisei non risiedeva tanto nelle pratiche quotidiane, quanto piuttosto nel loro approccio alla legge e alla tradizione.
Una prospettiva rivoluzionaria emerge dall’analisi di Vered Noam del testo qumranico 4QMMT. Questo documento, una polemica contro un gruppo rivale, elenca una serie di disaccordi di natura halakhica. Identificando le posizioni criticate con quelle che diventeranno poi la norma nel giudaismo rabbinico, Noam argomenta in modo convincente che i farisei non erano affatto dei conservatori rigidi, ma piuttosto degli innovatori e dei liberalizzatori della halakhà. Essi proponevano insegnamenti più indulgenti e popolari – ad esempio riguardo alla purificazione della giovenca rossa o all’impurità delle pelli – in opposizione alle visioni più severe e orientate alla classe sacerdotale dei sadducei e della comunità di Qumran. Questa visione è corroborata dal saggio di Yair Furstenberg, il quale dimostra come il ragionamento giuridico farisaico spesso mirasse a “minare la purezza e la santità” del sistema sacerdotale, rendendo la pietà più accessibile alla gente comune. Si delinea così un paradosso affascinante: i farisei, descritti come i custodi della “tradizione”, erano in realtà dei rivoluzionari. La loro innovazione consisteva probabilmente nel presentare le loro interpretazioni più miti e incentrate sull’uomo non come una rottura con la Torah, ma come il recupero del suo vero spirito, quello della “tradizione dei padri”, democratizzando di fatto la santità. Una tale mossa non poteva che provocare l’ira dei gruppi sacerdotali conservatori.
Il ritratto offerto da Flavio Giuseppe, analizzato magistralmente da Steve Mason, demolisce la vecchia tesi dello storico come un fariseo o un simpatizzante del movimento farisaico. Mason rivela il costante disprezzo aristocratico di Giuseppe per questo gruppo. Nelle sue opere, i farisei sono descritti come politicamente sediziosi, ipocriti e abili manipolatori delle masse, responsabili in larga misura della caduta della dinastia asmonea. Per Flavio Giuseppe, sacerdote e uomo di stato, l’influenza popolare dei farisei e il loro ricorso alla “tradizione” a scapito della legge scritta rappresentavano una pericolosa degenerazione dell’autorità legittima.
Infine, il Nuovo Testamento non offre un ritratto unico, ma una vera e propria galleria di immagini. Paula Fredriksen propone una rilettura radicale di Paolo, sostenendo che egli non smise mai di essere un “fariseo perfettamente giusto”. Il suo incontro con Cristo non fu una conversione dal giudaismo, ma il telos (compimento) della sua fede farisaica, in particolare della sua credenza nella risurrezione. La sua giustizia sotto la Legge era, per sua stessa ammissione, “senza difetti” (amemptos, Fil 3,6). Questa immagine è in netto contrasto con la rappresentazione polemica del Vangelo di Matteo, che, come dimostrano Henry Pattarumadathil e Adela Yarbro Collins, usa i farisei (spesso artificiosamente associati ai sadducei) come bersaglio retorico in una lotta intra-ebraica per l’autorità. Luca-Atti, secondo Hermut Löhr, offre un quadro più ambivalente: il Vangelo è generalmente negativo, ma gli Atti includono figure positive come Gamaliele e riconoscono l’esistenza di credenti farisei, suggerendo un contatto storicamente plausibile tra i gruppi. L’analisi di Harold Attridge del Vangelo di Giovanni, infine, si concentra sulla figura ambigua ma in definitiva positiva di Nicodemo, il quale dimostra che non tutti i farisei erano ostili e che non erano impermeabili al messaggio di Gesù.
Da questo mosaico di fonti emerge una sorprendente convergenza su un punto, nonostante l’ostilità della maggior parte dei testimoni: i farisei erano noti per la loro clemenza. Flavio Giuseppe li definisce “miti quanto a punizioni”. Le dispute legali nei testi qumranici e rabbinici li mostrano costantemente assumere la posizione più indulgente. Persino le critiche di Gesù (ad esempio sul divorzio) implicano che le loro regole fossero un compromesso con la debolezza umana, non espressioni di una rigidità spietata. Questa conferma incrociata è uno strumento potente per smantellare lo stereotipo popolare del fariseo crudele e legalista.
La storia della ricezione – come sono stati rappresentati i farisei?
La seconda parte del volume traccia la Wirkungsgeschichte (storia della ricezione) della figura del fariseo, mostrando come la complessa realtà storica sia stata progressivamente cancellata e sostituita da secoli di polemiche teologiche e rappresentazioni culturali.
Dall’antichità al medioevo: la costruzione di uno stereotipo
Il processo di trasformazione inizia molto presto. Come osserva Matthias Skeb, i primi Padri della Chiesa trasformarono i farisei da avversari storici di Gesù in archetipi teologici di eresia e ipocrisia. Giustino Martire li usò come esempio della discrepanza tra apparenza esteriore e realtà interiore, mentre Egesippo li vide come la fonte stessa delle eresie cristiane. L’analisi statistica di Luca Angelelli fornisce una prova quantitativa di questo slittamento, mostrando come l’uso dell’aggettivo pharisaikos (“farisaico”) con connotazione negativa emerga e raggiunga il suo apice nel IV secolo, cementando linguisticamente lo stereotipo.
Parallelamente, all’interno della tradizione ebraica, i farisei vennero in gran parte “dimenticati”. Shaye J. D. Cohen spiega che la prima letteratura rabbinica evita sistematicamente il termine, probabilmente a causa delle sue connotazioni negative e di una diversa auto-comprensione da parte dei Saggi. Essi furono “riscoperti” solo nel Medioevo attraverso lo Yosippon, una parafrasi ebraica di Flavio Giuseppe che per prima identificò esplicitamente i Saggi con i farisei. Abraham Skorka mostra come pensatori medievali del calibro di Maimonide interpretassero il termine perushim non come un partito storico, ma come un ideale di perishut (pietà, separazione), una postura etica piuttosto che un’identità di gruppo.
Dalla Riforma all’età moderna: il fariseo come “altro” polemico
La figura del fariseo, ormai stereotipata, fu poi riutilizzata e “armata” in successive dispute intra-cristiane. Randall Zachman dimostra come Martin Lutero e Giovanni Calvino usarono il “fariseo” come controfigura polemica della Chiesa Cattolica, equiparando la sua presunta giustizia basata sulle opere, il suo legalismo e la sua ipocrisia alla caricatura evangelica dei farisei.
Questa immagine negativa fu codificata visivamente nell’arte cristiana. Angela La Delfa traccia l’evoluzione iconografica da figure neutre alla rappresentazione stereotipata di uomini arroganti con abiti “ebraici” distintivi, spesso in contrasto con l’umile pubblicano o un compassionevole Gesù. La rappresentazione positiva di Nicodemo rimane una significativa e costante eccezione. Questa tradizione iconografica è proseguita nelle sacre rappresentazioni e nei media moderni. Christian Stückl offre un’affascinante testimonianza dall’interno dello sforzo consapevole di de-giudaizzare e de-fariseizzare i tropi antisemiti nella Passione di Oberammergau. Adele Reinhartz analizza come il cinema abbia sia perpetuato questi stereotipi (in film come Intolerance di Griffith o Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini) sia, in opere più recenti, li abbia sovvertiti o usati per criticare le istituzioni contemporanee (come in Jésus de Montréal di Arcand).
Questa sezione si conclude con la magistrale sintesi di Susannah Heschel e Deborah Forger, che ripercorre la storia della ricerca moderna, dalla riabilitazione ottocentesca dei farisei da parte di Abraham Geiger fino ai fondamentali dibattiti metodologici innescati da Jacob Neusner ed E. P. Sanders, mostrando il lento e faticoso percorso accademico verso un’immagine storica più accurata.
Da questa lunga storia della ricezione emerge con forza come la figura del “fariseo” sia stata costantemente utilizzata come archetipo polemico per l'”ipocrita interno al gruppo”. Gli evangelisti lo usarono contro la leadership ebraica rivale; i Padri della Chiesa contro gli eretici cristiani; i Riformatori contro i cattolici; i registi e i critici sociali moderni contro l’establishment contemporaneo. Ciò dimostra che lo stereotipo non è solo un antico pregiudizio, ma un’arma retorica durevole e adattabile. Il progetto storico del volume assume quindi una profonda valenza etica, poiché cerca di disarmare quest’arma svelandone la falsità storica.
Implicazioni pratiche e prospettive future
La sezione finale del volume affronta la rilevanza contemporanea della ricerca, passando dall’analisi storica all’applicazione pratica nell’educazione, nella predicazione e nel dialogo interreligioso.
Dall’accademia alla prassi: correggere l’insegnamento e la predicazione
Il volume evidenzia l’urgenza che questa ricerca accademica si traduca in una prassi educativa rinnovata. L’analisi di Philip A. Cunningham sui libri di testo di religione cattolica negli Stati Uniti e in Italia rivela la preoccupante persistenza di stereotipi negativi, spesso derivanti da una lettura acritica e letteralista dei Vangeli, in contrasto con gli stessi principi ermeneutici della Chiesa.
In risposta a questa sfida, il saggio di Amy-Jill Levine offre una vera e propria lezione magistrale di pedagogia e omiletica responsabili. Levine propone strategie concrete per predicatori e insegnanti: riconoscere il danno storico causato da questi testi, fornire un contesto storico adeguato (ad esempio, spiegando le leggi di purità come mezzo per celebrare l’identità ebraica), sfidare le letture anacronistiche e persino suggerire modifiche ai lezionari per evitare di proclamare testi che hanno alimentato l’odio. Con grande lucidità, diagnostica la “sordità culturale” e la “fragilità cristiana” che spesso impediscono di riconoscere il problema, offrendo al contempo strumenti pratici per un percorso di “disintossicazione”.
Un’opera fondamentale per il dialogo ebraico-cristiano
Per concludere, è possibile sostenere senza tema di smentita che I farisei si afferma come una risorsa essenziale e indispensabile, un vero e proprio “manuale”, come suggerito nella prefazione. Non si tratta di una semplice raccolta di saggi, ma di una dichiarazione programmatica e coerente che fornisce le fondamenta accademiche per una comprensione più accurata e giusta dei farisei.
Attingendo al saggio finale di Massimo Grilli e Joseph Sievers, è chiaro che il futuro degli studi sui farisei risiede nella continua collaborazione interdisciplinare e interreligiosa. L’obiettivo non è creare un nuovo stereotipo uniformemente positivo, ma apprezzare la complessità delle fonti e la realtà storica che esse, pur tra mille distorsioni, riflettono.
Il volume si chiude, e questa recensione con esso, riecheggiando la proposta finale dei curatori: che la cosiddetta Regola d’Oro, condivisa in forme diverse sia da Hillel sia da Gesù, serva da principio ermeneutico guida per ogni futuro impegno. Per comprendere i farisei, e per estensione il nostro “altro” religioso, dobbiamo sforzarci di comprenderli come vorremmo essere compresi noi stessi: con rigore storico, onestà intellettuale e profonda empatia. Quest’opera non solo ci insegna molto sui farisei, ma ci sfida a diventare lettori, studiosi e credenti migliori.
Per chi volesse acquistare il volume: https://amzn.to/3Uj3fEf