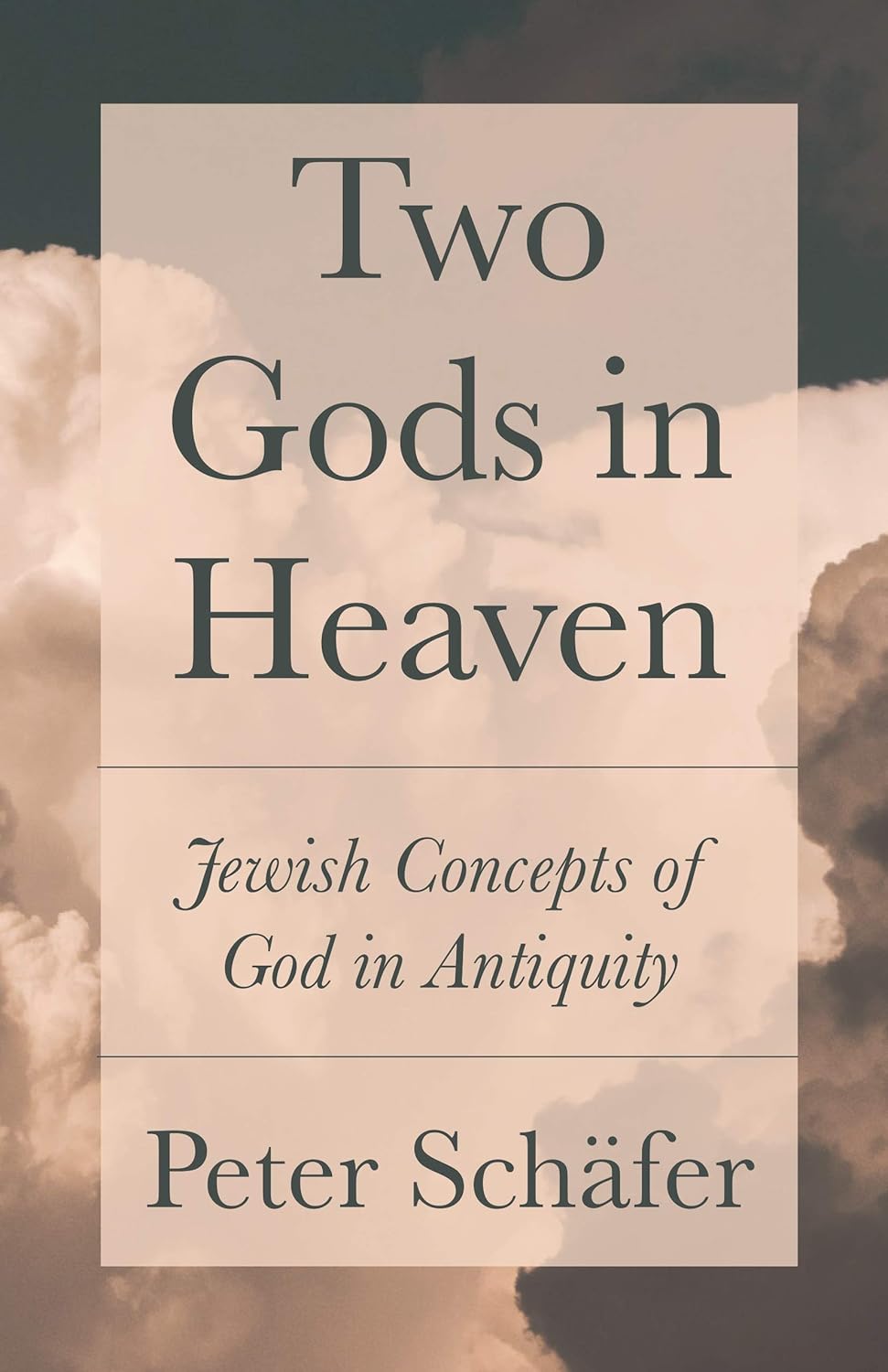Introduzione: sfidare il monoteismo, ridisegnare le origini
Nel suo magistrale e provocatorio studio, Two Gods in Heaven: Jewish Concepts of God in Antiquity, Peter Schäfer, uno dei massimi studiosi del giudaismo antico, si assume il compito monumentale di smantellare uno dei pilastri della teologia e della credenza popolare occidentale. Il punto di partenza dell’opera è la decostruzione di quello che Schäfer definisce un “cliché popolare” (p. 1): l’assunto che il giudaismo sia la religione monoteista per eccellenza, un baluardo di fede nell’unico Dio che si contrappone storicamente al politeismo pagano e, successivamente, alla complessità trinitaria del cristianesimo. Con meticolosa erudizione testuale e acume storiografico, Schäfer dimostra come questo quadro idealizzato “non regge a una revisione storica” (p. 1).
L’autore inizia col ricordare che il termine stesso “monoteismo” è un conio moderno, documentato per la prima volta nel 1660 dal filosofo inglese Henry More (p. 2), e che i modelli di sviluppo religioso che lo pongono o come culmine di un’evoluzione o come ideale originario degenerato nel tempo sono ormai obsoleti nella storia delle religioni. Al loro posto, Schäfer propone un “modello dinamico” che si muove tra i due poli di “monoteismo” e “politeismo”, riconoscendo l’esistenza di numerose configurazioni intermedie che si sono cristallizzate in tempi e luoghi diversi (p. 2). L’intero progetto del libro si fonda sulla premessa che il giudaismo antico non fu mai monolitico. La sua argomentazione non è semplicemente che “il binitarismo esisteva”, ma che la sua esistenza rivela una profonda e continua diversità teologica interna che l'”ortodossia” rabbinica cercò in seguito di gestire e sopprimere. Schäfer stabilisce questo punto mostrando prima elementi politeistici o enoteistici all’interno della stessa Bibbia ebraica — come la menzione di YHWH e della sua Asherah nelle iscrizioni di Kuntillet Ajrud, o il culto di altre divinità da parte dei mercenari ebrei di Elefantina (p. 3) — che dimostrano come la diversità non sia un'”eresia” tardiva ma una caratteristica antica e persistente.
La tesi centrale del volume è incapsulata nella frase rabbinica “due poteri in cielo” (sheteirashuyyot) (p. 6), che dà il titolo all’opera. Schäfer chiarisce di utilizzare il termine “binitario” per descrivere non un conflitto dualistico tra un dio buono e uno malvagio, come nello gnosticismo, ma piuttosto “due dèi che governano fianco a fianco e insieme, in diversi gradi di accordo e correlazione” (p. 6). Questa idea di una seconda figura divina accanto a Dio creatore non è, secondo l’autore, un’aberrazione, ma un filone persistente e vitale all’interno del pensiero ebraico, le cui radici affondano profondamente nel terreno fertile del giudaismo del Secondo Tempio.
Un elemento cruciale dell’analisi è la ridefinizione del rapporto tra giudaismo e cristianesimo. Schäfer respinge il modello lineare “madre-figlia” a favore di uno “scambio dinamico e vivace tra due religioni sorelle” (p. 5). In questa prospettiva, il giudaismo rabbinico e il cristianesimo primitivo non sono entità predefinite e separate, ma si sono cristallizzate gradualmente attraverso un processo dialettico di dialogo, appropriazione e polemica. Il cristianesimo non ha inventato le sue premesse cristologiche fondamentali — come l’idea di un Figlio di Dio incarnato e preesistente — ma le ha attinte da un ricco repertorio già presente nel giudaismo del Secondo Tempio. In questo contesto, Schäfer ridefinisce implicitamente il concetto di “eresia”. Non si tratta di una deviazione da un’ortodossia preesistente, ma del risultato di una lotta di potere per la definizione teologica. Le idee che egli traccia sono “eretiche” solo dal punto di vista retrospettivo della fazione rabbinica vittoriosa. La polemica rabbinica contro i “due poteri”, quindi, non è la prova di un giudaismo unificato che si difende da una minaccia cristiana esterna, ma piuttosto la prova di una potente fazione ebraica (i rabbini) che tenta di stabilire la propria visione teologica come normativa rispetto ad altre fazioni altrettanto “ebraiche”, come quelle dei mistici. Il libro è, in definitiva, la storia di un conflitto interno al giudaismo sulla natura di Dio, un conflitto che il cristianesimo ha sia ereditato che esacerbato.
Posizionandosi nel dibattito storiografico, Schäfer dialoga criticamente con studiosi come Alan Segal, la cui opera Two Powers in Heaven rimaneva intrappolata in un “corsetto metodologico” che vedeva i rabbini polemizzare contro “sette eretiche” esterne, e si allinea maggiormente con l’approccio di Daniel Boyarin, che ha evidenziato i conflitti interni al movimento rabbinico stesso (p. 6). Con Two Gods in Heaven, Schäfer offre una sintesi completa e audace, che per la prima volta integra sistematicamente il giudaismo del Secondo Tempio, il giudaismo rabbinico e la mistica ebraica antica in un’unica, avvincente narrazione (p. 8).
Parte I: le radici pre-cristiane del binitarismo nel giudaismo del Secondo Tempio
La prima mossa strategica di Peter Schäfer è quella di dimostrare in modo inequivocabile che l’arsenale concettuale per un “secondo dio” era pienamente sviluppato all’interno del giudaismo prima dell’emergere del cristianesimo. La Parte I del libro è dedicata a questa archeologia teologica, concentrandosi sulle tradizioni apocalittiche e sapienziali del periodo post-esilico, un’epoca di fervente creatività religiosa (pp. 17-18). L’organizzazione del materiale in questa sezione non è meramente cronologica; è una dimostrazione sistematica della creazione di quello che si potrebbe definire un “kit di strumenti binitario”. Schäfer mostra come diverse tradizioni ebraiche — apocalittica, sapienziale, filosofica — abbiano contribuito in modo indipendente con diversi strumenti concettuali che poterono essere (e furono) in seguito assemblati in varie combinazioni sia da ebrei che da cristiani.
Il Figlio dell’uomo e la Sapienza personificata
Il punto di partenza di quasi tutte le speculazioni binitarie successive è l’enigmatica figura del “Figlio dell’uomo” nel libro di Daniele. Schäfer analizza la visione di Daniele 7, in cui “uno simile a un essere umano” (ke−varenash) (p. 19) viene presentato all'”Antico di Giorni” e riceve un dominio eterno. Rifiutando le interpretazioni che vedono questa figura semplicemente come un simbolo del popolo di Israele o che leggono nel testo la presenza di due troni divini, Schäfer avanza la tesi che si tratti di una figura angelica suprema, distinta da Dio, molto probabilmente l’arcangelo Michele (p. 23). Questo angelo, elevato a uno status quasi divino, diventa il “punto di partenza e l’origine delle successive figure binitarie” (p. 24). Daniele fornisce così la grammatica visiva e il ruolo escatologico: una seconda figura, dall’aspetto umano, che riceve il dominio eterno nella corte celeste, anticipando in cielo la vittoria che il popolo di Israele attende sulla terra.
Parallelamente, la letteratura sapienziale offre un altro modello per una seconda figura divina: la Sapienza (in ebraico Hokhmah, in greco sophia) personificata. Schäfer esplora i testi canonici (Proverbi) e non canonici (Siracide, Sapienza di Salomone) per tracciare due filoni principali (p. 25).
Il primo, di stampo più biblico e presente nei Proverbi e nel Siracide, descrive la Sapienza come un’entità femminile, una “bambina” o una “figlia” di Dio, creata prima del mondo e che gioca alla sua presenza (p. 26). Questa Sapienza preesistente viene infine inviata sulla terra per risiedere in Israele, dove viene identificata con la Torah (p. 29). Il secondo filone, più influenzato dalla filosofia platonica e visibile nel libro della Sapienza, presenta la Sapienza come un’ “emanazione” (aporroia) o un’ “immagine” (eikōn) della perfezione di Dio, un archetipo divino che infonde la sua forza nel mondo (p. 28). La letteratura sapienziale fornisce così lo status ontologico: la preesistenza prima della creazione, sia come entità creata che come emanazione divina.
Figure divinizzate a Qumran e nella letteratura apocrifa
Le comunità del Secondo Tempio, in particolare quella di Qumran, spinsero queste idee ancora oltre. L’ Inno di Auto-glorificazione (4Q471b) presenta un oratore umano che si vanta di essere stato innalzato a un “trono potente” (kisse ‘oz) nella “congregazione degli dèi” (elim, cioè gli angeli) (p. 33), con una gloria che supera quella dei re del passato. Schäfer interpreta questo testo come un chiaro caso di apoteosi, la “divinizzazione di un essere umano” (p. 37), un passo fondamentale nella concettualizzazione di un uomo che può raggiungere uno status divino.
L’ Apocrifo di Daniele (4Q246) compie un ulteriore passo avanti, utilizzando esplicitamente i titoli di “Figlio di Dio” (berade′el) e “Figlio dell’Altissimo” (bar′elyon) (p. 39) per descrivere una figura messianica. Schäfer sostiene che questa figura, lungi dall’essere un re ellenistico malvagio come proposto da alcuni studiosi, è un salvatore escatologico positivo, un rappresentante celeste del “popolo di Dio” a cui è riservato il giudizio finale (p. 44). La sua vicinanza a Dio è “senza precedenti”, pur mantenendo una distinzione dal “grande Dio” che gli garantisce la vittoria.
Questa traiettoria culmina nella letteratura apocrifa. Nelle Parabole di Enoc, il “Figlio dell’uomo” preesistente, che siede sul trono di gloria come giudice escatologico, viene drammaticamente identificato nei capitoli finali (70-71) con il patriarca umano Enoc, che viene rapito in cielo e trasformato (pp. 49-51). Questa fusione tra un essere celeste e un essere umano divinizzato rappresenta un momento fondamentale. Allo stesso modo, il Quarto Libro di Esdra identifica il “Figlio dell’uomo” con il Messia davidico e lo chiama esplicitamente “mio figlio” (filius meus) (p. 55). Schäfer insiste che questo titolo debba essere inteso letteralmente, presentando un “dio più giovane accanto a suo padre, il dio più anziano” (p. 58). Qumran e gli apocrifi forniscono così il meccanismo dell’apoteosi e i titoli espliciti: un essere umano può essere elevato a uno status divino e la seconda figura può essere chiamata “Figlio di Dio”.
L’apice filosofico: il Logos come “secondo dio”
L’apice di questa evoluzione concettuale si trova nell’opera del filosofo ebreo di Alessandria, Filone (ca. 20 a.C. – ca. 50 d.C.). Schäfer analizza come Filone, nel suo tentativo di armonizzare la Bibbia ebraica con la filosofia platonica, sviluppi la dottrina del Logos. Questo Logos non è solo la forza creativa di Dio, ma è descritto con titoli che ormai ci sono familiari: “primogenito” (prōtogonos), “arcangelo” (archangelos), “l’uomo a sua immagine” e persino “Israele” (p. 63). Il passo più audace, tuttavia, è quando Filone definisce esplicitamente il Logos come un “secondo dio” (deuterontheon), un intermediario necessario tra il Dio trascendente e il mondo creato (p. 63). Con Filone, conclude Schäfer, “il giudaismo difficilmente potrebbe avvicinarsi di più a ciò che si svilupperà nella cristologia” (p. 64). Filone fornisce così la giustificazione filosofica per l’esistenza di una seconda potenza divina.
Alla fine del periodo del Secondo Tempio, il giudaismo non aveva un solo, ma molteplici modelli ben sviluppati per una seconda potenza divina. Il cristianesimo non ha inventato questa idea; ha selezionato e adattato concetti da un ricco e variegato mercato teologico ebraico preesistente.
Parte II: la tradizione binitaria nel dialogo con il cristianesimo: giudaismo rabbinico e mistica ebraica antica
Se la prima parte del libro stabilisce in modo convincente le radici pre-cristiane del binitarismo ebraico, la seconda parte affronta la questione più spinosa e originale: cosa accadde a queste idee dopo che il cristianesimo se ne appropriò per definire la propria cristologia? La risposta di Peter Schäfer, che costituisce il cuore del suo contributo più innovativo, è che esse non furono semplicemente abbandonate, ma furono attivamente dibattute, soppresse e trasformate all’interno del giudaismo stesso, in un dialogo serrato e spesso polemico con la nascente religione sorella (pp. 11, 69).
La divergenza tra Palestina e Babilonia
L’argomentazione di Schäfer in questa sezione è fondamentalmente geopolitica. Le possibilità teologiche per gli ebrei, egli sostiene, furono direttamente modellate dal loro rapporto con il potere cristiano dominante. Egli traccia una netta divergenza tra i due principali centri del giudaismo tardoantico.
In Palestina, sotto il diretto dominio romano e poi bizantino, dove il cristianesimo divenne religione di stato, l’identità ebraica richiese la creazione di confini netti. Le idee binitarie, così centrali per la cristologia, divennero teologicamente tossiche. Schäfer sostiene che la tradizione del “Figlio dell’uomo” divenne “praticamente irrilevante” nel giudaismo rabbinico palestinese, proprio a causa della sua “usurpazione… da parte del Nuovo Testamento” (p. 11). A riprova di ciò, egli analizza un passo della Mekhilta, un midrash palestinese, confutando l’interpretazione di Daniel Boyarin secondo cui vi si celerebbe un midrash sul Figlio dell’uomo come dio giovane. Per Schäfer, il testo non ha alcuna agenda nascosta e la tradizione fu semplicemente soppressa per reazione polemica (p. 71).
La situazione in Babilonia era radicalmente diversa. Sotto l’Impero Sasanide, gli ebrei erano una minoranza riconosciuta e i cristiani, a volte, una minoranza perseguitata. La pressione politica era differente. Qui, gli ebrei avevano lo “spazio teologico” per riappropriarsi e rivendicare la propria eredità binitaria come forma di espressione autenticamente ebraica, anche se questa riecheggiava idee cristiane. È in Babilonia, quindi, che “le idee binitarie sopravvissero” e furono persino intensificate (p. 12). Questa distinzione geopolitica è una chiave di volta della tesi di Schäfer.
Davide sul trono celeste e la polemica sui “due poteri”
La prova più evidente di questa sopravvivenza babilonese si trova nel Talmud Babilonese. Schäfer offre un’analisi approfondita del famoso passo di b. Hagigah 14a, che discute il plurale “troni” in Daniele 7,9. In questo testo, a Rabbi Aqiva viene attribuita l’interpretazione radicale e “eretica” secondo cui i due troni sarebbero “uno per lui e uno per Davide” (p. 82). Questa identificazione del Messia-Re Davide con il Figlio dell’uomo di Daniele, innalzato a un trono celeste, rappresenta una continuazione diretta delle tradizioni del Secondo Tempio.
Tuttavia, il Talmud non si limita a registrare questa opinione. Al contrario, inscena una sua confutazione sistematica. Altri rabbini attaccano con veemenza Aqiva, accusandolo di profanare la divinità. L’interpretazione viene progressivamente ridimensionata: i due troni diventano simboli degli attributi divini della “giustizia” e della “misericordia”, o addirittura, nella versione più conservatrice, un semplice trono con il suo sgabello (pp. 82-84). In questa lettura, il Talmud Babilonese si rivela non un semplice archivio di tradizioni, ma un documento accuratamente redatto che mette in scena e risolve conflitti teologici. I redattori talmudici non nascondono l’opinione “eretica”; la preservano, attribuendola a una figura autorevole come Aqiva, proprio per poter dimostrare la sua autorevole confutazione. La conservazione dell'”eresia” è essenziale per la performance della sua sconfitta.
Schäfer collega questa polemica talmudica all’Apocalisse di Davide, un testo della letteratura delle hekhalot (la mistica ebraica antica), che egli presenta come la prova dell’esistenza stessa della tradizione contro cui il Talmud si scagliava. In questo testo mistico, Davide viene effettivamente innalzato in cielo e intronizzato su un trono di fuoco “di fronte al trono del suo creatore” (p. 91), assumendo pienamente il ruolo del Figlio dell’uomo e del Messia-Re.
L’apoteosi di Enoc-Metatron, lo “YHWH minore”
La traiettoria più spettacolare del binitarismo ebraico tardoantico è quella legata alla figura di Enoc. Schäfer traccia un percorso che va dalla sua radicale degradazione alla sua suprema esaltazione. Nel Genesi Rabbah, un testo palestinese, la tradizione della sua ascesa celeste viene capovolta. Enoc è descritto come un “malvagio” e un “ipocrita” che morì di morte naturale (p. 103). Schäfer interpreta questa inversione come una mossa polemica diretta contro l’uso che il cristianesimo faceva di Enoc come precursore di Cristo, che non aveva conosciuto la morte (p. 107).
Ancora una volta, è in Babilonia e nella letteratura mistica che la tradizione riemerge con una forza senza precedenti. Nel Terzo Libro di Enoc (o Sefer Hekhalot), assistiamo a una sbalorditiva apoteosi. L’uomo Enoc non viene solo trasformato in un angelo, ma nell’angelo supremo, Metatron. Schäfer descrive in dettaglio questo processo: la sua trasformazione in un essere di fuoco, la sua intronizzazione su un trono che eguaglia quello divino, il suo ruolo di viceré di Dio a cui tutti gli angeli devono obbedienza. Il culmine viene raggiunto quando Dio stesso gli conferisce il proprio nome e il titolo di “YHWH minore” (YHWH haqatan) (p. 110). Questa è la vetta delle tradizioni binitarie nel giudaismo tardoantico.
Tuttavia, anche qui, il testo stesso contiene la propria contro-narrazione. Immediatamente dopo l’esaltazione di Metatron, viene inserito l’episodio di Elisha ben Avuyah (noto come Aher, “l’Altro”). Aher, un rabbino che diventerà l’archetipo dell’eretico, ascende al cielo, vede Metatron seduto sul suo trono e dichiara: “Ci sono davvero due poteri in cielo!” (p. 113). Per questa affermazione “eretica”, sia Aher che lo stesso Metatron (per non essersi alzato e aver così indotto l’errore) vengono puniti. La presenza di questa polemica all’interno dello stesso testo che esalta Metatron è, per Schäfer, la prova definitiva che il dibattito era interno al giudaismo. Il testo contiene sia l’esaltazione “eretica” che la confutazione “ortodossa”. Altre figure, come Akatriel (un altro nome di Metatron), e altre polemiche talmudiche, come quella contro Rav Idith (p. 124), servono a rafforzare l’immagine di un’élite rabbinica impegnata in uno sforzo concertato per “disinnescare l’idea binitaria” (p. 14) che era chiaramente prevalente e attraente nei circoli mistici babilonesi.
Valutazione critica e conclusione: una risposta ebraica al Cristo
Al termine di questo viaggio erudito e affascinante attraverso secoli di pensiero ebraico, Peter Schäfer tira le somme in una conclusione che è tanto sintetica quanto potente. La traiettoria delineata nel libro è chiara: dallo sviluppo pre-cristiano di un “kit di strumenti binitario” nel giudaismo del Secondo Tempio, si passa alla complessa vita post-cristiana di queste idee, caratterizzata dalla soppressione in Palestina e da una vivace e polemica rinascita in Babilonia (p. 134).
L’autore pone un’enfasi particolare su quella che considera la distinzione fondamentale e invalicabile tra il binitarismo ebraico e la cristologia cristiana: l’incarnazione. Sebbene il giudaismo abbia sviluppato il concetto di una seconda figura divina, e persino di un essere umano che subisce un’apoteosi e diventa divino, non ha mai varcato la soglia dell’incarnazione. Nel pensiero ebraico, come scrive Schäfer, “l’umanità dell’ ‘umano’ che diventa ‘dio’… si estingue”, la sua forma terrena viene trascesa e annullata nella trasformazione celeste. Al contrario, nel cristianesimo, l’incarnazione — il divino che si fa carne e abita il mondo come essere umano — è il meccanismo centrale e indispensabile della redenzione (p. 136). Questa, per Schäfer, è la differenza fondamentale che ridefinisce irrevocabilmente i percorsi delle due religioni.
Questa distinzione permette a Schäfer di formulare la sua tesi finale, la più audace del volume. Il binitarismo del giudaismo babilonese tardoantico, in particolare quello espresso nella letteratura delle hekhalot, non fu una semplice sopravvivenza di idee antiche, né un’imitazione del cristianesimo. Fu, piuttosto, una “risposta… genuinamente ebraica” alle affermazioni cristiane (p. 138). Fu una riappropriazione della propria eredità pre-cristiana, un modo per competere con il cristianesimo su un terreno teologico condiviso. La disputa non era più se potesse esistere una seconda figura divina — un’idea che, come dimostra Schäfer, era profondamente radicata in certi filoni del giudaismo — ma chi fosse quella figura: Davide o Metatron per questi circoli ebraici, contro Gesù per i cristiani. Il giudaismo babilonese, in questa lettura, non si limitò a una reazione difensiva e delimitante, ma rispose in modo affermativo, sviluppando una propria “cristologia” ebraica, centrata su figure come il Messia-Re Davide o il patriarca divinizzato Enoc.
In conclusione, Two Gods in Heaven si impone come uno studio davvero intererssante, che costringe a riconsiderare le narrazioni convenzionali sulle origini sia del giudaismo rabbinico che del cristianesimo primitivo. Con una meticolosa analisi testuale e una tesi audace e coerente, Peter Schäfer non solo illumina la sorprendente diversità interna del pensiero ebraico antico, ma dimostra anche la fluidità dei confini religiosi nella tarda antichità. Il libro non è semplicemente un catalogo di idee binitarie, ma una profonda riflessione su come le identità religiose si formino attraverso processi complessi di dialogo, conflitto e riappropriazione. È un’opera che rimodella la nostra comprensione delle origini intricate e intrecciate di due delle più influenti tradizioni religiose del mondo, rivelando una storia molto più complessa e affascinante di quanto il semplice cliché del monoteismo ebraico abbia mai lasciato intendere.
Per chi volesse acquistare il volume: https://amzn.to/4f7JDNa