Introduzione: Un approccio storico alla Bibbia ebraica
L’opera Antico Testamento di Thomas Römer, curata per l’edizione italiana (Claudiana 2025) da Daniele Garrone, si propone come una densa e rigorosa introduzione storica alla Bibbia ebraica. Fin dalla prefazione, l’autore chiarisce il proprio intento: esplorare il contenuto di quella che definisce una “biblioteca” , analizzando le modalità di compilazione e canonizzazione dei suoi vari libri e inserendoli nel loro contesto storico, un arco temporale che si estende per oltre un millennio. L’approccio dichiarato è quello di rendere il testo accessibile a un pubblico vasto, invitando i lettori a consultare direttamente una Bibbia per seguire gli sviluppi presentati.
Tuttavia, la struttura e il metodo del volume rivelano un obiettivo più profondo. L’opera non è semplicemente una guida ai contenuti dell’Antico Testamento, ma funge da introduzione propedeutica al metodo storico-critico stesso. Invece di iniziare con i racconti della Genesi, Römer dedica i primi capitoli a questioni fondamentali come la definizione dei canoni, la storia della trasmissione testuale e la ricostruzione della storia di Israele e Giuda. Questa scelta metodologica posiziona il lettore non come un fedele che riceve una rivelazione, ma come uno studioso che analizza un complesso artefatto storico-letterario. Il libro, pertanto, socializza il lettore alla disciplina accademica degli studi biblici, fornendo gli strumenti critici necessari per comprendere i testi non come opere monolitiche e atemporali, ma come il prodotto di lunghi e complessi processi redazionali, influenzati da contesti politici, sociali e teologici in continua evoluzione. Sottolineando l’importanza della Bibbia come parte del “patrimonio letterario e filosofico dell’umanità”, Römer ne rivendica la rilevanza culturale al di là dei confini confessionali, un presupposto che guida l’intera analisi.
La struttura della “biblioteca”: Torah, Profeti e Scritti
Uno dei contributi più significativi del volume è la chiara delucidazione delle differenze strutturali e contenutistiche tra la Bibbia ebraica, o TaNaK, e le diverse versioni dell’Antico Testamento cristiano. Römer sottolinea come l’affermazione che i due corpora corrispondano sia imprecisa, poiché nessuna delle varianti cristiane (cattolica, ortodossa, protestante) coincide pienamente con il canone ebraico.
L’Antico Testamento cattolico, basato sul canone della Bibbia greca (la Settanta) e ripreso dalla Vulgata latina, include un numero maggiore di libri, i cosiddetti deuterocanonici (come Maccabei, Tobia, Giuditta, Sapienza e Siracide), e presenta versioni più ampie di alcuni testi come Ester e Daniele. La sua organizzazione è quadripartita: Pentateuco, Libri storici, Libri sapienziali e Libri profetici. Le Chiese ortodosse adottano canoni ancora più estesi, che possono includere (come nel caso di quella etiope) opere come Enoc o i Giubilei. L’Antico Testamento protestante, nato dalla volontà dei Riformatori di tornare alla hebraica veritas, adotta per l’Antico Testamento solo i libri presenti nel canone ebraico; tuttavia, ne mantiene l’organizzazione cristiana in quattro sezioni.
Questa differenza strutturale non è un mero dettaglio organizzativo, ma costituisce un’argomentazione teologica intrinseca. La collocazione dei Profeti alla fine del canone cristiano crea un ponte narrativo verso il Nuovo Testamento: i profeti annunciano la venuta di un messia, e i Vangeli presentano Gesù di Nazaret come il compimento di tale promessa. L’ultimo profeta, Malachia, che preannuncia il ritorno di Elia, stabilisce un legame diretto con le narrazioni evangeliche. Al contrario, la struttura tripartita del TaNaK, che si conclude con gli Scritti e spesso con il libro delle Cronache, orienta il lettore verso una traiettoria teologica differente. L’appello finale di Ciro a “salire” a Gerusalemme (II Cr. 36,23) non proietta verso un futuro messianico, ma richiama alla terra, alla ricostruzione del Tempio e alla centralità della comunità radunata attorno alla Torah. In questo modo, le due diverse disposizioni canoniche costruiscono due “macro-narrazioni” distinte a partire da un corpus testuale largamente condiviso.
Il TaNaK, acronimo delle sue tre sezioni, è così strutturato:
- Torah (Pentateuco): I cinque libri di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Costituisce il cuore del canone ebraico e viene letta integralmente nel culto sinagogale. Römer la presenta come una “biografia di Mosè”, che ne narra la vita dalla nascita alla morte, ma che si conclude deliberatamente con una nota di incompiutezza: il popolo è alle soglie della Terra Promessa, ma non vi è ancora entrato.
- Nevi’im (Profeti): Questa sezione è a sua volta suddivisa in Profeti anteriori (Giosuè, Giudici, Samuele, Re), di carattere prevalentemente storico-narrativo, e Profeti posteriori (Isaia, Geremia, Ezechiele e i Dodici profeti minori), che raccolgono oracoli e resoconti dell’attività profetica. Nel culto, i Profeti sono usati per commentare le letture della Torah.
- Ketuvim (Scritti): È la sezione più eterogenea, una vera e propria antologia di generi letterari diversi. Include opere poetiche (Salmi, Lamentazioni), testi sapienziali (Giobbe, Proverbi, Qoèlet), racconti (Rut, Ester), un libro apocalittico (Daniele) e opere storiografiche (Esdra-Neemia, Cronache). Questi testi vengono letti solo in occasioni liturgiche specifiche.
La tabella seguente, basata sulle sinossi presentate nel volume, illustra visivamente le principali differenze tra il canone ebraico e quello cattolico.
| TaNaK (Bibbia ebraica) | Antico Testamento cattolico |
| 1. Torah | 1. Pentateuco |
| Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio | Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio |
| 2. Nevi’im (Profeti) | 2. Libri storici |
| Profeti anteriori: Giosuè, Giudici, I/II Samuele, I/II Re | Giosuè, Giudici, Rut, I/II Samuele, I/II Re, I/II Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester (greco), I/II Maccabei |
| Profeti posteriori: Isaia, Geremia, Ezechiele, I Dodici | |
| 3. Ketuvim (Scritti) | 3. Libri sapienziali |
| Salmi, Giobbe, Proverbi, Rut, Cantico dei cantici, Qoèlet, Lamentazioni, Ester, Daniele, Esdra-Neemia, I/II Cronache | Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet, Cantico dei cantici, Sapienza, Siracide |
| 4. Libri profetici | |
| Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruc, Ezechiele, Daniele, I Dodici |
La costituzione del canone: Un processo secolare
Il processo di canonizzazione, come ricostruito da Römer, non fu un singolo evento, ma uno sviluppo graduale e secolare, guidato da precise necessità storiche e teologiche. Questo percorso può essere suddiviso in tre fasi principali, corrispondenti alla progressiva chiusura delle tre sezioni del TaNaK.
La prima fase fu la promulgazione del Pentateuco, che Römer colloca nel IV secolo a.e.v., durante il periodo persiano. La perdita dell’autonomia politica e la dispersione geografica del popolo giudaico resero necessaria la creazione di un nuovo fondamento identitario. Il Pentateuco nacque come un testo di compromesso, frutto della collaborazione tra diverse élite intellettuali e sacerdotali: quelle rimaste a Gerusalemme, quelle legate al santuario samaritano sul monte Garizim e quelle influenti della diaspora babilonese. Questa origine composita spiega la coesistenza di tradizioni e leggi a volte divergenti, come la teologia centralizzatrice del Deuteronomio (Deut. 12) accanto a testi più antichi che ammettono una pluralità di luoghi di culto (Es. 20,24). In questa fase, si svolse un dibattito fondamentale sull’estensione della Torah. L’opzione di un “Esateuco”, che includeva il libro di Giosuè e quindi il racconto della conquista, fu scartata a favore di un “Pentateuco”, che si conclude con la morte di Mosè fuori dalla Terra Promessa. Questa scelta, secondo Römer, riflette la realtà di un giudaismo che stava diventando una religione della diaspora, per la quale l’obbedienza alla Legge (la “patria portatile”) diventava più fondamentale del possesso fisico della terra.
La seconda fase fu la canonizzazione dei Profeti, che gli studiosi collocano intorno al 200 a.e.v.. Questa raccolta fu creata unendo i libri “storici” (da Giosuè ai Re) con gli scritti profetici propriamente detti. L’intento era quello di costruire una grande narrazione della storia di Israele, dalla conquista fino all’esilio, interpretandola alla luce della parola profetica, che ne spiegava le cause (la disobbedienza) e ne annunciava la possibile restaurazione. Questo corpus fu deliberatamente concepito come subordinato alla Torah, come dimostrano i “ganci” testuali all’inizio (Gios. 1,7) e alla fine (Mal. 3,22), che richiamano esplicitamente la “legge di Mosè”. La chiusura di questa sezione avvenne probabilmente in epoca ellenistica, e l’esclusione del libro di Daniele, la cui forma definitiva risale al 164 a.e.v. [il testo adotta a.e.v. e e.v. al posto dei più consueti, per il lettore italiano, a.C. e d.C.], è un forte indizio a favore di questa datazione.
La terza e ultima fase fu la chiusura degli Scritti e del canone tripartito, un processo che si concluse solo nel II secolo e.v.. Questo atto finale fu una reazione a una serie di crisi e sfide: la distruzione del Secondo Tempio nel 70 e.v., che rese l’interpretazione delle Scritture il nuovo centro della vita religiosa; la necessità di consolidare l’identità del giudaismo farisaico-rabbinico; la proliferazione di scritti apocalittici che sollevavano interrogativi su quali libri fossero “sacri”; e, infine, la necessità di distinguersi dal nascente cristianesimo, che stava a sua volta definendo il proprio canone basandosi sulla traduzione greca delle scritture ebraiche. Il processo fu tutt’altro che lineare, come dimostrano le lunghe discussioni rabbiniche sulla “santità” di libri come Qoèlet, Ester e il Cantico dei Cantici, che si protrassero fino al IV secolo e.v.
L’intero processo di canonizzazione può essere letto come un progressivo “addomesticamento” della rivelazione divina. Si passa da una forma aperta e carismatica, come la profezia, a un corpus testuale chiuso e gerarchicamente strutturato, con la Torah al suo vertice. La parola profetica viene incorniciata e subordinata all’autorità della Legge, e l’idea stessa che la profezia sia terminata con gli ultimi profeti dell’epoca persiana serve a consolidare l’autorità del testo scritto, la cui interpretazione diventa il nuovo fulcro della vita religiosa, gestita da una classe di saggi e scribi.
Dal papiro al codice: La trasmissione materiale del testo
Il capitolo dedicato a “Testi e manoscritti” demistifica l’idea di un testo biblico unico e immutabile, illustrando la sua complessa storia materiale. Römer evidenzia come i testi biblici, al pari di ogni altra opera dell’antichità, abbiano attraversato una lunga storia di trasmissione, revisione e riscrittura.
I primi testi non furono redatti nella scrittura ebraica “quadrata” oggi familiare, ma in una scrittura alfabetica più antica, di tipo paleo-ebraico o “fenicio”, come testimoniano importanti iscrizioni extra-bibliche quali la Stele di Mesha e l’iscrizione di Tel Dan. I supporti di scrittura erano vari e determinati dalla funzione del testo: la pietra per le iscrizioni monumentali, l’intonaco dei muri, i frammenti di ceramica (ostraca) per appunti e lettere, il papiro (importato dall’Egitto e raramente conservatosi a causa dell’umidità) e, soprattutto, il cuoio, che sarebbe poi evoluto nella pergamena. Per secoli, la forma del “libro” fu il rotolo; il codice, ovvero il libro rilegato, si affermò solo in epoca tardo-ellenistica, soprattutto grazie alla pratica cristiana di riunire l’intero canone in un unico volume.
Il percorso verso il testo standardizzato, noto come Testo Masoretico, fu un processo lungo e deliberato. La prima fase, la fissazione del testo consonantico, iniziò dopo la distruzione del Tempio nel 70 e.v., spinta dalla necessità di rafforzare l’identità giudaica e di creare un testo di riferimento in opposizione all’uso che i cristiani facevano delle traduzioni greche. Gli scribi (sopherim) e i loro successori, i masoreti, si assunsero il compito di trasmettere il testo. Non osando modificarlo, idearono un sistema di note critiche per segnalare le difficoltà, come i puncta extraordinaria o la distinzione tra ketib (“ciò che è scritto”) e qere (“ciò che si deve leggere”). La seconda fase, molto più tarda (a partire dal VII-VIII secolo e.v.), fu lo sviluppo di sistemi di vocalizzazione per fissare la pronuncia del testo. Tra i vari sistemi (babilonese, palestinese), prevalse quello tiberiense, elaborato dalla famiglia Ben Asher, che divenne la base per i grandi codici medievali come il Codice di Leningrado (datato 1008), il più antico manoscritto completo della Bibbia ebraica che possediamo.
La storia materiale del testo rivela un paradosso fondamentale: la sua fluidità e pluralità hanno preceduto la sua fissità e sacralità. I ritrovamenti di Qumran, in particolare, hanno dimostrato che prima della standardizzazione masoretica coesistevano molteplici versioni testuali degli stessi libri. La traduzione greca della Settanta (LXX), iniziata nel III secolo a.e.v., è un’altra testimonianza cruciale di questa pluralità. Per libri come Geremia o Samuele, la LXX fu realizzata a partire da un testo ebraico (Vorlage) significativamente diverso e spesso più antico di quello che sarebbe poi diventato il Testo Masoretico. Il meticoloso lavoro dei masoreti non fu, quindi, la semplice conservazione di un testo originale unico, ma la creazione di un testo standard a partire da una tradizione molto più variegata. La concezione del testo biblico come sacro e immutabile è il punto di arrivo di questo processo, non il suo punto di partenza.
Contesto storico: La storia di Israele e Giuda
Römer dedica un capitolo assai importante alla ricostruzione della storia di Israele e Giuda, sottolineando che essa è il contesto indispensabile per comprendere la formazione della letteratura biblica. L’autore avverte che la narrazione biblica non può essere usata acriticamente come fonte storica, poiché è scritta da una prospettiva teologica e politica specifica, quella del regno meridionale di Giuda.
L’epoca dei due regni (dal X all’VIII secolo a.e.v.) vide il regno settentrionale di Israele come la principale potenza politica e culturale. Fu in questo contesto, in particolare sotto il prospero regno di Geroboamo II, che presero forma scritta le prime versioni delle tradizioni su Giacobbe (l’antenato eponimo di “Israele”) e sull’Esodo, narrazioni fondative per l’identità del Nord. La distruzione di Samaria da parte degli Assiri nel 722 a.e.v. fu un evento traumatico che portò alla migrazione di queste tradizioni verso il regno di Giuda, dove furono recepite e reinterpretate.
L’ascesa di Giuda tra la fine dell’VIII e il VII secolo a.e.v. coincise con un’intensa attività letteraria. Sotto il re Giosia (640-609 a.e.v.), in un periodo di debolezza dell’impero assiro, fu avviata una profonda riforma politico-religiosa. Questa riforma, mirata a centralizzare il culto nel tempio di Gerusalemme e a imporre la venerazione esclusiva di YHWH (monolatria), fu legittimata da una produzione letteraria specifica: la prima versione del Deuteronomio e un’opera storiografica (la cosiddetta “Storia Deuteronomistica”) che rileggeva la storia dei due regni per esaltare Giosia come un nuovo Davide.
La distruzione di Gerusalemme da parte dei Babilonesi nel 587 a.e.v. e il successivo esilio rappresentarono la crisi che funse da catalizzatore per la redazione di gran parte della Bibbia. Le élite deportate a Babilonia rielaborarono le tradizioni storiche e profetiche per dare un senso alla catastrofe, interpretandola come una punizione divina per l’infedeltà del popolo e dei suoi re. L’epoca persiana (a partire dal 539 a.e.v.) fu il periodo della ricostruzione del Tempio e della redazione di opere fondamentali come lo scritto sacerdotale (P), che confluì nel Pentateuco, e i libri di Esdra e Neemia.
Infine, il periodo ellenistico (dal 332 a.e.v.) e quello romano videro la nascita di nuove sfide culturali e politiche, che stimolarono la produzione di nuovi generi letterari, come la letteratura sapienziale critica (Qoèlet) e quella apocalittica (Daniele), quest’ultima in risposta alla crisi maccabaica (ca. 167 a.e.v.). La distruzione del Secondo Tempio nel 70 e.v. segnò la fine di un’era e accelerò il processo che portò il giudaismo farisaico a definire in modo stabile il proprio canone di Scritture.
L’analisi storica di Römer rivela una duplice e mutevole funzione della letteratura biblica. Inizialmente, essa fu uno strumento di state-building, una forma di propaganda politica al servizio della monarchia, come nel caso delle opere prodotte sotto Giosia per legittimare il suo programma. In seguito al collasso dello stato, questa stessa tradizione letteraria fu riadattata per diventare uno strumento di sopravvivenza culturale e di resistenza, costruendo un’identità per una comunità in esilio e in diaspora che poteva sussistere anche senza un’autonomia politica.
La formazione del Pentateuco: Dalla critica delle fonti ai modelli recenti
Il capitolo sulla formazione del Pentateuco è forse il più denso del volume, in quanto ripercorre quasi tre secoli di ricerca storico-critica, mostrando l’evoluzione dei modelli interpretativi e lo stato attuale del dibattito.
Römer parte dalla tesi tradizionale dell’autenticità mosaica, indiscussa fino all’Illuminismo, sebbene già minata da incongruenze interne come il racconto della morte di Mosè (Deut. 34). La prima vera messa in discussione sistematica venne da Spinoza, che nel 1670 propose di datare la compilazione finale del Pentateuco all’epoca di Esdra. La svolta metodologica avvenne con la scoperta della diacronia e delle fonti, inaugurata da Jean Astruc nel 1753, che ipotizzò l’uso di documenti distinti basandosi sull’alternanza dei nomi divini YHWH e ‘Elohim.
Questa intuizione portò allo sviluppo della “teoria documentaria classica”, la cui formulazione più influente fu quella di Julius Wellhausen alla fine del XIX secolo. Secondo questo modello, il Pentateuco (o meglio, l’Esateuco, includendo Giosuè) sarebbe il risultato della combinazione di quattro fonti principali, redatte in epoche diverse e riflettenti stadi differenti dell’evoluzione religiosa di Israele:
- Lo Yahwista (J) e l’Elohista (E), i documenti più antichi, risalenti all’epoca monarchica.
- Il Deuteronomio (D), legato alla riforma del re Giosia (ca. 622 a.e.v.).
- Lo scritto Sacerdotale (P), il più tardo, redatto durante o dopo l’esilio babilonese.
Questo modello, perfezionato da studiosi come Gerhard von Rad, che vedeva nello Yahwista un grande teologo della corte salomonica, ha dominato la ricerca per quasi un secolo. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 del Novecento, è stato oggetto di una critica radicale. Studi di autori come Van Seters, Schmid e Rendtorff hanno dimostrato l’insostenibilità di una datazione alta dello Yahwista, evidenziandone le forti affinità stilistiche e teologiche con la letteratura deuteronomistica e profetica dell’esilio.
Römer illustra come il crollo del consenso sulla teoria documentaria classica abbia aperto la strada a nuovi modelli, che, pur divergendo nei dettagli, condividono alcuni punti fermi:
- La centralità dell’epoca persiana: La formazione finale del Pentateuco è vista come un fenomeno del periodo post-esilico, non monarchico.
- L’esistenza di tradizioni pre-esiliche: Racconti sui patriarchi, sull’Esodo e antiche raccolte di leggi (come il Codice dell’Alleanza) esistevano in forma scritta o orale durante la monarchia, ma come unità indipendenti e non ancora integrate in una narrazione continua.
- Il ruolo delle grandi “composizioni”: Molti studiosi, seguendo l’impostazione di Erhard Blum, vedono il Pentateuco come il risultato della fusione di due grandi blocchi redazionali: una composizione di matrice deuteronomistica (D) e una di matrice sacerdotale (P).
Römer propone un modello plausibile che integra queste nuove prospettive. La storia delle origini sacerdotale (P) si estendeva originariamente da Genesi 1 a Levitico 16, formando un “Triateuco” incentrato sulla creazione del mondo e l’istituzione del culto. Il Deuteronomio, d’altra parte, era inizialmente legato ai libri storici successivi. Il libro dei Numeri sarebbe stato l’ultimo a essere composto, concepito come un “ponte” per collegare il blocco sacerdotale (Gen-Lev) con il Deuteronomio, creando così il Pentateuco nella sua forma attuale. In questo processo finale, furono integrati anche il romanzo di Giuseppe (Gen. 37-50), un racconto della diaspora egiziana, e si decise di concludere la Torah con la morte di Mosè, riflettendo l’identità di un popolo ormai disperso.
La formazione dei Profeti: Storiografia e oracoli
La seconda sezione del TaNaK, i Profeti (Nevi’im), è suddivisa in due parti con storie redazionali distinte ma interconnesse: i Profeti anteriori (i libri “storici”) e i Profeti posteriori (i libri profetici).
Per i Profeti anteriori (Giosuè, Giudici, Samuele, Re), Römer presenta la teoria della “storia deuteronomistica” come il principale strumento di analisi. Formulata da Martin Noth nel 1943, questa ipotesi sostiene che questi libri non siano opere separate, ma parte di un’unica grande opera storiografica, concepita da un autore (o una scuola) durante l’esilio babilonese per spiegare la catastrofe del 587 a.e.v. come conseguenza dell’infedeltà di Israele alla Legge del Deuteronomio, che funge da prologo e chiave interpretativa dell’intera narrazione. Römer illustra poi le principali revisioni di questa teoria: il modello di Frank M. Cross, che postula una prima edizione propagandistica dell’opera sotto il re Giosia, successivamente aggiornata in esilio; e il modello della scuola di Gottinga (Smend, Dietrich), che identifica molteplici strati redazionali successivi (storico, profetico, nomistico). L’autore propone una sintesi: una “biblioteca deuteronomistica” di scritti propagandistici iniziò a formarsi sotto Giosia, ma fu solo dopo la distruzione di Gerusalemme che questi rotoli furono radicalmente rivisti e unificati per creare una grande eziologia della catastrofe.
Per quanto riguarda i Profeti posteriori (Isaia, Geremia, Ezechiele e i Dodici), Römer evidenzia il passaggio della ricerca da un interesse per gli ipsissima verba (“le parole autentiche”) dei profeti storici a un’analisi dei complessi processi redazionali che hanno dato forma ai libri. La produzione di questi testi non è attribuibile a singoli profeti-scrittori, ma a circoli di scribi e sacerdoti che hanno raccolto, conservato, ampliato e riattualizzato oracoli preesistenti. Römer identifica due principali “scuole” redazionali:
- Un circolo deuteronomistico, responsabile della forma finale dei libri di Isaia e Geremia, come dimostrano i paralleli testuali con i libri dei Re (es. Is. 36-39 // II Re 18-20) e l’uso di uno stile e di una teologia affini.
- Un circolo sacerdotale, che ha plasmato il libro di Ezechiele, il cui linguaggio e le cui preoccupazioni cultuali sono molto vicini a quelli dello scritto sacerdotale (P) del Pentateuco.
La formazione di ogni libro è un processo a sé stante. Il libro di Isaia è il risultato della fusione di almeno tre blocchi principali (Proto-Isaia, capp. 1-39; Deutero-Isaia, capp. 40-55; Trito-Isaia, capp. 56-66), assemblati e rielaborati in un arco di tempo che va dall’VIII secolo a.e.v. fino all’epoca ellenistica. Il libro di Geremia esiste in due forme antiche, una più breve (attestata dalla Settanta) e una più lunga (il Testo Masoretico), testimoniando un lungo e complesso processo redazionale di matrice deuteronomistica. Il libro di Ezechiele, pur apparendo più omogeneo, è stato anch’esso rielaborato da una scuola sacerdotale che ha trasposto il ministero del profeta nel contesto della diaspora babilonese. Infine, il rotolo dei Dodici Profeti minori è stato assemblato unendo libri di epoche e origini diverse, con redattori che hanno creato legami tematici e verbali per dare coerenza all’intera raccolta.
La formazione degli “Scritti”: Una raccolta composita
L’ultima sezione del TaNaK, i Ketuvim (Scritti), è la più eterogenea, e il suo ordine non è mai stato fissato in modo definitivo. Römer ne analizza la formazione raggruppando i libri per genere letterario.
I Libri poetici includono i Salmi, il cui libro (il Salterio) è il risultato di un lungo processo di raccolta e redazione. Collezioni più antiche (come quelle “davidiche”) furono progressivamente assemblate e incorniciate da salmi che ne orientavano la lettura, prima in senso messianico, poi con un’enfasi sulla regalità di YHWH e infine, in modo definitivo, sulla centralità della Torah (Sal. 1 e 119). Le Lamentazioni sono cinque poemi acrostici sulla distruzione di Gerusalemme, opere erudite composte in epoca persiana. Il Cantico dei Cantici è una raccolta di poesie erotiche, probabilmente del III secolo a.e.v., la cui inclusione nel canone fu facilitata dall’attribuzione a Salomone e da successive letture allegoriche.
I Libri sapienziali riflettono l’evoluzione del pensiero sapienziale. I Proverbi raccolgono collezioni di massime di epoche diverse, alcune delle quali mostrano una chiara dipendenza dalla sapienza egizia (la Sapienza di Amenemope), e furono incorniciate in epoca ellenistica da un’introduzione che personifica la Sapienza (Prov. 1-9).
Giobbe e Qoèlet rappresentano la “crisi della sapienza”. Il primo contesta la dottrina tradizionale della retribuzione attraverso il dialogo tra Giobbe e i suoi amici, incorniciato da un racconto popolare. Il secondo, un testo filosofico del III secolo a.e.v., radicalizza questa critica, proclamando l’assurdità (hebel) dell’esistenza e l’impossibilità per l’uomo di comprendere l’opera divina.
I Libri storici di questa sezione offrono una prospettiva sulla storia post-esilica. Esdra e Neemia, originariamente un’opera unica, narrano la restaurazione della comunità giudaica sotto l’impero persiano, assemblando documenti di varia natura (memoriali, liste, lettere) in una compilazione finale di epoca ellenistica. I libri delle Cronache offrono una rilettura della storia monarchica già narrata in Samuele e Re, ma da una prospettiva sacerdotale e levitica, con un forte accento sul Tempio, il culto e una rigida teologia della retribuzione immediata.
Infine, le due novelle, Rut ed Ester, mettono in scena figure femminili eroiche. Rut, ambientato all’epoca dei Giudici ma scritto in epoca persiana, è una narrazione inclusiva che, presentando una donna moabita come antenata del re Davide, si oppone polemicamente all’ideologia esclusivista di Esdra e Neemia. Ester è un romanzo della diaspora, la cui versione ebraica non menziona mai Dio, e che legittima la festa di Purim; la sua forma finale riflette le tensioni del periodo maccabaico. Il libro di Daniele è l’unico testo pienamente apocalittico del canone ebraico. La sua prima parte (capp. 1-6) è una raccolta di racconti edificanti della diaspora, mentre la seconda (capp. 7-12) contiene visioni apocalittiche che riflettono la persecuzione di Antioco IV Epifane (167-164 a.e.v.), data in cui il libro ha raggiunto la sua forma definitiva.
Oltre il canone ebraico: I libri supplementari
In un’utile appendice, Römer presenta una sintesi dei libri supplementari che, pur non facendo parte del canone ebraico, sono inclusi negli Antichi Testamenti delle tradizioni cattolica e ortodossa. Questi testi, per lo più composti o conservati in greco, offrono una finestra sul giudaismo del Secondo Tempio.
Tra i libri presenti nel canone cattolico, Römer descrive Giuditta, un romanzo storico ambientato in epoca asmonea che esalta l’eroismo di una donna; Tobia, un racconto sapienziale ed edificante della diaspora; I e II Maccabei, che narrano la rivolta asmonea da prospettive diverse (il primo come cronaca filo-asmonea, il secondo come opera teologica incentrata sul martirio); la Sapienza di Salomone, un’opera in greco di ambiente alessandrino che dialoga con la filosofia ellenistica; il Siracide, un vasto compendio sapienziale che tenta una sintesi tra tradizione ebraica e cultura greca; e Baruc con la Lettera di Geremia, scritti pseudoepigrafi che continuano il messaggio del profeta Geremia.
Vengono poi menzionati alcuni dei testi che compaiono esclusivamente nelle Bibbie delle Chiese ortodosse, come la Preghiera di Manasse, il Libro dei Giubilei (una “piccola Genesi” con un forte interesse per il calendario), il Libro di Enoc (un’importante opera apocalittica), III e IV Esdra e III e IV Maccabei. Questa sezione finale sottolinea ulteriormente la fluidità dei confini del corpus scritturistico nel giudaismo antico e la pluralità di percorsi che hanno portato alla formazione dei diversi canoni biblici.
Conclusione: Valutazione dell’opera
In conclusione, Antico Testamento di Thomas Römer si rivela un’opera di notevole spessore scientifico e di grande utilità didattica. Pur presentandosi come un’introduzione “pocket”, il volume offre una sintesi densa, aggiornata e metodologicamente rigorosa dello stato attuale della ricerca storico-critica sulla Bibbia ebraica. La sua principale forza risiede nella capacità di guidare il lettore attraverso la complessità dei processi di formazione dei testi e del canone, smontando l’idea di un testo sacro monolitico e rivelandone invece la natura di prodotto storico, frutto di compromessi, riscritture e stratificazioni successive.
Il tono, costantemente sobrio e analitico, evita ogni deriva confessionale, trattando la Bibbia come un oggetto di studio storico-letterario. La chiarezza espositiva, unita a una struttura logica impeccabile, rende accessibili anche i dibattiti esegetici più complessi, come quelli sulla formazione del Pentateuco o sulla storia deuteronomistica. L’opera non si limita a presentare i contenuti dei libri biblici, ma insegna un metodo di lettura, fornendo al lettore gli strumenti critici per accostarsi a questi testi antichi in modo consapevole. Per queste ragioni, il volume di Römer si qualifica come uno strumento indispensabile non solo per studenti di teologia e scienze religiose, ma per chiunque desideri comprendere l’Antico Testamento nel suo contesto originario, al di là delle interpretazioni dogmatiche, come uno dei monumenti più complessi e affascinanti del patrimonio culturale dell’umanità.
Per chi volesse acquistare il volume: https://amzn.to/46UBFES

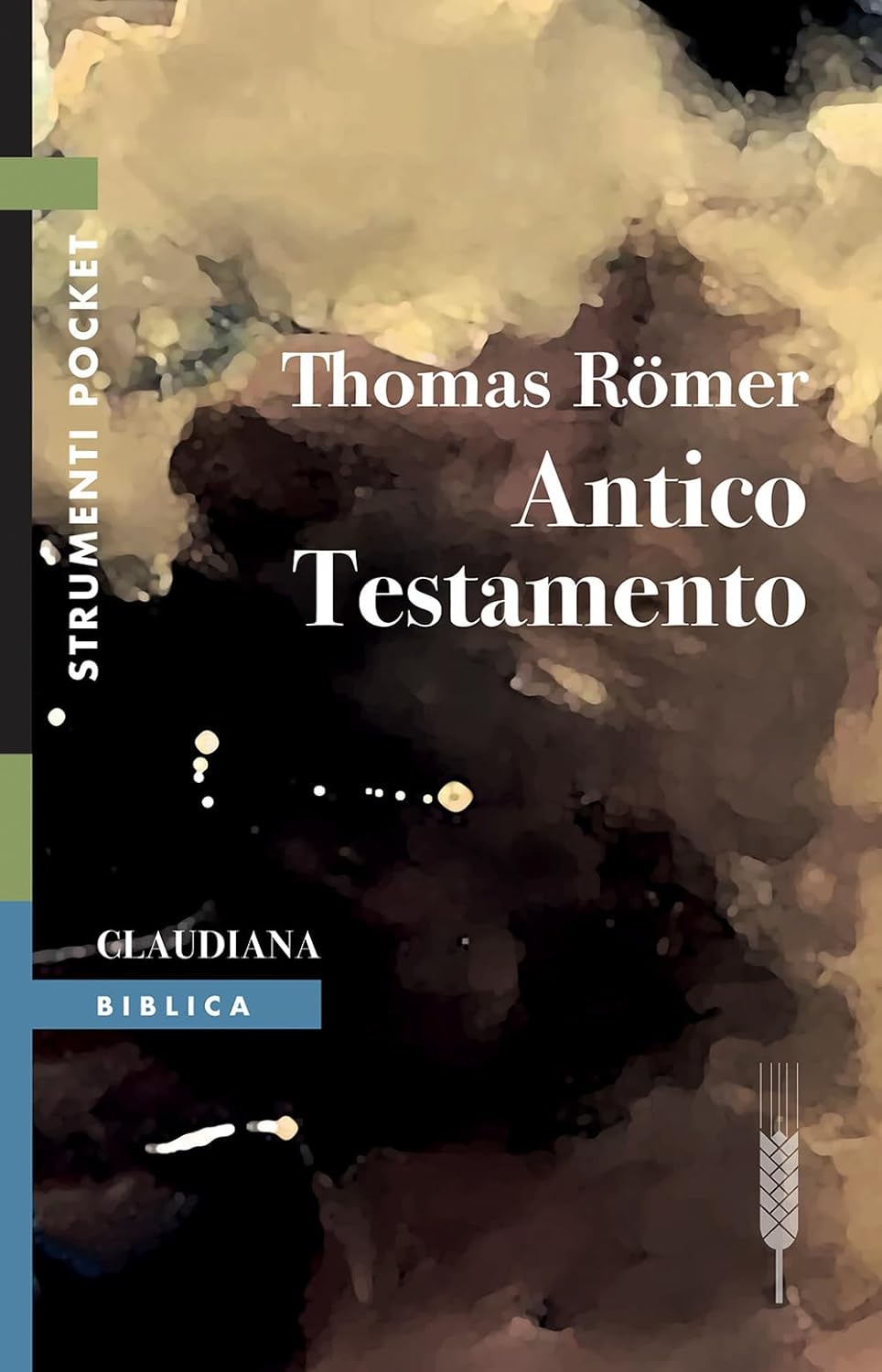
L’articolo è interessantissimo e ricco di spunti. Peccato che personalmente non amo le condensazioni in 160 pagine.