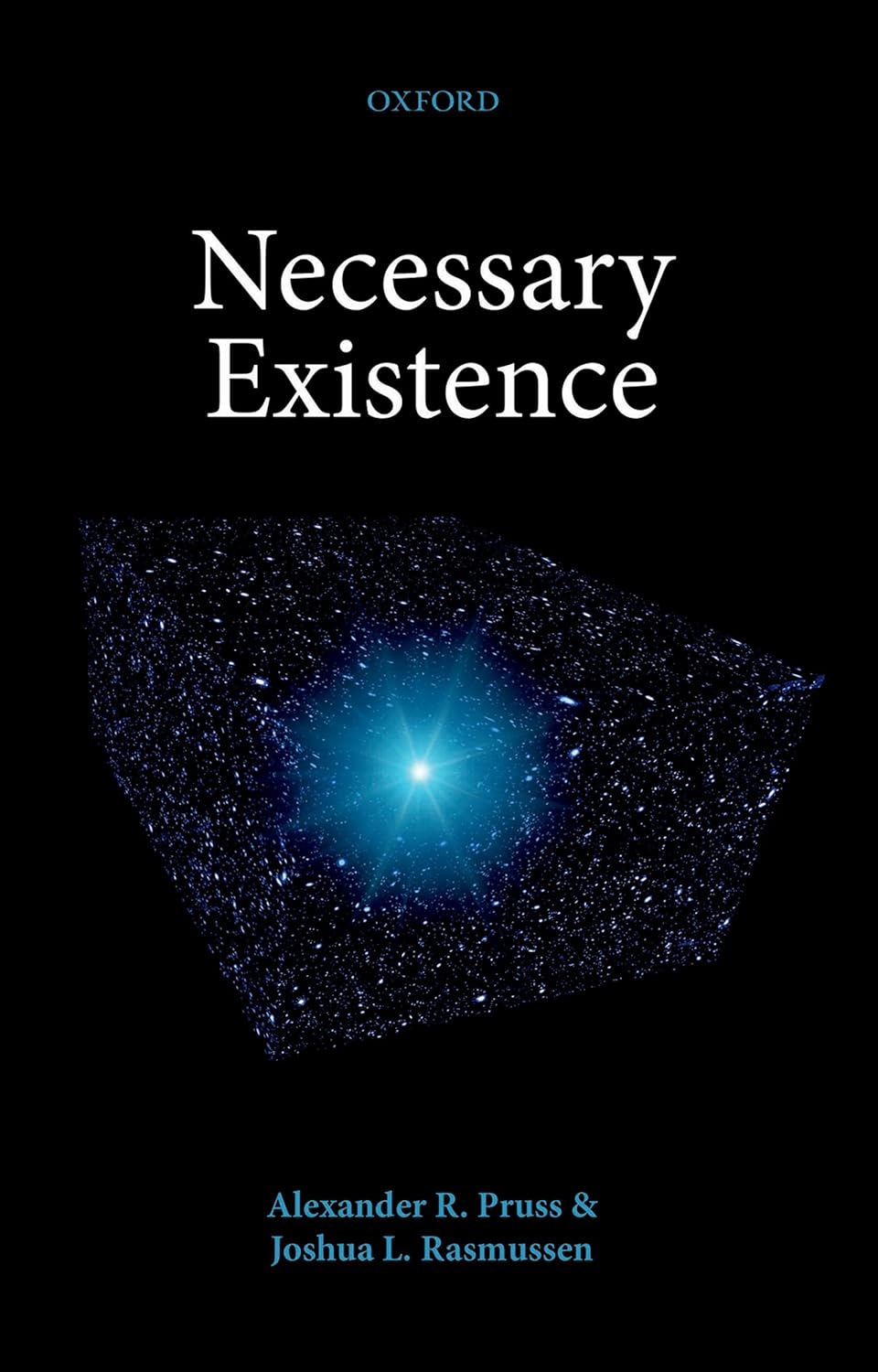Dati bibliografici: Alexander R. Pruss and Joshua L. Rasmussen, Necessary Existence, Oxford University Press, 2018, ISBN 978-0-19-874689-8.
[Avvertenza: il presente articolo potrebbe risultare piuttosto impegnativo per un lettore completamente digiuno di logica formale e di filosofia analitica.]
Introduzione: la rianimazione di una domanda fondamentale
Nel panorama della filosofia analitica contemporanea, poche domande sono tanto fondamentali e, allo stesso tempo, spesso relegate ai margini del dibattito quanto quella posta da Leibniz: “Perché esiste qualcosa anziché nulla?”. Il volume Necessary Existence di Alexander R. Pruss e Joshua L. Rasmussen non si limita a riesumare tale interrogativo, ma lo riarma con un arsenale di argomenti di una sottigliezza logica e una lucidità analitica che ne fanno un’opera di riferimento per la teologia naturale del XXI secolo. L’obiettivo dichiarato del libro è presentare un caso cumulativo, rigoroso e su più fronti a favore dell’esistenza di un “ente necessario”, definito in modo preciso e minimale come un’entità che (i) esiste in ogni mondo possibile e (ii) è “concreta”, ovvero capace di causazione.
L’approccio degli autori si distingue immediatamente per una mossa dialettica tanto originale quanto strategica. Anziché procedere con la consueta esposizione di argomenti rivolti a un pubblico scettico, il primo capitolo presenta i risultati di un sondaggio online, “Necessary Being”, progettato per sondare le intuizioni modali del pubblico, inclusi filosofi, accademici e non specialisti. I risultati sono sorprendenti: una stragrande maggioranza dei partecipanti, inclusi coloro che si dichiarano “non credenti” (93.1%) e “agnostici” nell’esistenza di un ente necessario, finisce per approvare, se prese singolarmente, premesse che congiuntamente e deduttivamente implicano la conclusione che un tale ente esiste.
Questa mossa non è un mero aneddoto sociologico, ma un ribaltamento dell’onere della prova che definisce il tono dell’intera opera. Pruss e Rasmussen sovvertono la dinamica dialettica tradizionale. Non tentano di imporre premesse controverse a un lettore scettico; al contrario, dimostrano che lo scettico stesso è già incline ad accettare determinate intuizioni fondamentali che, se combinate logicamente, portano alla conclusione teistica. La domanda, quindi, non è più “perché dovresti credere a queste premesse?”, ma diventa “date le tue stesse inclinazioni intuitive, come giustifichi il rifiuto della loro conseguenza logica?”. Il libro si posiziona così non come un’opera di proselitismo, ma come un’esplorazione delle tensioni interne alle intuizioni modali e metafisiche del pubblico analitico contemporaneo. L’obiettivo non è solo persuadere, ma dimostrare che il rifiuto della conclusione ha un costo significativo in termini di coerenza intuitiva, un costo che i capitoli successivi si impegneranno a calcolare con precisione.
Le fondamenta logiche: la centralità della modalità metafisica e del sistema S5
Il secondo capitolo, “Metaphysical Possibility and Necessity”, costituisce la chiave di volta dell’intero edificio argomentativo. Qui gli autori gettano le fondamenta logiche su cui si reggeranno tutti gli argomenti successivi, operando una distinzione fondamentale e difendendo un sistema di logica modale che si rivelerà di importanza strategica capitale.
La prima mossa è distinguere nettamente la “necessità metafisica ampia” (broadly logical necessity) dalla “necessità logica stretta” (narrowly logical necessity). Quest’ultima, legata alla provabilità all’interno di un sistema formale, viene dimostrata inadeguata attraverso una critica serrata che fa leva, in modo particolarmente efficace, sui teoremi di incompletezza di Gödel. Se la necessità fosse riducibile alla provabilità, argomentano, allora un sistema formale consistente non potrebbe provare la propria consistenza, portando alla conclusione controintuitiva che ogni proposizione è “L-possibilmente L-necessaria”, un risultato che svuota di significato la nozione stessa di necessità. La modalità metafisica, al contrario, è la forma più fondamentale di possibilità e necessità, quella che riguarda ciò che può o deve essere, indipendentemente dai limiti della nostra conoscenza o dei sistemi formali.
Una volta definito il campo di gioco, Pruss e Rasmussen procedono a difendere la tesi che la logica che governa la modalità metafisica è il sistema S5. Questo sistema è caratterizzato dall’assioma T (□p→p), dall’assioma S4 (□p→□□p) e dall’assioma di Brouwer (p→□◊p), che insieme implicano che la relazione di accessibilità tra mondi possibili è un’equivalenza (riflessiva, transitiva e simmetrica). La difesa di S5 è meticolosa. L’assioma S4 viene giustificato appellandosi all’invarianza della modalità metafisica: essendo una forma di possibilità “assoluta”, non condizionata dalle leggi di natura di un mondo specifico, le verità modali non dovrebbero variare da mondo a mondo. L’assioma S5, che codifica pienamente questa invarianza, viene ulteriormente sostenuto mostrando come il suo rifiuto porti a conseguenze implausibili, come un privilegio ingiustificato del mondo attuale o l’inclusione di mondi impossibili nella semantica modale. Vengono affrontate e respinte con perizia le obiezioni classiche, come l’argomento di Chisholm sulla non-transitività dell’identità transmondiale e le difficoltà poste dall’esistenzialismo riguardo alle proposizioni singolari.
La difesa di S5 non è un mero esercizio di logica formale; è la mossa strategica più potente del volume. Stabilendo la validità di questo sistema, gli autori operano una trasformazione radicale del campo di battaglia filosofico. La conseguenza più nota di S5 è l’equivalenza tra ◊□p e □p. Applicata all’esistenza di un essere necessario, ciò significa che se è possibile che esista un essere necessario (◊∃x□E!x), allora esiste un essere necessario (∃x□E!x). Questo è il nucleo dell’argomento ontologico modale di Plantinga. Pruss e Rasmussen, tuttavia, non lo presentano come il loro argomento principale, ma come il paradigma logico che informa la loro intera strategia. Grazie a S5, l’asticella epistemica si abbassa drasticamente. Non è più necessario difendere principi universali e attuali come “ogni evento contingente ha una causa”; è sufficiente dimostrare la loro mera possibilità metafisica. Questa transizione dalla fattualità alla possibilità rende i loro argomenti successivi straordinariamente resistenti alle obiezioni empiriche, come quelle derivanti dalla meccanica quantistica. Il dibattito viene spostato su un terreno più puramente metafisico e concettuale, dove gli strumenti dell’analisi logica e dell’intuizione modale, affinati dagli autori, possono essere impiegati con la massima efficacia.
Un arsenale di argomenti: i percorsi convergenti verso l’esistenza necessaria
Armati di questa potente impalcatura logica, Pruss e Rasmussen dedicano la parte centrale del libro alla costruzione di sei distinti argomenti, ciascuno dei quali rappresenta un percorso indipendente verso la medesima conclusione. La forza della loro posizione non risiede in un singolo argomento ritenuto inconfutabile, ma nella convergenza di molteplici linee di ragionamento che partono da presupposti diversi e affrontano il problema da angolazioni differenti.
Il classico rivisitato: l’argomento dalla contingenza (ACE)
Il Capitolo 3 presenta una versione aggiornata e rafforzata del classico argomento cosmologico dalla contingenza, battezzato “ACE” (Argument from Contingent Existence). L’argomento, nella sua essenza, afferma che (1) ogni pluralità di cose concrete contingenti ha una spiegazione per la sua esistenza e (2) se la pluralità di tutte le cose concrete contingenti ha una spiegazione, questa deve risiedere in un essere necessario. Una delle innovazioni più significative è l’uso della quantificazione plurale (“per ogni xs…”), che permette di parlare di collezioni di oggetti senza presupporre che esse formino un unico oggetto composito (come “l’universo”). Questa mossa elude elegantemente la classica obiezione di Hume basata sulla fallacia della composizione, che nega la legittimità di chiedere una causa per la “totalità” delle cose.
La difesa del principio esplicativo (premessa 1) è particolarmente robusta e sfaccettata, basandosi su quattro pilastri :
- Generalizzazione induttiva: La nostra esperienza quotidiana è pervasa da spiegazioni; generalizzare questo schema a tutti gli esistenti contingenti è un’inferenza ragionevole.
- Intuizione a priori: L’esistenza di qualcosa che avrebbe potuto non esistere (la sua contingenza) sembra intrinsecamente richiedere una spiegazione, indipendentemente dalle sue proprietà specifiche.
- L’argomento dal caos: Se le cose potessero apparire senza alcuna spiegazione, sarebbe incredibilmente improbabile che l’universo non sia un caos costante di oggetti che appaiono e scompaiono arbitrariamente. L’ordine che osserviamo è esso stesso un dato che richiede una spiegazione, e il principio esplicativo la fornisce.
- Evitare confini arbitrari: Negare il principio esplicativo implica tracciare una linea arbitraria tra ciò che richiede una spiegazione e ciò che non la richiede, senza un criterio metafisicamente rilevante per tale distinzione.
L’argomento dal caos, in particolare, rappresenta una potente riabilitazione del Principio di Ragione Sufficiente (PSR). Invece di postularlo come un assioma a priori, lo presenta come un’inferenza alla migliore spiegazione per una caratteristica fondamentale e osservabile del nostro universo: la sua relativa stabilità e ordine. Questo lo rende più appetibile per un filosofo con inclinazioni empiriche, trasformando un principio metafisico astratto in un’ipotesi quasi-scientifica.
L’innovazione modale: gli argomenti dalle cause possibili (MAB e WAB)
I Capitoli 4 e 5 introducono l’innovazione più interessante del libro: gli argomenti “basati sulla possibilità”. L’Argomento Modale dagli Inizi (MAB) e l’Argomento Debole dagli Inizi (WAB) sostituiscono i principi causali “forti” (che affermano che ogni contingente ha una causa) con principi “deboli” che affermano solo che certi tipi di “inizi” possono avere una causa.
Il MAB, per esempio, si basa sulla premessa che “per ogni stato di cose positivo s che può iniziare a esistere, è possibile che ci sia qualcosa di esterno a s che lo causi”. Il WAB restringe ulteriormente questo principio a certe classi di proprietà “naturali” per renderlo ancora più solido rispetto a potenziali controesempi. Combinando questi principi con la premessa, anch’essa modale, che un inizio dell’esistenza di tutte le cose concrete contingenti è possibile, e notando che una causa di tale inizio non potrebbe essere essa stessa contingente, si arriva alla possibilità di un ente necessario, e da lì, via S5, alla sua attualità.
Questi capitoli esemplificano una brillante strategia di “concessione strategica”. Gli autori concedono al critico il suo punto più forte: “Ammettiamo pure che possano esistere eventi contingenti incausati, come suggerito da alcune interpretazioni della meccanica quantistica”. Su questo terreno concesso, però, costruiscono un argomento ancora più potente, basato su una premessa che diventa eccezionalmente difficile da negare: “Ma sicuramente, è almeno possibile che un inizio abbia una causa?”. Negare questa premessa modale minima richiede una posizione molto più dogmatica e controintuitiva che non il semplice indicare possibili eccezioni a un principio universale.
Un nuovo strumento per la ragione: l’argomento dall’uniformità modale
Il Capitolo 6 introduce un altro strumento originale nell’arsenale degli autori: il principio di Uniformità Modale. Questo principio, presentato in versioni sia generali che ristrette (Mrestricted), afferma che differenze meramente quantitative tra due proposizioni non dovrebbero, di norma, alterare il loro status modale (cioè, se una è possibile, anche l’altra dovrebbe esserlo). Per esempio, se è possibile che esista una causa per l’inizio di tre cose concrete, sembra arbitrario negare che sia possibile una causa per l’inizio di una sola cosa concreta.
Questo principio non viene usato come un argomento a sé stante per un ente necessario, ma come uno strumento di epistemologia modale per giustificare e rafforzare le premesse modali degli argomenti precedenti, in particolare del MAB e del WAB. Questo capitolo eleva il progetto del libro a un livello meta-argomentativo. Non si limita a presentare argomenti, ma riflette sulla metodologia con cui si giustificano le premesse modali. Fornisce al lettore un “kit di strumenti” razionale, suggerendo che le intuizioni sulla possibilità non sono salti nel buio, ma possono essere guidate da principi generali di ragionevolezza, aumentando così la coerenza e la forza del caso complessivo.
Dall’astratto al concreto: l’argomento dal fondamento degli abstracta
Il Capitolo 7 si sposta su un terreno completamente diverso, costruendo un argomento che parte non dal mondo fisico, ma dal regno degli oggetti astratti (abstracta). L’argomento procede in tre passi fondamentali:
- Necessariamente, esistono oggetti astratti: Vengono addotti argomenti standard a favore dell’esistenza necessaria di entità come numeri, proposizioni e proprietà.
- Necessariamente, se esistono oggetti astratti, esistono oggetti concreti: Si sostiene che gli abstracta non possono esistere in un vuoto platonico, ma devono essere ontologicamente fondati su, o dipendenti da, entità concrete. Vengono esplorate le tradizioni concettualiste (gli astratti sono pensieri in una mente) e aristoteliche (gli astratti sono fondati nelle loro istanze o nei poteri causali di produrle).
- Possibilmente, non esistono oggetti concreti contingenti: Questa premessa, difesa tramite un “argomento della sottrazione”, suggerisce che si può concepire un mondo privo di qualsiasi entità concreta contingente.
La conclusione è ineluttabile: se gli astratti esistono necessariamente (1) e richiedono un fondamento concreto (2), ma è possibile che non esistano fondamenti concreti contingenti (3), allora deve esistere un fondamento concreto necessario. Questo argomento crea un potente dilemma per il naturalista ateo standard, che tipicamente è un realista riguardo alla matematica e alla logica (accettando la premessa 1) ma un fisicalista riguardo alla metafisica (negando la conclusione). L’argomento lo forza a una scelta difficile: o abbandonare il realismo sugli astratti, una posizione con costi esplicativi enormi, o riconsiderare la possibilità di un fondamento concreto non-contingente per gli stessi.
La logica delle perfezioni: l’argomento di ispirazione gödeliana
L’ultimo argomento principale, nel Capitolo 8, è una versione semplificata e mirata dell’argomento ontologico di Gödel. La sua forza risiede nell’eleganza e nell’astrazione. Non parte da osservazioni sul mondo fisico, ma da un sistema assiomatico su ciò che costituisce una “proprietà positiva” (o perfezione). Gli assiomi formali sono due: (1) se una proprietà A è positiva, la sua negazione ~A non lo è; (2) se A è positiva e implica B, anche B è positiva. A questi si aggiungono solo due premesse sostanziali, ma altamente intuitive: (3) “esistere necessariamente” è una proprietà positiva, e (4) “essere capace di causare qualcosa” è una proprietà positiva.
Da questi pochi assiomi, con un breve passaggio logico, si dimostra che la congiunzione delle due proprietà positive (“esistere necessariamente” e “essere capace di causare”) deve essere possibile. Da qui, ancora una volta, S5 garantisce l’attualità di un ente che possiede entrambe le proprietà, ovvero un ente necessario e concreto. Questo argomento mostra l’ampiezza dell’arsenale degli autori: sono in grado di costruire un caso partendo da fatti generali sul mondo (contingenza, causalità) così come da principi puramente formali sulla logica del valore e della perfezione.
La difesa proattiva: demolire le obiezioni all’ente necessario
Il nono e ultimo capitolo è dedicato a una difesa proattiva della tesi, affrontando e smantellando sistematicamente le sei principali obiezioni all’esistenza di un ente necessario. Vengono analizzati l’argomento dalla concepibilità di Hume, il problema semantico di Swinburne, l’argomento logico di Findlay, l’argomento della sottrazione, i problemi legati alla causalità e l’obiezione del “costo ontologico”.
La strategia di replica più potente e ricorrente è quella degli “argomenti di parità” (parity arguments). Pruss e Rasmussen dimostrano con acume che i principi stessi su cui si fondano molte obiezioni possono essere utilizzati per costruire argomenti altrettanto, se non più, plausibili a favore della loro tesi. Per esempio, all’argomento dalla concepibilità (è concepibile un mondo senza cose concrete, quindi è possibile), contrappongono la concepibilità di un mondo in cui ogni cosa contingente ha una spiegazione, una possibilità che, come mostrato in ACE, implica l’esistenza di un ente necessario. Allo stesso modo, all’argomento della sottrazione (si possono sottrarre cose fino a zero), contrappongono un argomento di “sottrazione esplicativa” (se si può spiegare l’esistenza di N cose, si può spiegare l’esistenza di N-1 cose, fino a una spiegazione per l’esistenza di almeno una cosa, che deve essere necessaria).
L’effetto di questa strategia è devastante per l’obiezione. Non si limita a negare la premessa dell’avversario, ma neutralizza la sua intera linea di ragionamento, mostrando che essa porta a conclusioni opposte con la stessa forza, risultando in uno stallo dialettico che priva l’obiezione originale di ogni potere persuasivo.
Questo approccio ha un’implicazione profonda sulla natura dello scetticismo. La posizione scettica sull’esistenza di un ente necessario è spesso presentata come la posizione di default, modesta e non dogmatica. Il Capitolo 9, attraverso gli argomenti di parità, rivela che questa presunta modestia è un’illusione. Per mantenere lo scetticismo, si devono ora negare principi altamente intuitivi (come la possibilità di una spiegazione universale) o ammettere che le proprie intuizioni modali (sulla sottrazione o la concepibilità) non sono più sicure di quelle opposte. Lo scetticismo cessa di essere una posizione “neutra” o di default e si trasforma in una tesi metafisica sostanziale e “costosa”, che richiede la difesa di un insieme specifico e controverso di posizioni filosoficamente impegnative. Il libro riesce così a ribaltare la presunzione dialettica: non è più il teista a dover giustificare la sua “aggiunta costosa” all’ontologia, ma lo scettico a dover giustificare il suo rifiuto delle conseguenze delle sue stesse intuizioni.
Conclusione: il ruolo di Necessary Existence nel dibattito analitico contemporaneo
Necessary Existence è un’opera di straordinaria importanza per la filosofia analitica contemporanea. La sua forza non risiede in una singola prova che si pretende inconfutabile, ma nella costruzione di un caso cumulativo formidabile, che attacca il problema dell’esistenza fondamentale da una molteplicità di angolazioni convergenti: dalla logica modale all’epistemologia, dalla metafisica della causalità all’assiologia.
Il contributo più significativo del libro è forse quello di aver aumentato in modo esponenziale il “costo filosofico” del naturalismo ateo. Per rifiutare la conclusione di Pruss e Rasmussen, un critico non deve più confrontarsi con una singola formulazione dell’argomento cosmologico, spesso vulnerabile a obiezioni standard. Deve ora smantellare un’intera falange di argomenti, ciascuno con le proprie fondamenta e difese, e deve inoltre proteggere le proprie obiezioni dalla potente strategia degli argomenti di parità. Il rifiuto dell’esistenza necessaria non è più un’opzione “economica” o di default; è una posizione che richiede presupposti metafisici ed epistemologici sostanziali e spesso controintuitivi.
In definitiva, Necessary Existence si afferma come un’opera di riferimento, un esempio paradigmatico di come gli strumenti più affilati della filosofia analitica possano essere impiegati per rivitalizzare e portare a un nuovo livello di sottigliezza argomentativa le più antiche e profonde questioni metafisiche. Non è semplicemente un libro “interessante”; è un’opera che definisce un’agenda, che sfida i paradigmi esistenti e che ogni filosofo interessato alle questioni ultime della realtà dovrà, d’ora in poi, prendere in serissima considerazione.