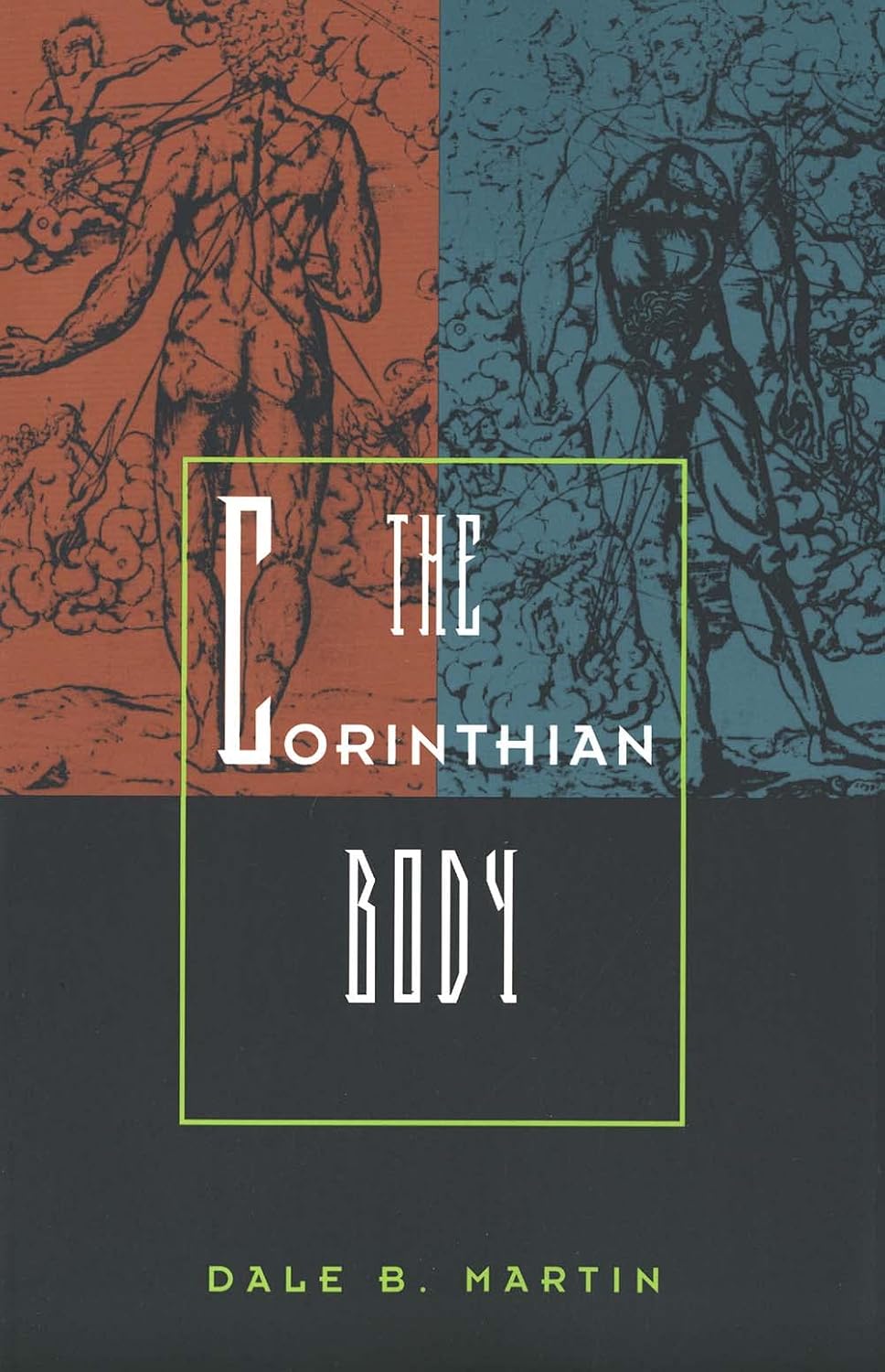Introduzione: svelare il corpo corinzio
Nel panorama degli studi paolini, poche opere hanno avuto l’impatto trasformativo di The Corinthian Body di Dale B. Martin. Pubblicato nel 1995, questo volume rappresenta una pietra miliare, un’indagine che ha ridefinito radicalmente il quadro interpretativo della Prima Lettera ai Corinzi. Con un’erudizione che attinge con pari maestria all’esegesi neotestamentaria, ai testi medici e filosofici greco-romani, alla teoria sociale e alla critica ideologica, Martin svela la logica nascosta dietro i conflitti che animavano la chiesa di Corinto (p. xii). L’autore riesce in un’impresa tanto audace quanto illuminante: decodificare le dispute corinzie attraverso la lente centrale e unificante del corpo umano (p. xi).
La tesi centrale del libro, esposta con vigore e sostenuta da un’analisi meticolosa, è che i vari disaccordi teologici, etici e sociali tra Paolo e le diverse fazioni della comunità non erano questioni disparate, ma manifestazioni superficiali di un conflitto più fondamentale: uno scontro tra costruzioni ideologiche concorrenti del corpo (p. xv). Martin identifica due modelli corporei principali in competizione. Da un lato, il corpo gerarchico dei “Forti”, i membri più istruiti e di status socioeconomico elevato, che vedevano il corpo come un microcosmo splendidamente equilibrato dell’universo. Dall’altro, il corpo permeabile e vulnerabile alla contaminazione, una visione condivisa da Paolo e dai “Deboli”, i membri di status inferiore della comunità (p. xv).
Questa recensione seguirà la struttura bipartita del libro di Martin, esplorando prima le implicazioni della gerarchia e poi quelle dell’inquinamento, per dimostrare come questa chiave di lettura offra una spiegazione piuttosto interessante per le molteplici tensioni che affiorano dalla Prima Lettera ai Corinzi.
Parte I: Gerarchia
La prima metà del libro di Martin è dedicata a smontare e ricostruire il concetto di gerarchia, mostrando come l’ordine sociale e cosmico fosse inscritto direttamente sulla superficie e all’interno del corpo antico.
Il corpo antico: un microcosmo gerarchico
Martin inizia con una brillante decostruzione delle nostre categorie moderne, dimostrando come dualismi cartesiani quali fisico/spirituale o naturale/soprannaturale siano del tutto anacronistici se applicati al mondo antico (p. 3-6). Al loro posto, egli delinea un “modello a un solo mondo”, un universo concepito come un continuum di sostanze disposte secondo una gerarchia di essenze, dal più denso e terreno (terra, acqua) al più sottile e celeste (aria, fuoco, etere) (pp. 15, 127-128).
In questo quadro, il corpo umano non era come un microcosmo, era un microcosmo, composto degli stessi elementi del cosmo e soggetto alle stesse dinamiche (p. 16). I confini tra interno ed esterno erano fluidi e permeabili, attraversati da canali (poroi) che permettevano il flusso di sostanze e influenze (pp. 17-18). Questo corpo era anche intrinsecamente gerarchico: la testa (sede della ragione) governava le parti inferiori, il maschile (caldo, secco, attivo) dominava sul femminile (freddo, umido, passivo), e l’aspetto esteriore (fisiognomica) era un indicatore infallibile del carattere interiore e dello status sociale (p. 18, 30-34). Infine, questo corpo era malleabile, da modellare e formare fin dalla nascita per conformarsi agli ideali estetici e sociali della classe dominante (pp. 25-29).
La retorica del corpo politico e l’economia del corpo
Armato di questa comprensione del corpo antico, Martin analizza le strategie retoriche di Paolo. Dimostra che l’apostolo, lungi dall’essere un laico della parola, era un abile retore che conosceva e utilizzava le convenzioni del suo tempo, in particolare la retorica della homonoia (concordia) (pp. 38-39). Tradizionalmente, la metafora del “corpo politico” era usata in modo conservatore per rafforzare le gerarchie sociali esistenti, esortando le classi inferiori (“i piedi”) a sottomettersi a quelle superiori (“la testa”) per il bene comune (pp. 39, 93).
Paolo, tuttavia, sovverte radicalmente questo topos. In 1 Corinzi 1-4, egli non nega la gerarchia, ma la inverte. Introduce un dualismo apocalittico tra “questo mondo” e il regno di Dio, ognuno con il proprio sistema di valori. La “sapienza” del mondo è stoltezza per Dio, e la “stoltezza” della croce è la vera sapienza e potenza di Dio (1 Corinzi 1,18-25) (pp. 58-60). In questo modo, Paolo sfida l’ideologia dei “Forti”, che basavano il loro status sulla sapienza retorica e filosofica, e offre un modello alternativo in cui i “deboli” e i “disprezzati” sono scelti da Dio per confondere i forti (1 Corinzi 1,27-28) (p. 61).
Questa inversione di status è la chiave per comprendere i conflitti specifici. Le divisioni durante la Cena del Signore (1 Corinzi 11,17-34) non erano semplici mancanze di pietà, ma manifestazioni di stratificazione sociale, con i ricchi “Forti” che umiliavano i poveri “Deboli” (p. 74). I litigi portati davanti ai tribunali pagani (1 Corinzi 6,1-11) erano un tentativo dei membri di status superiore di usare il loro vantaggio sociale contro i fratelli più deboli (pp. 75-77). Il dibattito sul cibo immolato agli idoli (1 Corinzi 8-10) vedeva i “Forti”, sicuri della loro gnosis (conoscenza), rivendicare la libertà di mangiare, incuranti della “coscienza debole” dei fratelli di status inferiore (pp. 70-71). In ogni caso, Paolo si schiera con i “Deboli”, esortando i “Forti” a rinunciare ai loro diritti e a imitare il suo stesso esempio di abbassamento volontario, come il suo rifiuto del sostegno finanziario per lavorare come artigiano (1 Corinzi 9) (p. 83).
Lingue degli angeli e il corpo risorto
Anche la disputa sulla glossolalia (parlare in lingue) in 1 Corinzi 12-14 viene letta da Martin come un conflitto di status. Il parlare in lingue, probabilmente una forma di discorso esoterico e angelico, era considerato un’attività di alto status, praticata e valorizzata dai “Forti” (pp. 87-88). Paolo affronta il problema non negando il valore del dono, ma ricontestualizzandolo all’interno del corpo di Cristo. Ancora una volta, usa l’analogia del corpo (1 Corinzi 12,12-27) per invertire la gerarchia: le membra “apparentemente più deboli” sono in realtà “più necessarie” e devono ricevere “più onore” (12,22-24) (pp. 94-95). Inoltre, analizzando la dicotomia nous/pneuma (mente/spirito) in 1 Corinzi 14, Martin mostra come Paolo sovverta la gerarchia platonica, che privilegiava lo pneuma ispirato, insistendo che il “superiore” pneuma si sottometta al “comune” nous per l’edificazione di tutta la comunità (pp. 97-102).
Il culmine della Parte I è l’analisi della risurrezione in 1 Corinzi 15. I “Forti”, influenzati dalla filosofia popolare, rifiutavano l’idea della risurrezione del nekros (cadavere) come filosoficamente rozza e assurda (p. 107-108). La risposta di Paolo è un capolavoro di accomodamento e sovversione. Qui, la sua osservazione è acuta, poiché l’argomentazione di Paolo è più sottile di una semplice opposizione tra un “corpo carnale” e uno spirituale. Egli fa una concessione strategica ai suoi avversari concordando che “carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio” (15,50), riconoscendo così che le componenti corruttibili del corpo attuale sono inadatte all’immortalità (p. 126). Tuttavia, usa questo accordo per ridefinire radicalmente la natura stessa del sōma (corpo) risorto. La distinzione fondamentale che introduce non è tra un corpo carnale e uno spirituale, ma tra il sōma psychikon (il corpo attuale, animato dalla forza vitale di status inferiore, la psychē, e composto da elementi corruttibili come carne e sangue) e il sōma pneumatikon (il corpo risorto, animato e costituito da pneuma, la materia-spirito celeste) (pp. 126-127). Attingendo alla cosmologia della “gerarchia delle essenze”, Paolo colloca il corpo di risurrezione al vertice della scala, come un corpo celeste, glorioso e incorruttibile, composto della sostanza più nobile (pp. 127-128). Infine, inserisce questa trasformazione fisiologica nel suo mito cosmico apocalittico, dove la risurrezione segna la vittoria finale di Cristo su tutte le potenze nemiche, inclusa la Morte (15,20-28) (pp. 133-134).
Parte II: Inquinamento
Nella seconda parte del libro, Martin introduce un’altra lente interpretativa cruciale: la preoccupazione per l’inquinamento e la permeabilità dei confini corporei.
Eziologie della malattia: squilibrio contro invasione
Martin delinea due principali eziologie della malattia nel mondo antico, che corrispondono alle due ideologie del corpo (p. 143).
- Eziologia dello squilibrio: Sostenuta dai medici e dalle classi colte, questa visione attribuiva la malattia a uno squilibrio interno degli umori corporei. Il corpo era visto come un sistema relativamente chiuso e sicuro, e la preoccupazione principale era mantenere l’ordine e l’equilibrio interni, non respingere agenti esterni. Questa visione riflette la sicurezza sociale dell’élite (pp. 144-153).
- Eziologia dell’invasione: Più comune tra le classi inferiori e nel pensiero popolare, questa visione concepiva il corpo come un’entità permeabile, costantemente minacciata dall’invasione di agenti esterni ostili (demoni, spiriti, miasmi) che violavano i suoi fragili confini. Questa visione riflette la precarietà sociale dei non-élite (pp. 144, 153-157).
Martin sostiene che Paolo e i “Deboli” condividevano l’eziologia dell’invasione, mentre i “Forti” aderivano a quella dello squilibrio. Questa differenza fondamentale spiega le loro diverse posizioni su questioni di purezza e contaminazione (pp. 161-162).
Sesso, cibo e i pericoli del desiderio
Questa “linea di faglia” ideologica diventa evidente nelle dispute su sesso e cibo. Nel caso dell’uomo incestuoso (1 Corinzi 5), la preoccupazione di Paolo non è solo morale, ma è una paura della contaminazione. L’uomo è come “lievito” che minaccia di corrompere l’intero corpo di Cristo; deve essere espulso per purificare la comunità (pp. 169-171). Allo stesso modo, l’unione con una prostituta (1 Corinzi 6) non è solo un peccato individuale, ma un atto che unisce un membro di Cristo al cosmo corrotto, creando un canale di inquinamento che minaccia l’integrità del corpo sociale (p. 176-178).
Anche la sua posizione sul cibo immolato agli idoli (1 Corinzi 8-10) è dettata da questa logica. Mentre i “Forti” vedono la questione in termini di conoscenza e libertà, Paolo la vede in termini di pericolo. Per i “Deboli”, che non possiedono la gnosis come profilassi, mangiare quel cibo significa entrare in comunione (koinonia) con i demoni, un atto di contaminazione (pp. 181-182). Persino la Cena del Signore (1 Corinzi 11) può diventare un agente di malattia. Se consumata in uno stato di divisione, il corpo di Cristo diventa un pharmakon (un farmaco che può essere anche veleno), che invade i corpi dei partecipanti causando malattia e morte (pp. 190-191, 194-195).
Infine, Martin analizza la discussione su matrimonio e celibato (1 Corinzi 7) attraverso la lente del desiderio. Per Paolo, il problema non è tanto l’atto sessuale in sé, quanto il “bruciare” del desiderio, visto come un fuoco interno, una malattia che minaccia di corrompere il corpo dall’interno. Il matrimonio, quindi, non è un luogo per l’espressione del desiderio, ma una profilassi contro di esso (pp. 208-213). Questa visione, radicata in un’eziologia dell’invasione (il desiderio come agente patogeno interno), si scontra con quella dei “Forti”, che avrebbero visto il desiderio come una forza naturale da controllare e bilanciare, non da estinguere (pp. 205-206).
I veli e la vulnerabilità femminile
L’analisi culmina nel capitolo sui veli delle donne (1 Corinzi 11,2-16). Martin rifiuta le interpretazioni moderne che vedono qui una lotta per l’uguaglianza. Al contrario, egli mostra come la richiesta di Paolo sia radicata in una fisiologia antica che considerava le donne intrinsecamente più deboli, porose e vulnerabili degli uomini (pp. 231-232). La profezia era vista come un atto di “penetrazione” divina, un momento in cui i confini del corpo si aprivano, rendendo il profeta particolarmente vulnerabile. Per le donne, questa vulnerabilità era amplificata dalla loro stessa natura “aperta” (pp. 239-241).
Il velo, quindi, non è un semplice simbolo di sottomissione, ma un dispositivo profilattico (p. 229). Protegge la donna (e, per estensione, la comunità) dall’invasione di forze esterne durante il pericoloso atto della profezia. La minaccia specifica, secondo Paolo, viene “a causa degli angeli” (11,10), che potevano essere sessualmente eccitati o offesi dalla violazione dell’ordine cosmico rappresentata da una donna scoperta. Il velo, quindi, funziona per mantenere la gerarchia di genere e per sigillare i confini del corpo contro l’inquinamento spirituale e sessuale (p. 245).
Questo però può essere considerato uno degli elementi più deboli dell’impianto del volume, che in qualche modo si riverbera pesantemente anche su parte di quanto sostenuto in precedenza nel testo. La critica principale che è possibile qui fare è che Martin impone al testo paolino una griglia interpretativa – quella della medicina greco-romana – che Paolo stesso non menziona mai. L’Apostolo basa infatti il suo ragionamento su argomenti teologici e sociali: l’ordine della Creazione, il concetto di “capo” (kephalē), la relazione tra immagine e gloria di Dio, e le consuetudini delle chiese. La spiegazione di Martin, pur storicamente informata, appare quindi importata dall’esterno piuttosto che derivata dall’argomentazione interna al passo.
Inoltre, la sua interpretazione degli “angeli” come esseri sessualmente aggressivi è considerata altamente speculativa. Molti studiosi oggi preferiscono vedere in essi i guardiani dell’ordine cosmico e liturgico, la cui presenza durante il culto esige un comportamento decoroso, o semplicemente i testimoni celesti dell’assemblea.
Infine, la tesi di Martin rischia di essere riduzionista, poiché sottovaluta la centralità delle dinamiche sociali di onore e vergogna, fondamentali nel mondo mediterraneo. Per molti esegeti, la preoccupazione principale di Paolo non era la porosità del corpo femminile, ma il disonore che una donna, apparendo in pubblico senza il simbolo del suo status matrimoniale, avrebbe arrecato a sé stessa, a suo marito e, in definitiva, alla reputazione dell’intera comunità cristiana. L’approccio più recente preferisce una lettura multifattoriale, che integra la teologia di Paolo con il contesto socio-culturale di Corinto. Sebbene l’analisi di Martin rimanga un contributo brillante per la sua capacità di immergerci nella mentalità antica, la sua spiegazione del velo è oggi vista come un’ipotesi affascinante ma non del tutto convincente, superata da letture più radicate nella logica interna del testo e nel suo contesto sociale.
Conclusione: una nuova anatomia del pensiero paolino
In conclusione, The Corinthian Body di Dale B. Martin è un’opera di grande erudizione e acume interpretativo. Il suo più grande merito è quello di fornire una chiave di lettura unificante e coerente per la Prima Lettera ai Corinzi, dimostrando come le dispute apparentemente disparate su retorica, cibo, sesso, doni spirituali e risurrezione siano tutte manifestazioni di un conflitto fondamentale sulla costruzione del corpo (p. xv).
Martin va lodato per il suo rigore metodologico, la sua profonda conoscenza delle fonti primarie (filosofiche, mediche e letterarie) e la sua capacità di integrare approcci critici moderni senza cadere nell’anacronismo (p. xii-xiii). Dopo aver letto questo libro, è impossibile tornare a leggere Paolo allo stesso modo. Al netto dei limiti evidenziati, si è costretti a riconoscere che per l’apostolo e le sue comunità, la teologia non era mai un’astrazione, ma era sempre, e profondamente, incarnata. Con The Corinthian Body, Dale B. Martin ci ha fornito una nuova e indispensabile anatomia del pensiero paolino, svelando le tensioni, le strategie e la genialità di un apostolo che lottava per un nuovo tipo di corpo – sia individuale che sociale – nel mezzo del complesso e conflittuale mondo greco-romano.