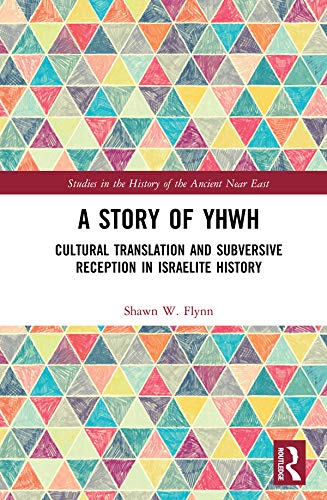Tracciare una narrazione delle trasformazioni di YHWH
Nel panorama degli studi biblici e storico-religiosi, l’indagine sulle origini e l’evoluzione della divinità israelitica, YHWH, rappresenta un campo di ricerca perennemente fertile e dibattuto. In questo contesto si inserisce il volume di Shawn W. Flynn, A Story of YHWH: Cultural Translation and Subversive Reception in Israelite History (Routledge, 2020), un’opera che si propone di tracciare una narrazione diacronica dello yahwismo dall’Età del Ferro fino al periodo persiano. L’autore, professore associato di Bibbia Ebraica presso il St. Joseph’s College dell’Università di Alberta, si colloca nel solco di studi fondamentali come Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan di John Day e L’invenzione di Dio di Thomas Römer, ma ambisce a offrire una prospettiva metodologica distintiva.
La tesi centrale del volume si discosta programmaticamente dagli approcci comparativi tradizionali. Flynn non si limita a domandare cosa fosse YHWH o chi fosse per gli antichi Israeliti, ma sposta l’asse della ricerca sul perché delle sue trasformazioni. La domanda guida che anima l’intera opera è: “Perché le espressioni dello yahwismo si sono spostate e hanno progredito in certe direzioni?” Questa impostazione privilegia l’analisi delle “espressioni guidate dal contesto” (context-driven expressions), esaminando come momenti storici specifici, caratterizzati da pressioni politiche, militari e culturali, abbiano agito da catalizzatori per il cambiamento teologico. L’obiettivo non è descrivere una figura divina statica, ma raccontare la storia di come una concezione del divino sia stata costantemente negoziata, rimodellata e riarticolata da una comunità per rispondere alle sfide del proprio tempo.
Per condurre questa indagine, Flynn introduce due strumenti metodologici principali, che costituiscono il contributo più originale e strutturante del suo lavoro. Questi vengono presentati come “lenti di lettura” per filtrare e interpretare i dati testuali ed extratestuali.
Il primo strumento è la traduzione culturale (cultural translation). Flynn attinge questo concetto non tanto dall’uso che ne è stato fatto negli studi biblici (ad esempio, la “translatability” delle divinità in Mark Smith), quanto piuttosto dalla sua origine nell’antropologia sociale, in particolare attraverso le opere di Talal Asad e Amitav Ghosh. In questa accezione, la traduzione culturale descrive il processo attraverso cui una cultura, spesso in posizione subalterna, assimila e reinterpreta concetti, motivi e pratiche da una cultura vicina o egemonica. Questo processo è spesso organico, non necessariamente intenzionale, e scaturisce dal contatto prolungato e dalla necessità di dare un senso a realtà esterne. Flynn sottolinea che la traduzione culturale è frequentemente attivata da pressioni esterne, siano esse politiche, militari o religiose. Per analizzarne le dinamiche, egli propone di esaminare la “coerenza” (somiglianze e differenze con la fonte), la “risonanza” (perché un certo motivo ha avuto successo nella cultura ricevente) e le “motivazioni” che hanno spinto all’adozione e all’adattamento di un determinato elemento culturale.
Il secondo strumento è la ricezione sovversiva (subversive reception). Questo concetto, mutuato principalmente dal lavoro di Eckart Otto sui legami tra il Deuteronomio e i trattati di vassallaggio neo-assiri, descrive un processo più consapevole. Non si tratta di una semplice assimilazione, ma di un’appropriazione strategica. La cultura subalterna adotta deliberatamente le forme, l’ideologia e il linguaggio della potenza dominante, ma li svuota del loro significato originale e li riassegna al proprio dio e alla propria visione del mondo. È un atto di resistenza teologica che mira a delegittimare l’ideologia imperiale utilizzando le sue stesse armi retoriche. Come afferma Otto, citato da Flynn, questo non è un segno di debolezza, ma di “autocoscienza e forza religiosa” che contesta le pretese del potere egemonico e rafforza l’identità del gruppo subalterno.
L’impiego di questi due modelli non è meramente strumentale, ma sottende una tesi più profonda sull’evoluzione della coscienza identitaria di Israele. La “traduzione culturale” sembra caratterizzare le fasi più arcaiche, in cui lo yahwismo è ancora profondamente immerso in una matrice culturale semitica condivisa, e le somiglianze con le divinità circostanti sono il risultato di un’osmosi naturale. La “ricezione sovversiva”, invece, diventa la modalità prevalente in epoche successive, in particolare a partire dal confronto con gli imperi, quando emerge una più forte necessità di auto-definizione e di distinzione identitaria in opposizione a un “altro” politico e culturale. La storia delle trasfomazioni di YHWH diventa, così, anche la storia delle strategie di sopravvivenza intellettuale e culturale di Israele, in cui la teologia si configura come un campo di battaglia simbolico per la negoziazione di potere, identità e resistenza.
Le origini contese: YHWH come divinità liminale e “outsider”
Il secondo capitolo del volume, “Competing narratives of early origins”, affronta la complessa questione delle prime fasi dello yahwismo. Flynn non si prefigge di risolvere in modo definitivo il dibattito sull’origine geografica di YHWH, ma utilizza l’analisi delle diverse ipotesi per distillare un profilo comune e coerente della divinità nel suo stadio formativo.
L’indagine prende le mosse dalle origini meridionali, un’ipotesi supportata da diverse linee di evidenza. In primo luogo, vengono considerate le fonti extra-bibliche, in particolare le liste topografiche egizie del Nuovo Regno che menzionano i nomadi Shasu in associazione a un toponimo foneticamente simile a YHWH. Sebbene l’interpretazione di questi dati sia dibattuta, essi suggeriscono un legame precoce tra il nome divino e le regioni a sud del Levante. A queste si affiancano le testimonianze bibliche più arcaiche, come i poemi in Deuteronomio 33,2, Giudici 5,4-5 e Abacuc 3,3, che descrivono costantemente YHWH come una divinità che “proviene” da sud, da località come Seir, Edom, Teman e il monte Paran. Per approfondire la natura di una divinità meridionale e “straniera”, Flynn introduce un caso di studio comparativo con il dio egizio Seth. L’analisi evidenzia come Seth, specialmente in certi periodi della storia egizia, fosse percepito come una divinità “outsider”: legato al deserto, alle terre straniere, alle carovane e agli spazi liminali, al di fuori dei grandi centri cultuali della valle del Nilo. Questa comparazione non mira a stabilire una derivazione diretta, ma a dimostrare l’esistenza nel Vicino Oriente antico di un modello di divinità marginale e non urbana, un modello che si attaglia perfettamente al profilo del primo YHWH.
Successivamente, l’analisi si sposta verso le origini settentrionali, esaminando i ben noti paralleli con il pantheon di Ugarit. Qui, il confronto si concentra principalmente sulle figure di El e Baal. Come Baal, YHWH condivide i tratti di una giovane e vigorosa divinità della tempesta e della guerra, la cui ascesa al potere è caratterizzata dal conflitto. In modo analogo a Baal, che deve negoziare il proprio status all’interno del consiglio divino presieduto dal patriarca El, anche il primo YHWH appare in una posizione subordinata. Flynn richiama il celebre passo di Deuteronomio 32,8-9, specialmente nella sua versione attestata a Qumran, dove El Elyon (“Dio l’Altissimo”) ripartisce le nazioni tra i “figli degli dèi”, assegnando Giacobbe come “porzione di YHWH”. In questo quadro teologico arcaico, YHWH non è il dio supremo, ma una delle divinità a cui è affidato il governo di un popolo specifico, agendo sotto l’autorità di un dio superiore.
Il contributo più significativo di Flynn in questo capitolo risiede nella sintesi di queste due narrazioni apparentemente concorrenti. Che si guardi a sud o a nord, emerge un profilo costante: il primo YHWH è una divinità liminale, non urbana e “outsider”. Non è il dio di un impero consolidato o di una capitale prestigiosa, ma una figura legata ai margini geografici (il deserto meridionale) e gerarchici (la sua posizione nel pantheon). È una divinità associata a popoli nomadi o seminomadi, a spazi non istituzionalizzati e a un’identità collettiva ancora in fase di formazione.
Questa caratterizzazione iniziale si rivela fondamentale per comprendere l’intera traiettoria successiva. Lo status di “outsider” di YHWH non rappresenta un limite, ma piuttosto la condizione stessa della sua futura ascesa. Una divinità già pienamente integrata in un sistema teologico e politico stabile, come poteva essere Ra a Eliopoli, non avrebbe posseduto la flessibilità e il potenziale necessari per essere adottata e radicalmente trasformata da un gruppo sociale emergente come il primo Israele. Al contrario, una divinità dinamica, guerriera, la cui storia è una narrazione di affermazione contro altre forze, offriva un modello teologico in perfetta “risonanza” con la condizione socio-politica di un popolo anch’esso “outsider” rispetto ai grandi imperi dell’epoca. La marginalità iniziale di YHWH, quindi, non è un difetto d’origine, ma la premessa indispensabile che gli permetterà di diventare il centro di un’identità nuova ed esclusiva. La sua storia, come la racconterà Flynn, è quella di un dio dei margini che conquista il centro, per poi ridefinire il concetto stesso di centro e, infine, tornare a identificarsi con coloro che vivono ai margini.
L’ascesa sulla scena internazionale: urbanizzazione e confronto con l’impero neo-assiro
Il terzo capitolo documenta una delle trasformazioni più decisive nella storia dello yahwismo: il passaggio di YHWH da divinità dei margini a nume tutelare di un centro urbano, Gerusalemme. Questo processo, secondo Flynn, non è indolore né privo di conseguenze, ma ridefinisce radicalmente la natura della divinità e la espone a nuove e formidabili pressioni.
L’analisi parte dal fenomeno dell’urbanizzazione come forza motrice del cambiamento religioso nel Vicino Oriente antico. L’associazione stretta tra una divinità e una città specifica, come Marduk con Babilonia o, in modo ancora più radicale, Aton con la nuova capitale di Akhenaton, Amarna, non era un fatto secondario. Significava legare il prestigio del dio al potere politico della città e viceversa, creando un’ideologia in cui la prosperità urbana e il favore divino erano inestricabilmente connessi. Per Israele, questo processo è riflesso nella tradizione biblica attraverso la competizione tra diversi centri cultuali (in particolare la memoria di Silo, che viene soppiantata da Gerusalemme) e la narrazione della solenne installazione dell’Arca dell’Alleanza nella città davidica, un atto fondativo che consacra Gerusalemme come dimora terrena di YHWH (2 Samuele 6; Salmo 132).
Una volta che YHWH diventa il dio di Gerusalemme, la città e la sua divinità entrano di diritto sulla scena internazionale, trovandosi a fronteggiare la superpotenza egemonica dell’epoca: l’impero neo-assiro. La sfida non era solo militare, ma profondamente teologica. L’ideologia imperiale assira presentava il re come vicario del dio nazionale Assur e interpretava l’espansione militare come l’esecuzione di un mandato divino volto a estendere l’ordine cosmico del proprio dio su tutta la terra. Questa “guerra di propaganda”, supportata da un’efficienza militare senza precedenti, costituiva una minaccia diretta all’identità e alla sopravvivenza teologica di un piccolo regno come Giuda.
È in questo contesto di pressione imperiale che Flynn individua l’emergere della ricezione sovversiva come strategia di resistenza teologica. Egli offre due casi di studio esemplari. Il primo è una lettura innovativa di Isaia 6. La celebre visione della chiamata del profeta nel tempio viene interpretata non solo come un’esperienza mistica, ma come un atto politico-teologico. Flynn la mette in parallelo con il rituale mesopotamico del mīs pî (“lavaggio della bocca”), una cerimonia complessa utilizzata per consacrare e “animare” le statue divine, rendendole ricettacoli effettivi della presenza e della parola del dio. In Assiria, questo rituale legittimava la statua del dio (e, per estensione, il re che ne era il servitore) come fonte dell’autorità divina. Secondo Flynn, Isaia 6 sovverte questo modello: un rituale analogo, simboleggiato dal carbone ardente che purifica le labbra del profeta, non consacra una statua inanimata, ma la persona vivente del profeta. L’autorità di parlare e agire per conto di Dio viene così trasferita dalla statua del dio imperiale al profeta giudeo, creando una fonte di legittimità divina alternativa e inattaccabile dal potere politico esterno.
Il secondo caso di studio è il libro di Naum. L’intero libro, un oracolo contro Ninive, capitale dell’Assiria, viene letto come un esercizio di ricezione sovversiva dell’iconografia regale assira. Flynn si concentra in particolare sull’immagine del leone. Nell’arte e nella propaganda neo-assira, il re dimostrava la sua forza e il suo dominio sul caos cacciando e uccidendo leoni. Naum si appropria di questa potente immagine, ma ne inverte i ruoli: ora è la stessa Assiria a essere identificata con il leone feroce, e YHWH assume il ruolo del cacciatore cosmico che sta per annientare la bestia. La propaganda imperiale viene così ritorta contro se stessa, trasformando un simbolo di potere assiro in un presagio della sua imminente distruzione per mano del Dio di Giuda.
L’urbanizzazione di YHWH, dunque, si rivela un’arma a doppio taglio. Da un lato, eleva il suo status da divinità tribale a dio nazionale, cementando l’identità del popolo attorno a un centro politico e cultuale. Dall’altro, crea una profonda vulnerabilità teologica: legando indissolubilmente la sorte del dio a quella della città, espone lo yahwismo a una crisi esistenziale in caso di sconfitta militare. La teologia del Vicino Oriente antico era chiara su questo punto: la caduta di una città implicava la sconfitta e l’impotenza del suo dio protettore. Pertanto, il processo di urbanizzazione, pur rappresentando un momento di ascesa e consolidamento, pone involontariamente le premesse per la più grande catastrofe teologica nella storia di Israele: l’esilio babilonese, che costringerà gli eredi della tradizione yahwista a un ripensamento radicale della natura stessa della presenza e del potere di Dio.
La crisi dell’esilio: dalla presenza urbana all’universalismo concettuale
La distruzione di Gerusalemme e del suo tempio da parte dei Babilonesi nel 587 a.C., analizzata nel quarto capitolo, rappresenta il punto di rottura, il fallimento del modello teologico che legava indissolubilmente YHWH a uno spazio urbano specifico. Lungi dal segnare la fine dello yahwismo, questa catastrofe agì come un potente catalizzatore, innescando una serie di risposte teologiche creative e profonde che avrebbero trasformato per sempre il volto della divinità israelitica.
Flynn esplora la pluralità di queste reazioni. Alcuni testi, come il Salmo 137, esprimono il trauma crudo e viscerale della perdita. La celebre domanda “Come possiamo cantare i canti del Signore in terra straniera?” cattura il senso di disorientamento e l’apparente impossibilità di praticare il culto al di fuori dello spazio sacro designato. È la voce della disperazione che si aggrappa alla memoria di un mondo perduto. Altri lamenti, come il Salmo 44, articolano il senso di abbandono divino attraverso il motivo, comune nel Vicino Oriente antico, della “divinità dormiente”. L’inazione di YHWH di fronte alla sofferenza del suo popolo è rappresentata come un sonno, un silenzio che lascia la comunità senza risposte e senza risoluzione. Questo testo mostra come, di fronte alla crisi, alcuni autori si affidassero a tropi culturali condivisi per esprimere il loro dolore, senza necessariamente formulare una nuova e complessa teodicea.
Tuttavia, altre correnti di pensiero elaborarono soluzioni più strutturate e destinate ad avere un impatto duraturo. La Storia Deuteronomistica e gli scritti profetici a essa associati, come Geremia, offrono una potente rilettura retrospettiva degli eventi. La catastrofe non è la prova della debolezza di YHWH di fronte agli dèi di Babilonia, ma, al contrario, la manifestazione della sua giustizia sovrana. YHWH non è stato sconfitto; è stato lui a utilizzare l’impero babilonese come “bastone della sua ira” per punire l’infedeltà del suo popolo all’alleanza. In questa visione, YHWH viene trasformato da una divinità locale, la cui efficacia è legata a un territorio, a un Signore universale della storia. Di conseguenza, il fulcro della relazione con Dio si sposta dalla presenza fisica nel tempio all’obbedienza etica e cultuale alla Torah. La vera “dimora” di Dio non sono più le mura di pietra, ma la fedeltà del cuore della comunità.
La tradizione Sacerdotale (P), a cui gli studiosi attribuiscono la stesura di Genesi 1, offre una risposta ancora più radicale e cosmica. Scritto con ogni probabilità durante o immediatamente dopo l’esilio, questo testo è una magistrale opera di teologia polemica. Senza ingaggiare una battaglia mitologica diretta, sovverte l’epica della creazione babilonese, l’Enuma Elish. Invece di un cosmo nato da un conflitto violento tra divinità, Genesi 1 presenta una creazione ordinata attraverso la parola sovrana di un unico Dio. Le grandi divinità astrali e naturali del pantheon mesopotamico – il sole (Shamash), la luna (Sin), il mare (Tiamat) – vengono declassate a semplici “luci” e creature, private del loro nome e della loro autonomia divina, e subordinate alla volontà del creatore. In questa nuova visione, il vero tempio di YHWH non è più un edificio a Gerusalemme, ma l’intero cosmo. La sua presenza non è più localizzata, ma manifestata nell’ordine della creazione e nel ritmo settimanale del sabato, che diventa un santuario nel tempo, accessibile a tutti, ovunque. YHWH emerge come un Dio trascendente, universale e onnipotente, la cui sovranità non può essere messa in discussione dalla caduta di una singola città.
Infine, il libro di Abacuc, che si colloca forse sulla soglia della crisi, anticipa le domande che l’esilio renderà urgenti. Il profeta lotta con il problema della teodicea: come può un Dio santo e giusto usare uno strumento così malvagio come l’impero babilonese? La risposta che il libro abbozza sposta il baricentro della sopravvivenza spirituale. Non è più la sicurezza istituzionale del tempio o della monarchia a garantire salvezza, ma una disposizione interiore: “il giusto vivrà per la sua fede” (Abacuc 2,4). Si tratta di un passo fondamentale verso l’interiorizzazione della fede e la definizione di un rapporto con Dio basato sulla fiducia e sulla perseveranza etica, indipendentemente dalle circostanze esterne.
La crisi esilica, quindi, agisce come un potente “filtro evolutivo” per la teologia israelitica. I modelli che legavano YHWH in modo indissolubile a un luogo fisico si dimostrano inadeguati a sopravvivere alla catastrofe. Le concezioni che emergono e si affermano sono quelle che riescono a “deterritorializzare” la presenza divina, spostandola dal luogo (il tempio) al testo (la Torah), al tempo (il sabato), alla comunità (il popolo fedele) e al cosmo (la creazione). Lungi dal rappresentare la fine dello yahwismo, l’esilio ne fu il più potente catalizzatore, costringendolo a evolversi da religione nazionale incentrata sul culto a una “religione del libro” con una vocazione universale, ponendo così le basi per il giudaismo del Secondo Tempio e, indirettamente, per le grandi religioni monoteistiche che da esso sarebbero derivate.
Le “vite postume” dello yahwismo: universalismo e particolarismo nel periodo persiano
Il quinto capitolo esplora le complesse e spesso conflittuali traiettorie dello yahwismo nel periodo post-esilico, sotto la dominazione persiana. Lungi dall’essere un’epoca di monolitica restaurazione, questo periodo è caratterizzato da una frammentazione della comunità giudaica e da una pluralità di espressioni teologiche che riflettono le diverse esperienze e i diversi contesti (Yehud, Egitto, Babilonia).
Flynn inizia la sua analisi con la comunità giudaica di Elefantina, in Egitto. I papiri aramaici scoperti in questa guarnigione militare rivelano un quadro dello yahwismo sorprendentemente diverso da quello promosso dall’élite scribale di Gerusalemme. Qui, il culto di YHW (una forma del nome divino) non solo possedeva un proprio tempio con altari e sacrifici – in apparente violazione del principio deuteronomico di centralizzazione del culto – ma coesisteva con la venerazione di altre divinità. I testi menzionano entità come Anat-Yahu, interpretata da molti come una paredra o consorte di YHW, e altre divinità come Ashim-Bethel. Questo “yahwismo della diaspora” dimostra la persistenza di pratiche politeistiche o sincretistiche e suggerisce che l’ideale monoteistico e centralizzatore, propugnato da alcune correnti della Bibbia Ebraica, non era affatto universalmente accettato tra tutti coloro che si identificavano come adoratori del Dio di Israele.
Spostando l’attenzione sulla comunità di Yehud (la provincia persiana di Giuda), Flynn analizza il Terzo Isaia (Isaia 56-66) come un testo che riflette le profonde tensioni interne del post-esilio. La questione centrale non è più la lotta contro il politeismo, ma il dibattito su chi costituisca il “vero Israele” e su quali siano i confini della comunità restaurata. Il capitolo mette in luce la dialettica tra particolarismo e universalismo. Da un lato, ci sono spinte esclusiviste che mirano a definire l’identità giudaica su basi genealogiche e rituali rigide. Dall’altro, testi come Isaia 56,1-8 aprono le porte della comunità agli “stranieri” e agli “eunuchi” che scelgono di osservare il sabato e di aderire all’alleanza, suggerendo un’identità basata sulla fede e sulla pratica piuttosto che sulla sola discendenza. Flynn si sofferma su Isaia 57,15, dove YHWH dichiara di dimorare “in alto e nel luogo santo”, ma anche “con chi è contrito e umile di spirito”. Questa duplice localizzazione della presenza divina – trascendente e immanente – indica uno spostamento significativo: la dimora di Dio non è più esclusivamente il tempio fisico, ma si estende alla comunità dei pii e dei sofferenti. Si assiste a un ritorno tematico alla connessione originaria di YHWH con i marginalizzati, ora ridefinita in termini spirituali ed etici.
L’apice di questa tendenza universalista è rappresentato, secondo Flynn, dal libro di Giona. L’autore lo interpreta come una brillante satira letteraria e una critica radicale al nazionalismo particolarista. Giona, che incarna il profeta nazionalista desideroso della distruzione dei nemici di Israele (rappresentati da Ninive, la capitale assira), fugge da un Dio la cui misericordia si rivela insopportabilmente universale. Il libro utilizza magistralmente la metafora dello spazio per illustrare questo conflitto teologico. Giona tenta di sottrarsi alla presenza di YHWH sia orizzontalmente, fuggendo verso Tarsis, ai confini del mondo conosciuto, sia verticalmente, sprofondando negli abissi marini. In entrambi i casi, scopre che la sovranità di YHWH è assoluta e non conosce confini geografici o cosmici. La narrazione culmina nella lezione divina sulla compassione, che si estende non solo agli abitanti di Ninive, ma persino al loro bestiame, rappresentando una delle affermazioni più potenti dell’universalismo teologico nel periodo persiano. Il libro, quindi, funziona come una reductio ad absurdum della posizione particolarista: un profeta che si lamenta perché il suo Dio è troppo misericordioso appare teologicamente incoerente e moralmente meschino.
L’analisi di Flynn dimostra che il periodo persiano non segna l’affermazione di un’unica ortodossia, ma piuttosto l’inizio di un’intensa lotta interna al giudaismo per la sua stessa anima. La teologia universalista forgiata nella crisi dell’esilio – l’idea di YHWH come unico creatore e signore della storia – si scontra ora con la necessità pratica di ricostruire una comunità distinta e definire i suoi confini in un contesto post-imperiale. Correnti più esclusiviste, come quelle riflesse in Esdra e Neemia con il loro divieto di matrimoni misti, spingono per un’identità basata sulla purezza genealogica. Testi come Giona e parti del Terzo Isaia, invece, controbattono che la logica stessa di un Dio universale esige un’apertura e una missione che trascendano i confini etnici. Il monoteismo, quindi, non risolve i problemi teologici, ma ne crea di nuovi e più complessi. Una volta stabilito che esiste un solo Dio per tutta l’umanità, la domanda centrale diventa: qual è, allora, il ruolo specifico del popolo eletto? Questa tensione fondamentale tra l’universalità di Dio e la particolarità del suo popolo diventerà una delle dinamiche più creative e durature del pensiero ebraico e, successivamente, di quello cristiano.
Valutazione conclusiva: contributi, limiti e importanza dell’opera
Giunti al termine di questa analisi, è possibile formulare una valutazione complessiva del volume A Story of YHWH di Shawn W. Flynn, evidenziandone i contributi originali, i limiti intrinseci e l’importanza generale per il campo degli studi biblici e storico-religiosi.
I contributi originali dell’opera sono molteplici e significativi. In primo luogo, il merito principale del libro risiede nel suo approccio metodologico, incentrato sulla domanda “perché”. Spostando l’attenzione dalle analisi comparative statiche a un’indagine dinamica sulle cause e le motivazioni del cambiamento teologico, Flynn offre una prospettiva più vivace e storicamente contestualizzata sull’evoluzione dello yahwismo. In secondo luogo, l’applicazione sistematica dei concetti di “traduzione culturale” e “ricezione sovversiva” fornisce al lettore un vocabolario analitico ricco e sfumato per descrivere le diverse modalità di interazione tra la cultura israelita e il suo contesto vicino-orientale. Terzo, il libro riesce a costruire una narrazione diacronica coerente e avvincente, articolata attraverso tappe storiche ben definite (pre-monarchia, pressione assira, esilio, periodo persiano), che guida il lettore attraverso la complessa “carriera” di YHWH, da divinità tribale “outsider” a Dio universale. Infine, l’enfasi sulla dimensione spaziale (periferia vs. centro, tempio vs. cosmo) come chiave interpretativa per comprendere la natura di YHWH costituisce un filo conduttore particolarmente illuminante che attraversa l’intera opera.
Tuttavia, è anche necessario riconoscere i limiti di un’impresa così ambiziosa. Come lo stesso Flynn ammette con onestà intellettuale, ogni narrazione diacronica di ampio respiro è, per sua natura, una ricostruzione ipotetica. Essa si fonda su datazioni dei testi biblici che, in molti casi, rimangono oggetto di un acceso dibattito accademico. Un approccio critico, pur apprezzando la coerenza del modello proposto, deve riconoscere che studiosi con presupposti diversi sulla cronologia di testi chiave potrebbero giungere a conclusioni differenti. Inoltre, la costruzione di una narrazione lineare richiede necessariamente una certa selettività delle fonti. Sebbene i testi scelti da Flynn siano esemplari e ben analizzati, altri testi degli stessi periodi potrebbero offrire ritratti di YHWH più complessi o contraddittori, che si inseriscono con maggiore difficoltà nella traiettoria delineata. Infine, la distinzione tra “traduzione culturale” (descritta come più organica e meno conscia) e “ricezione sovversiva” (intenzionale e strategica), sebbene euristicamente molto utile, potrebbe in alcuni casi semplificare processi culturali che si collocano in una zona grigia e ambigua tra i due poli.
Nonostante queste inevitabili limitazioni, l’importanza complessiva di A Story of YHWH è indiscutibile. L’opera si qualifica come una sintesi di alto livello, indispensabile per studenti avanzati e specialisti del settore, offrendo un quadro interpretativo robusto, aggiornato e metodologicamente stimolante. La sua maggiore forza risiede nella capacità di integrare in modo magistrale l’esegesi testuale, i dati archeologici ed epigrafici del Vicino Oriente antico e la teoria socio-antropologica, il tutto all’interno di una narrazione che è al contempo accessibile e scientificamente rigorosa.
Il libro di Flynn fornisce un modello esemplare di come la storia della religione israelita possa essere scritta non come una sterile successione di dogmi, ma come la storia dinamica e contestuale di un popolo che lotta per dare un senso alla propria esperienza del divino di fronte a sfide storiche monumentali. È un contributo significativo che invita a riconsiderare non solo la storia di YHWH, ma anche la metodologia stessa con cui tale storia viene raccontata, dimostrando che la teologia è, in ultima analisi, una forma di risposta creativa alle pressioni della storia.
La tabella seguente riassume la traiettoria evolutiva di YHWH come delineata da Flynn, mettendo in relazione i periodi storici con le caratteristiche della divinità, i contesti spaziali, le pressioni esterne e le modalità di interazione culturale.
L’Evoluzione della Concezione di YHWH secondo Shawn W. Flynn
| Periodo Storico | Caratterizzazione Principale di YHWH | Spazio di Riferimento | Pressione Esterna Principale | Modalità di Interazione Culturale Prevalente | Testi Esemplari |
| Età del Ferro I (ca. 1200-1000 a.C.) | Dio guerriero, “outsider”, subordinato nel pantheon | Spazi liminali, non urbani (deserto, montagne) | Competizione tra gruppi tribali locali | Traduzione Culturale (matrice culturale condivisa) | Gdc 5; Dt 32,8-9; Salmi arcaici |
| Età del Ferro IIA/B (ca. 900-722 a.C.) | Divinità nazionale, legata alla monarchia e al tempio | Centro urbano (Gerusalemme) | Competizione con regni vicini (Moab, Aram) | Traduzione Culturale / Prime forme di Ricezione Sovversiva | 2 Sam 6; Salmi regali; Iscrizioni di Kuntillet Ajrud |
| Età del Ferro IIC (ca. 722-587 a.C.) | Signore della storia, che usa gli imperi come strumenti | Gerusalemme (minacciata) | Impero Neo-Assiro | Ricezione Sovversiva | Isaia 6, 10; Naum; parti del Deuteronomio |
| Periodo Esilico (587-539 a.C.) | Creatore trascendente, Signore universale, Dio della Legge | Cosmo, Comunità in esilio, Testo (Torah) | Impero Neo-Babilonese / Crisi della distruzione | Sviluppo Interno / Polemica Sovversiva | Genesi 1; Secondo Isaia; Geremia; Ezechiele |
| Periodo Persiano (539-332 a.C.) | Dio universale di misericordia / Dio particolare della comunità restaurata | Comunità locale vs. Mondo intero | Impero Persiano / Conflitti interni | Dialogo Interno alla Tradizione (Universalismo vs. Particolarismo) | Terzo Isaia; Giona; Esdra-Neemia |