La necessità di una prospettiva storica nello studio delle religioni
L’opera di Dario Sabbatucci, La prospettiva storico-religiosa, pubblicata in prima edizione a Milano da Il Saggiatore nel 1990 e in seconda edizione a Roma dalle Edizioni SEAM nel 2000, si presenta al lettore non come un semplice manuale, ma come un saggio programmatico e una rigorosa lezione di metodo. Fin dalle prime pagine, il volume sfida le categorie concettuali più radicate, invitando a una riconsiderazione critica delle fondamenta stesse su cui poggia lo studio delle religioni. Il titolo stesso è una dichiarazione d’intenti: non si tratta di un compendio di nozioni sulle religioni del mondo, ma di un’opera che mira a forgiare lo sguardo dello studioso, a insegnare un modo di osservare i fenomeni culturali.
La tesi centrale, esplicitata con chiarezza nella premessa, è la necessità di adottare una “prospettiva storico-religiosa in senso proprio”. Questa, erede della scuola fondata in Italia da Raffaele Pettazzoni, si definisce come “autenticamente storica” e si contrappone a una diffusa “storia delle religioni esplicata come una disciplina più ‘religiosa’ che ‘storica’”. Quest’ultima, secondo Sabbatucci, commette l’errore metodologico capitale di proiettare in modo acritico le categorie della cultura occidentale, e in particolare del cristianesimo, su civiltà e contesti storici differenti, universalizzando ciò che è invece un prodotto specifico e contingente. Il percorso argomentativo del libro segue questa traccia, partendo dalla decostruzione del concetto apparentemente più universale, la “fede”, per poi estendere la critica agli approcci a-storici e delineare, infine, i principi positivi del metodo storico-religioso. L’opera di Sabbatucci, dunque, non vuole descrivere le religioni altrui, ma compiere un’operazione preliminare e fondamentale: insegnare a riconoscere e a neutralizzare i condizionamenti della nostra stessa cultura, affinché l’analisi storica possa essere condotta con il massimo rigore scientifico possibile.
Il cuore del metodo: la storicizzazione della fede
Il nucleo del metodo di Sabbatucci è esposto in modo paradigmatico nel primo capitolo, “Fede nella fede”. L’autore individua un problema fondamentale: la storia delle religioni ha a lungo problematizzato gli “oggetti di fede”, ma quasi mai la “fede stessa”, trattandola come un “dato” naturale e astorico, una qualità connaturata all’uomo, e non come un “fatto” storico, ovvero un prodotto culturale con una sua precisa genealogia. Questa operazione, spesso inconscia, porta a considerare la fede come il nocciolo di ogni religione, un presupposto universale che in realtà, dimostra Sabbatucci, è profondamente condizionato dal modello cristiano. L’autore critica l’uso disinvolto di espressioni come “la fede dei Boscimani !Kung”, rilevando come tale linguaggio proietti un intero universo concettuale cristiano su una cultura che non lo possiede, annientando secoli di storia con una singola frase.
L’autore procede a una lucida storicizzazione, dimostrando come il concetto di “fede” che oggi ci appare ovvio – un “credere con alternativa” finalizzato a una salvezza oltremondana – sia un prodotto specifico della storia cristiana. Esso emerge dalla scelta storica di riconoscere in Gesù il Messia, una scelta che distingueva i primi cristiani dagli altri ebrei e che richiedeva un atto di fede personale in una promessa di salvezza extramondana. Questa fede, misurata dall’eroismo dei martiri e dei confessori e istituzionalizzata nelle “confessioni” protestanti, è un costrutto storicamente determinato e non una categoria universale dello spirito umano. Sabbatucci mostra come la stessa santità cristiana sia legata a doppio filo a questo concetto: i primi santi furono i martiri, coloro che “confessarono” la propria fede fino alla morte, e in seguito i “confessori”, che la testimoniarono con una vita eroica interamente dedicata alla realtà oltremondana. Questa genealogia dimostra che la fede non è un’emozione generica, ma un atto istituzionale preciso, con una sua storia e una sua funzione all’interno di un sistema culturale specifico.
Per illustrare in modo inconfutabile questa specificità, Sabbatucci mette in atto il suo metodo comparativo nel secondo capitolo, “La parola e la fede”. Il confronto non è volto a trovare somiglianze, ma a far emergere l’incommensurabilità storica dei concetti. La fides romana non era la fede cristiana. Per i Romani, fides significava “lealtà”, un patto di reciprocità tra uomini e dèi che garantiva una salvezza terrena, mondana, e che trovava la sua espressione nel rispetto dei patti (foedus) e nella pace (pax deorum). Era una virtù civile, non un atto di fiducia individuale in una realtà trascendente. Sabbatucci approfondisce l’analisi mostrando come la fides fosse così centrale per l’ordine civico da essere divinizzata nella dea Fides, il cui tempio sorgeva sul Campidoglio. Inoltre, la contrappone alla dea Spes (Speranza), evidenziando come per i Romani le due fossero antitetiche (o si agisce sulla base della certezza di un patto, la fides, o si spera nella buona sorte, la spes), a differenza del cristianesimo che le unisce come virtù teologali solidali. Questa comparazione smaschera l’errore di una traduzione superficiale e dimostra come l’applicazione della nostra categoria di “fede” a un contesto come quello romano ne travisi completamente il significato. Questa mossa metodologica iniziale è esemplare: se persino un concetto basilare come la “fede” si rivela un prodotto storico contingente, a maggior ragione lo saranno tutte le altre categorie analitiche utilizzate dalla disciplina.
La critica alle prospettive “più religiose che storiche”
Una volta stabilito il principio della storicità, Sabbatucci dedica ampia parte del volume a una critica serrata di quegli approcci che, a suo avviso, sono viziati da un errore metodologico di fondo: la destorificazione. Correnti come la fenomenologia religiosa, la psicologia della religione e certa antropologia tendono a cercare “essenze” universali e metastoriche, ignorando i contesti specifici e proiettando modelli preconcetti sulla realtà storica.
Un bersaglio centrale di questa critica è l’ipotesi dell’homo religiosus, analizzata nel capitolo ottavo. Sabbatucci dimostra come questo costrutto non sia uno strumento euristico neutro, ma un’ipotesi che maschera un’impostazione teologica. Presupporre una “religiosità” innata e universale, modellata di fatto sull’esperienza cristiana, serve a sottrarre il fenomeno religioso all’analisi storica rigorosa, ponendolo in una dimensione metastorica che lo rende inattaccabile dalla critica. L’autore mostra come questa operazione, spesso condotta da teologi che si improvvisano psicologi o antropologi, porti a un circolo vizioso: si parte dall’idea di una religiosità universale per “trovarla” in ogni cultura, interpretando ogni dato in funzione di questa premessa. La religiosità diventa così una qualità umana astratta, irriducibile alla ragione storica, e la religione il suo prodotto, anch’esso sottratto all’analisi critica.
Allo stesso modo, nel capitolo nono, viene decostruita la teoria del “monoteismo primordiale” (Urmonotheismus) di Padre Wilhelm Schmidt. Sabbatucci svela come questa teoria si fondi su un’interpretazione selettiva e forzata dei dati. L’analisi di reperti preistorici, come il presunto “culto dell’orso”, o di dati etnografici relativi ai popoli siberiani, viene piegata alla necessità di “trovare” un Dio unico originario che confermi il racconto biblico. Questo approccio ignora deliberatamente i complessi e documentabili processi di acculturazione storica, come l’influenza del monoteismo cinese o islamico su quelle stesse popolazioni, che spiegherebbero i dati in modo molto più economico e storicamente fondato. Sabbatucci mostra, ad esempio, come la nozione di un “Essere Supremo” tra i popoli siberiani sia spesso legata a termini derivati dal cinese T’ien (Cielo) o dal persiano Ahura Mazda, indicando un processo di diffusione storica e non la sopravvivenza di una credenza primordiale. L’errore metodologico, anche in questo caso, è quello di partire da una tesi teologica (la Rivelazione originaria) e di usare la storia e l’etnografia non per indagare, ma per confermare aprioristicamente quella tesi.
L’analisi critica culmina nel confronto con Mircea Eliade, l’interlocutore privilegiato di Sabbatucci. Pur riconoscendo la coerenza interna e la razionalità del suo sistema, Sabbatucci ne attacca il fondamento metodologico. La ricerca di “archetipi” e “ierofanie” (manifestazioni del sacro) astrae i fenomeni – il cielo, la luna, le acque – dal loro specifico contesto culturale per inserirli in una “storia” metastorica e universale. Questa operazione, apparentemente scientifica, si rivela essere una forma di “cripto-teologia”: un discorso su Dio mascherato da scienza, in cui il modello implicito di ogni manifestazione del sacro rimane quello cristiano. L’errore, ancora una volta, non risiede nell’interpretazione di un singolo dato, ma nel presupposto a-storico che guida l’intera ricerca, rendendola circolare: si trovano archetipi universali perché si è partiti dal presupposto che esistano. Per Sabbatucci, il metodo di Eliade, pur affascinante, vanifica la storia, riducendo la specificità irriducibile delle culture a semplici variazioni di un tema universale che, in ultima analisi, è quello della cultura occidentale stessa.
La prospettiva storico-religiosa: in cosa consiste
Se la parte critica del libro è demolitoria, la sua parte costruttiva è altrettanto potente e risponde con chiarezza alla domanda su cosa sia, in positivo, il metodo storico-religioso. Erede della lezione di Pettazzoni, esso consiste nel trattare la religione non come una categoria a sé stante, ma come una “forma della civiltà”, un prodotto culturale pienamente integrato e inseparabile dalle altre dimensioni – politica, sociale, economica – di una data cultura.
Questo approccio si fonda su alcuni principi cardine. Il primo è l’analisi rigorosa del contesto culturale specifico. Ogni fatto religioso va compreso all’interno del suo peculiare sistema di valori. L’esempio magistrale è nel capitolo quarto, “Acqua nel vino”. Sabbatucci analizza la contrapposizione tra il sago (cibo quotidiano, femminile) e l’uati (bevanda inebriante, maschile) presso i Marind-anim della Nuova Guinea. Un approccio fenomenologico interpreterebbe questa coppia secondo la dialettica occidentale sacro/profano. L’analisi storico-religiosa, invece, mostra come essa funzioni all’interno della loro specifica dialettica maschile/femminile, la quale svolge una funzione “cosmicizzante” totale, che ordina l’intero universo culturale e sociale, senza essere limitata a una sfera “religiosa” separata dal resto. In questa cultura, il maschile e il femminile non sono solo generi biologici, ma principi cosmici che strutturano ogni aspetto della realtà, dal cibo alle attività rituali. Applicare la nostra distinzione sacro/profano significherebbe imporre una categoria estranea e perdere la chiave di volta del loro sistema di valori.
Il secondo principio è la storicizzazione delle categorie analitiche. Lo storico deve sottoporre a critica non solo il suo oggetto, ma anche i suoi stessi strumenti concettuali. L’esempio della “teocrazia” (capitoli 10 e 11) è illuminante. Sabbatucci non la tratta come una forma di governo universale, ma ne rintraccia la nascita precisa nel I secolo d.C. con lo storico Flavio Giuseppe, che coniò il termine per descrivere la “costituzione mosaica” in un contesto apologetico specifico, volto a renderla comprensibile al mondo greco-romano. Flavio Giuseppe, confrontandosi con le categorie politiche greche (monarchia, aristocrazia, democrazia), inventò un quarto termine per definire un sistema in cui Dio stesso è il legislatore e il sovrano. Applicare questa categoria a-storicamente ad altri contesti, come fa certa sociologia, è un’operazione che la svuota della sua concretezza e ne travisa la funzione, riducendola a un generico “governo di sacerdoti” (ierocrazia) e perdendone la specificità monoteistica e storica.
Infine, un punto chiave del metodo è il riconoscimento della specificità della cultura occidentale. La nostra distinzione tra “religioso” e “civico”, tra potere spirituale e temporale, è essa stessa un prodotto storico complesso, non una griglia universale applicabile a tutte le civiltà. Molte culture non operano questa distinzione, e la nostra tendenza a cercare una “religione” separata dal resto della vita sociale costituisce il principale ostacolo alla loro comprensione. Sabbatucci mostra come questa separazione affondi le sue radici nella cultura romana, con la sua dialettica tra sacro/profano e pubblico/privato, e si sia poi evoluta attraverso la storia europea, dalla lotta per le investiture fino al laicismo moderno. Comprendere questa genealogia è fondamentale per rendersi conto che quando cerchiamo “la religione” in un’altra cultura, stiamo cercando qualcosa che potrebbe semplicemente non esistere come entità separata. Il metodo storico-religioso è, in definitiva, radicalmente anti-essenzialista: non cerca “cosa è” la religione in astratto, ma “come funziona” un determinato sistema di valori in un preciso contesto storico, mostrando come ogni cultura costruisca il proprio cosmo in modo irriducibilmente specifico.
Collocazione e oblio di un maestro
Per comprendere appieno il valore e l’originalità de La prospettiva storico-religiosa, è necessario collocare Dario Sabbatucci nel panorama degli studi del Novecento. Egli è stato uno degli esponenti più rigorosi e radicali della cosiddetta “Scuola romana di Storia delle religioni”, fondata dal suo maestro Raffaele Pettazzoni. Questa scuola si è sempre distinta per un approccio rigorosamente storico, aconfessionale e comparativo, in netta opposizione alle correnti fenomenologiche e teologizzanti che dominavano la scena internazionale. Il metodo del “comparativismo storico”, inaugurato da Pettazzoni e sviluppato da Brelich e poi, appunto, (tra gli altri) da Sabbatucci, non utilizza la comparazione per livellare i fenomeni alla ricerca di “essenze” universali, ma al contrario per far emergere, attraverso il confronto, l’irriducibile specificità storica di ogni singolo fatto culturale.
Sabbatucci ha portato questo metodo alle sue estreme conseguenze, giungendo a quello che lui stesso definì uno “storicismo assoluto”. La sua mossa più radicale non è stata solo quella di storicizzare i fenomeni religiosi altrui, ma di rivolgere lo stesso sguardo critico alle categorie analitiche dello studioso occidentale. Concetti come “religione”, “fede”, “mito”, “sacro” e “profano” non sono, per Sabbatucci, strumenti neutri e universali, ma prodotti storici della cultura occidentale. Applicarli acriticamente ad altre civiltà è un atto di violenza ermeneutica che ne impedisce la comprensione. Da qui la sua tesi della “vanificazione dell’oggetto religioso”: non si tratta di negare la realtà dei fenomeni, ma di mettere in discussione l’esistenza stessa di una categoria universale e autonoma chiamata “religione”, separata dalle altre sfere della vita (politica, sociale, economica), una separazione che, come dimostra, è essa stessa un prodotto storico peculiare dell’Occidente.
Proprio la radicalità e il rigore di questa impostazione sono, paradossalmente, tra le cause del progressivo oblio che il suo contributo sta subendo. In un panorama accademico internazionale sempre più dominato dal modello anglofono dei Religious Studies, caratterizzato da un approccio spesso eclettico che mescola sociologia, antropologia e fenomenologia, la severa disciplina storica della Scuola romana appare a molti anacronistica o eccessivamente polemica. La globalizzazione degli studi ha portato a una sorta di monolinguismo accademico che tende a marginalizzare le tradizioni di pensiero non anglofone, inclusa quella italiana. Inoltre, la critica demolitoria che Sabbatucci ha rivolto a figure canoniche come Mircea Eliade, la cui opera viene definita “inutile” per lo storico, non ha certo favorito la sua ricezione in ambienti accademici che su quelle figure hanno costruito interi paradigmi.
A questo si aggiunge un mutato clima culturale. In una società come quella italiana contemporanea, caratterizzata da un lato da un pluralismo religioso crescente e dall’altro da una religiosità sempre più individualizzata, fluida e “oscillante”, gli approcci sociologici e antropologici al “fatto religioso” odierno sembrano offrire risposte più immediate rispetto a una complessa archeologia della mentalità occidentale. L’oblio del metodo storico-religioso è, in un certo senso, un sintomo di quell’oblio della storia e delle genealogie culturali contro cui Sabbatucci ha combattuto per tutta la vita. La sua lezione, oggi più che mai, ci ricorda che per comprendere l’altro è indispensabile un’incessante e spietata critica di sé.
Il valore duraturo di un’opera fondamentale
In conclusione, La prospettiva storico-religiosa è molto più di un saggio. È un’opera che offre una proposta costruttiva per una disciplina più rigorosa, pienamente consapevole dei propri condizionamenti culturali e dei propri limiti metodologici. Il guadagno più profondo che il lettore trae dal metodo di Sabbatucci non è tanto la capacità di comprendere meglio le culture “altre”, ma soprattutto la possibilità di rivolgere uno sguardo critico sulla nostra stessa civiltà. Storicizzando categorie che diamo per scontate come “fede”, “scienza”, “religione” e “civiltà”, l’autore compie una vera e propria “archeologia della mentalità moderna”, svelandone le fondamenta storiche e, quindi, la loro natura contingente e non universale.
Il libro insegna che fare storia delle religioni non significa accumulare dati esotici, ma affinare uno strumento critico che ci permette di dialogare con il passato e con l’alterità senza proiettarvi ingenuamente noi stessi. La lezione di Sabbatucci è una lezione di umiltà intellettuale: ci costringe a riconoscere che le nostre categorie non sono finestre trasparenti sul mondo, ma lenti colorate, forgiate dalla nostra storia. Solo prendendo coscienza di queste lenti possiamo sperare di vedere qualcosa di ciò che sta al di là.
Nonostante la densità concettuale e il rigore a tratti polemico, il libro di Dario Sabbatucci si rivela un’opera intellettualmente liberatoria. Offre gli strumenti per pensare la storia e la cultura al di fuori delle categorie precostituite, rappresentando una lettura imprescindibile e di straordinaria attualità per chiunque si occupi di scienze umane con serietà e onestà intellettuale.

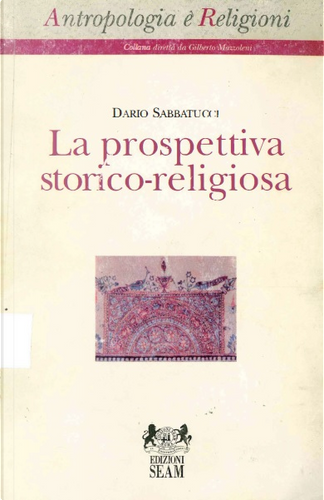
Bella recensione e libro molto interessante. Io ho sempre pensato a una religiosità universale di base che si manifesta storicamente nelle forme più varie, ma sono certamente pronto a prendere in considerazione una tesi diversa presentata da uno studioso.