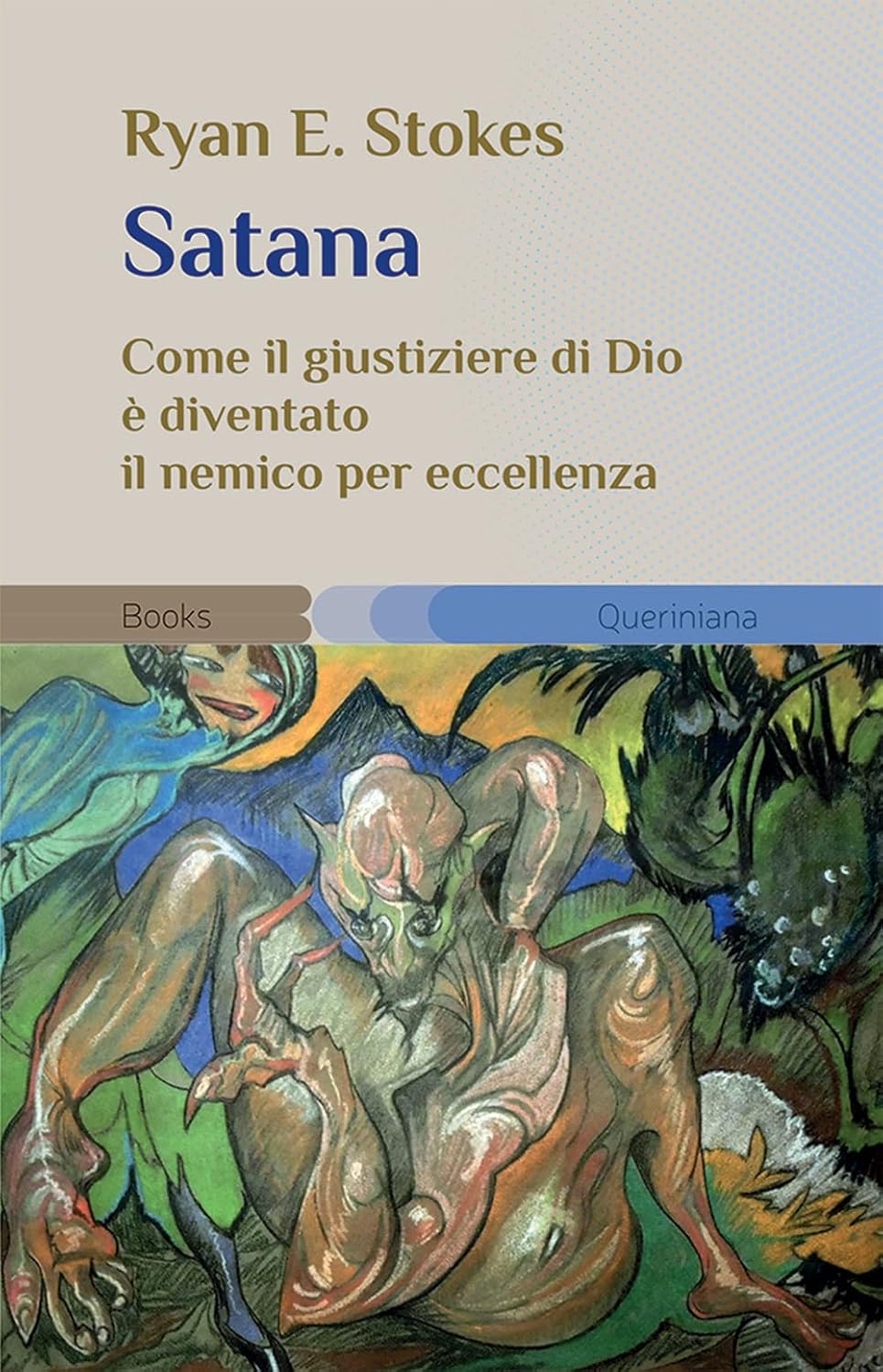Nel vasto panorama degli studi biblici, poche figure sono tanto iconiche e, al contempo, così profondamente fraintese come quella di Satana. L’immagine popolare, cristallizzata in secoli di arte e teologia, ce lo presenta come un demone rosso, armato di forcone, principe delle tenebre e avversario cosmico di Dio sin dall’alba dei tempi (p. 7). È proprio per smontare questa visione monolitica e anacronistica che Ryan E. Stokes, biblista statunitense e docente alla Carson-Newman University (p. 10), ha intrapreso la stesura di Satana. Come il giustiziere di Dio è diventato il nemico per eccellenza. Pubblicato in Italia da Queriniana, il volume è un’opera magistrale di storiografia religiosa che si prefigge di tracciare l’evoluzione di questa complessa figura dalle sue prime apparizioni nelle Scritture ebraiche fino al suo consolidamento nella letteratura del primo giudaismo e del Nuovo Testamento.
Come sottolinea John J. Collins nella sua prefazione (pp. 5-9), il lavoro di Stokes si distingue per il suo rigore metodologico. L’approccio non è teologico, ma squisitamente storico-descrittivo (p. 14). L’autore non si interroga sull’esistenza o la natura ontologica del Satana, ma pone domande ben più circoscritte e verificabili: «Cosa dicono e credono gli autori antichi in merito al Satana e figure affini?» e «Cosa si può apprendere sui processi letterari e teologici antichi che hanno dato origine alle successive concezioni del Satana?» (p. 15). Il risultato è un’indagine diacronica che svela una tradizione dinamica e sfaccettata, in cui un umile funzionario divino si trasforma progressivamente nel supremo antagonista del Bene (p. 13).
Capitolo 1: Le origini del Satana
Il primo capitolo getta le fondamenta dell’intera argomentazione di Stokes, affrontando la questione fondamentale delle origini del “satana” nelle Scritture ebraiche. L’autore inizia decostruendo il consenso critico tradizionale, che ipotizzava uno sviluppo lineare in tre stadi: da un nome comune (śāṭān come “avversario” in Numeri 22), a un titolo (haśśāṭān come “l’Accusatore” in Giobbe e Zaccaria), fino a un nome proprio (“Satana” in 1 Cronache 21) (pp. 26-27). Stokes contesta questa traiettoria, sostenendo che la sua semplicità ne è anche la principale debolezza (p. 27).
Il fulcro della sua tesi, introdotto qui e sviluppato in seguito, è una ridefinizione semantica del termine ebraico śāṭān. Contrariamente alla traduzione comune di “avversario” o, in contesti giuridici, “accusatore”, Stokes sostiene in modo convincente che il significato primario del termine sia quello di “aggressore” o, più specificamente, “giustiziere” (p. 29). Per dimostrarlo, analizza sistematicamente le occorrenze del termine. Parte dagli esempi umani: in 1 Samuele 29, i capi filistei temono che Davide possa diventare un satana in battaglia, cioè un aggressore che si rivolta contro di loro (p. 32); in 1 Re 11, Dio suscita avversari militari contro Salomone, definiti satana (p. 32); in 2 Samuele 19, Davide rimprovera Abisài, che vuole giustiziare Simei per aver maledetto il re, chiamandolo satana, ovvero qualcuno pronto a eseguire una condanna a morte (p. 33). Anche il verbo affine śṭn, presente in alcuni Salmi, denota un’aggressione fisica e letale, non una semplice accusa verbale (p. 34).
Armato di questa nuova comprensione, Stokes rilegge i testi chiave che menzionano un satana sovrumano. Il più antico è Numeri 22, dove l’angelo di YHWH si pone sulla strada di Balaam «come suo satana» (p. 35). L’angelo brandisce una spada e dichiara esplicitamente che è venuto per ucciderlo (Nm 22,32-33). Qui, satana è un ruolo temporaneo, una funzione di giustiziere divino, assunta dall’angelo stesso (p. 36).
Il passo successivo è Zaccaria 3. La visione tradizionale vede haśśāṭān come “l’Accusatore” che incrimina il sommo sacerdote Giosuè. Stokes ribalta questa lettura: la scena non è un processo. Giosuè, con le sue “vesti sporche”, è colpevole (‘āwōn) e meritevole di morte, in linea con le prescrizioni sacerdotali (p. 41; cfr. Es 28,43). Il Satana non è lì per accusarlo, ma per “satanizzarlo”, cioè per giustiziarlo. È l’angelo di YHWH che, con un rimprovero divino, ferma l’esecuzione e purifica Giosuè (p. 42). In Zaccaria, Stokes rileva uno sviluppo fondamentale: a differenza di Numeri, l’angelo di YHWH e il Satana sono due figure distinte e persino in conflitto. Il Satana è ormai un funzionario specifico della corte celeste, “il Giustiziere”, un ruolo che viene separato da quello dell’angelo-messaggero di Dio. Questa distinzione, secondo Stokes, serve a enfatizzare la trascendenza di Dio, allontanando la Divinità dall’atto diretto e pernicioso dell’esecuzione (p. 44).
Infine, Stokes affronta il dibattuto passo di 1 Cronache 21, dove un satana incita Davide a compiere il censimento. L’autore smonta l’idea che qui compaia per la prima volta il nome proprio “Satana”. Il termine è ancora un nome comune, “un satana”, un aggressore celeste (p. 44). La vera chiave interpretativa, secondo Stokes, è il profondo legame intertestuale tra questo racconto e la storia di Balaam in Numeri 22. L’autore di Cronache, che aveva accesso a una versione più lunga del racconto del censimento (testimoniata dal rotolo 4QSamª), nota le numerose somiglianze tra le due storie: l’ira di Dio, la presenza di un angelo con la spada sguainata, la confessione del peccato e il paradosso di una punizione per un’azione istigata da Dio stesso (pp. 49-51). Leggendo il censimento alla luce di Balaam, il Cronista sostituisce YHWH con “un satana” come istigatore, identificando questo satana con l’«angelo sterminatore» che compare più avanti nel capitolo (p. 55). Anche in questo caso, la motivazione non è una teodicea complessa, ma la tendenza postesilica a usare intermediari angelici per descrivere l’azione di un Dio sempre più trascendente (p. 56).
Il capitolo si chiude riaffermando che la tradizione del Satana nasce dal concetto di un giustiziere divino e che la sua evoluzione non è stata lineare, ma ha visto coesistere nozioni diverse e complesse di questi aggressori celesti (pp. 56-57).
Capitolo 2: Il Satana e l’innocente Giobbe
Se il primo capitolo ha definito le origini del Satana come giustiziere dei colpevoli, il secondo analizza il testo che, secondo Stokes, rappresenta il punto di svolta più radicale e l’apice di questa tradizione nelle Scritture ebraiche: il libro di Giobbe. Stokes avverte subito il lettore di non considerare Giobbe il punto di partenza per comprendere la figura, bensì la sua manifestazione più evoluta e teologicamente sofisticata (p. 30).
Un aspetto fondamentale dell’analisi di Stokes è la sua posizione sulla composizione del libro. Egli sposa e argomenta in dettaglio la tesi, un tempo popolare ma oggi meno considerata, secondo cui le scene della corte celeste che introducono il Satana (Gb 1,6-12 e 2,1-6, insieme alla descrizione della sua malattia fisica in 2,7-8) sono un’aggiunta redazionale successiva a una cornice narrativa preesistente (pp. 61-63). L’autore elenca meticolosamente le prove a sostegno di questa ipotesi: la coerenza di un racconto originario senza il Satana, in cui Giobbe perde solo i suoi beni e i figli; l’assenza, nell’epilogo, di qualsiasi menzione della guarigione fisica di Giobbe, che pure dovrebbe essere la sua prova più grande (p. 68); la perfetta continuità narrativa e grammaticale che si ottiene rimuovendo le scene sataniche (es. i pronomi in 1,13 si riferiscono a Giobbe in 1,5, non al Satana in 1,12) (p. 69); e, soprattutto, il completo silenzio sul Satana nei lunghi dialoghi poetici, che costituiscono il cuore del libro (p. 71).
Accettata questa premessa, l’analisi si concentra sul ritratto del Satana così come emerge dal materiale redazionale. Anche qui, la concezione di base rimane quella del giustiziere/aggressore: il Satana percorre la terra per sorvegliare l’umanità (come gli “occhi di YHWH” in altri testi) e, presumibilmente, per punire i malvagi (p. 74). Quando Dio gli dà il permesso di agire, egli colpisce fisicamente Giobbe, in linea con il suo ruolo (p. 74).
La vera, sconvolgente innovazione del redattore di Giobbe è che, per la prima volta in assoluto, questo aggressore divino attacca una persona innocente (p. 76). È questo il contributo rivoluzionario del libro alla tradizione satanica. Dio stesso lo conferma quando dice al Satana: «Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione» (Gb 2,3) (p. 76). Il Satana non è più solo il castigatore degli empi, ma diventa l’istigatore della sofferenza immeritata dei giusti.
Da dove ha tratto il redattore questa idea audace? Stokes propone un’affascinante inversione della cronologia tradizionale. Invece di pensare che l’autore di 1 Cronache 21 dipenda da Giobbe, egli suggerisce il contrario: il redattore di Giobbe ha probabilmente attinto da 1 Cronache 21,1 (p. 77). Nel testo delle Cronache, un satana “incita” (wayyāset) Davide. L’ambiguità di quel passo, in cui non si menziona esplicitamente l’ira divina preesistente come in 2 Samuele, avrebbe potuto permettere al redattore di Giobbe di concepire un Satana che istiga la Divinità contro un individuo senza una causa pregressa, estendendo il concetto da una nazione (Israele) a un singolo giusto (Giobbe) (p. 77).
Stokes conclude il capitolo evidenziando i contributi duraturi del libro di Giobbe alla tradizione. Anzitutto, esso solleva Dio da una parte della responsabilità diretta per la sofferenza dell’innocente, deviandola sul Satana (p. 78). In secondo luogo, amplia il campo d’azione del Satana, che ora può scatenare non solo piaghe, ma anche invasori stranieri (i sabei e i caldei), un tema che diventerà centrale nella letteratura successiva (p. 81). Infine, pur non essendo ancora un “accusatore” in senso legale, il Satana di Giobbe getta le basi per questo ruolo futuro: non accusa Giobbe di peccati commessi, ma mette in discussione la sua integrità futura, istigando così una “prova” che assomiglia a un’accusa (p. 81). È nel libro di Giobbe, afferma Stokes, che il nemico dei giusti comincia a prendere forma, trasformando per sempre la traiettoria della tradizione satanica.
Capitolo 3: Demoni, spiriti maligni, angeli caduti e il peccato umano
Dopo aver tracciato l’evoluzione del “satana” fino alla sua forma più complessa in Giobbe, Stokes sposta l’attenzione su altre tre tradizioni di esseri sovrumani presenti nelle Scritture ebraiche, che inizialmente erano distinte ma che confluiranno in maniera decisiva nel pensiero giudaico successivo sul male (p. 83). L’autore premette una nota metodologica fondamentale: bisogna evitare di proiettare retroattivamente la categoria moderna e onnicomprensiva di “demone”, poiché la tassonomia antica era molto più ricca e variegata (pp. 84-85).
Le tre tradizioni analizzate sono:
- Šēdîm (“Demoni”): Nelle Scritture ebraiche, questo termine non indica entità che causano malattie o tormenti, ma si riferisce specificamente a divinità straniere il cui culto è considerato illecito per Israele. I due passi biblici che li menzionano (Dt 32,17 e Sal 106,37) li associano all’idolatria e al sacrificio a dèi “che non sono Dio” (p. 87). Sono, in sostanza, falsi dèi.
- Rûaḥ rā‘â (“Spiriti maligni”): Questi sono spiriti nocivi inviati da Dio per affliggere gli esseri umani. Esempi classici includono lo spirito che tormenta il re Saul dopo che lo spirito di YHWH lo ha abbandonato (1 Sam 16-19) e lo “spirito di menzogna” (
rûaḥ) che, nella visione di Michea, Dio invia per ingannare i profeti di Acab e condurlo alla morte (1 Re 22) (pp. 88, 93). Questi spiriti sono agenti del giudizio divino, strumenti del piano di Dio.
šeqer - Bənê hā’ĕlōhîm (“Figli di Dio”): Questa è una classe di esseri divini che compaiono in vari contesti, come membri della corte celeste (Giobbe 1-2) o come governanti divini delle nazioni (Dt 32,8; Sal 82). L’episodio più enigmatico e influente è quello di Genesi 6,1-4, dove i “figli di Dio” prendono in moglie le “figlie degli uomini”, generando una progenie di “eroi dell’antichità” (p. 99). Il testo biblico è laconico e non condanna esplicitamente questa unione.
Il cuore del capitolo è l’analisi di come il Libro dei Vigilanti (1 Enoc 1–36), un’opera fondamentale del III secolo a.C., prenda queste tre tradizioni distinte e le intrecci in una nuova, potente eziologia del male nel mondo (p. 100). Stokes mostra come questo testo reinterpreti radicalmente Genesi 6,1 “figli di Dio” vengono identificati come una classe di angeli ribelli, i “vigilanti”, guidati da Semeyaza e Azazel (p. 101). La loro unione con le donne umane non è un evento neutro, ma un atto di ribellione che viola l’ordine della creazione (p. 103).
Questa sintesi creativa produce due innovazioni cruciali che plasmeranno tutto il pensiero successivo sul male:
- L’origine degli spiriti maligni: I figli nati da queste unioni proibite sono giganti mostruosi e violenti. Quando vengono distrutti, le loro componenti spirituali, non potendo morire, rimangono sulla terra come “spiriti maligni” disincarnati (1 En 15,8-10) (p. 103). Questa è una svolta epocale: l’origine degli spiriti che affliggono l’umanità non è più direttamente riconducibile a un comando di Dio (come in 1 Samuele), ma alla conseguenza di una ribellione angelica primordiale. Ciò serve a distanziare Dio dalla presenza continua e indiscriminata del male nel mondo (p. 109).
- L’origine del peccato umano promosso da esseri sovrumani: Oltre a generare una progenie distruttiva, i vigilanti rivelano all’umanità una conoscenza proibita: Azazel insegna la metallurgia per creare armi e la cosmetica che porta all’immoralità sessuale (1 En 8,1-2), mentre altri svelano pratiche magiche e divinatorie (p. 102). Ma il passo più significativo, secondo Stokes, si trova in 1 Enoc 19,1. Qui si afferma che gli “spiriti” degli angeli caduti non solo “portano distruzione”, ma “inducono in errore” gli uomini affinché “offrano sacrifici ai demoni come agli dèi” (p. 110). In questo passaggio, le tradizioni si fondono completamente: gli spiriti maligni (la progenie dei vigilanti) diventano istigatori attivi del peccato di idolatria, spingendo gli uomini a venerare i “demoni” (che qui sono identificati con gli stessi angeli caduti e imprigionati) (p. 112). Per la prima volta, una forza sovrumana esterna viene esplicitamente incolpata di indurre l’umanità a peccare.
In conclusione, il capitolo dimostra come il Libro dei Vigilanti abbia creato una sintesi teologica di straordinaria influenza, unificando le tradizioni sparse su demoni, spiriti e figli di Dio in una narrazione coerente che spiegava l’origine persistente della sofferenza e, soprattutto, del peccato nel mondo, ponendo le basi per le complesse demonologie che si svilupperanno in seguito, in particolare nel Libro dei Giubilei e nei testi di Qumran.
Capitoli 4 e 5: Il Principe di Mastema in Giubilei, tra agente divino e nemico del popolo di Dio
I capitoli 4 e 5 sono dedicati all’analisi di un’altra opera fondamentale del giudaismo del Secondo Tempio: il Libro dei Giubilei. Stokes tratta questo testo, una “riscrittura” della Genesi e di parte dell’Esodo risalente al II secolo a.C., come il passo successivo nell’evoluzione della tradizione satanica (p. 119). L’autore sottolinea la complessità compositiva di Giubilei, riconoscendo che, pur avendo un forte messaggio unitario, esso incorpora tradizioni diverse, talvolta in tensione tra loro. Questa complessità, secondo Stokes, è la chiave per comprendere il duplice e sfaccettato ritratto della sua principale figura antagonista: il “Principe di Mastema” (p. 123).
Il nome stesso è significativo. Mastema deriva da una radice ebraica che significa “ostilità” o “inimicizia” (śṭm), spesso un’ostilità divina contro i peccatori (p. 127). Che questo personaggio sia da identificare con il Satana della tradizione precedente è reso esplicito da Giubilei stesso (10,11), oltre che dalle evidenti somiglianze narrative con i racconti di Giobbe e Zaccaria (p. 127). Stokes, tuttavia, dimostra che Giubilei presenta due concezioni apparentemente divergenti di Mastema, che corrispondono ai temi dei capitoli 4 e 5 del suo libro.
Capitolo 4: Il Principe di Mastema e i suoi spiriti ingannatori
In questa prima veste, Mastema agisce come un funzionario divino, un capo degli spiriti maligni il cui operato rientra perfettamente nel piano di Dio per il mondo, specialmente per quanto riguarda l’elezione di Israele (p. 135). Stokes analizza in dettaglio Giubilei 10, il racconto che segue il diluvio. Qui, i figli di Noè si lamentano che i discendenti dei vigilanti, gli spiriti maligni, stanno tormentando e sviando i loro figli. Noè prega Dio di imprigionarli tutti. A questo punto, interviene Mastema, che si rivolge a Dio con una richiesta sorprendente: «Signore creatore, lascia qualcuno di loro innanzi a me, ed essi ascoltino la mia parola e facciano tutto quel che io dirò loro perché – se di loro non mi resta alcuno – io non posso applicare la potenza della mia volontà nei figli dell’uomo» (Giub 10,8) (p. 139). Dio acconsente e permette a Mastema di mantenere il controllo su un decimo degli spiriti per punire la malvagità umana, mentre gli altri nove decimi vengono imprigionati (p. 140). In questo ruolo, Mastema è chiaramente un agente del giudizio divino, un “castigatore” la cui funzione è sanzionata da Dio.
Questa funzione è ulteriormente chiarita in Giubilei 11, dove, nel periodo tra Noè e Abramo, il Principe di Mastema usa i suoi spiriti per diffondere idolatria e violenza tra le nazioni (p. 141). Il suo ruolo è fondamentale nella teologia dell’elezione di Giubilei, come emerge da Giubilei 15,31-32. Questo passo, basandosi su Deuteronomio 32,8-9, afferma che Dio ha deliberatamente posto tutte le nazioni sotto il dominio degli spiriti ingannatori affinché le facessero errare, ma ha riservato Israele per sé, governandolo direttamente senza intermediari malefici (p. 144). Mastema e i suoi spiriti diventano così lo strumento teologico attraverso cui Dio attua la separazione tra il suo popolo eletto e il resto dell’umanità peccatrice. La protezione di Israele da questo inganno spirituale avviene, secondo Giubilei, attraverso la rivelazione della Torah, consegnata a Noè, Abramo e infine a Mosè come un antidoto contro il potere di Mastema (p. 148).
Capitolo 5: Il Principe di Mastema, nemico del popolo di Dio
Se nel capitolo precedente Mastema era un agente del piano divino, qui Stokes analizza un’altra serie di racconti in cui egli agisce come un nemico autonomo e malevolo, che si oppone attivamente al piano di Dio per Israele (p. 150).
Il primo esempio è la storia della carestia in Giubilei 11, dove Mastema invia degli uccelli a divorare i semi per affamare l’umanità, ma viene sconfitto dall’ingegno del giovane Abramo (p. 151). È un primo scontro tra l’antagonista e il patriarca del popolo eletto.
La narrazione più potente è la riscrittura della legatura di Isacco (Aqedah) in Giubilei 17-18. Attingendo esplicitamente al modello di Giobbe, il racconto si apre con la fedeltà di Abramo che viene lodata in cielo. È Mastema che interviene e, come il Satana con Giobbe, sfida Dio a mettere alla prova Abramo, suggerendo il sacrificio del figlio Isacco (p. 153). Stokes evidenzia la natura ingiustificata di questa prova: Giubilei sottolinea che Abramo aveva già dimostrato la sua fedeltà in innumerevoli occasioni (p. 154). L’intento di Mastema è puramente malevolo e mira a distruggere la discendenza promessa. La tensione è palpabile: l’angelo della presenza sta di fronte sia ad Abramo che al Principe di Mastema, richiamando la scena di Zaccaria 3. È l’intervento diretto dell’angelo a salvare Isacco e a umiliare Mastema (pp. 153-154). Qui, Mastema non è un agente di Dio, ma un avversario del suo piano di salvezza che viene sconfitto da un altro agente divino.
Questo ruolo di nemico di Israele e protettore dei suoi avversari si consolida nel racconto dell’esodo in Giubilei 48. È Mastema, non Dio o un angelo, che cerca di uccidere Mosè sulla via per l’Egitto (Es 4,24) per “salvare gli egiziani” (p. 157). È sempre lui che aiuta i maghi egizi a replicare i miracoli di Mosè e che indurisce il cuore del Faraone per spingerlo a inseguire gli Israeliti (p. 158). Dio, in questo racconto, deve attivamente contrastare il suo stesso (ex?) funzionario, legandolo temporaneamente per permettere agli Israeliti di fuggire e sguinzagliandolo poi affinché, nel suo tentativo di nuocere a Israele, finisca involontariamente per compiere il piano di Dio di distruggere l’esercito egiziano nel mare (p. 162).
Stokes conclude questa sezione sottolineando la duplice natura del Satana in Giubilei. Il libro tiene insieme, non senza tensioni, le due tradizioni: quella di un funzionario divino che amministra il castigo e l’inganno sulle nazioni e quella di un nemico malevolo che si oppone attivamente al popolo di Dio. È questa figura complessa e ambigua, conclude Stokes, che la successiva tradizione ebraica e cristiana erediterà, un essere responsabile sia dei peccati del mondo sia delle sofferenze dei giusti (p. 175).
Capitolo 6: Demoni, spiriti maligni, il Satana e la responsabilità umana del peccato
Dopo aver delineato la crescente tendenza, in opere come Giubilei, ad attribuire il peccato a forze sovrumane esterne, nel sesto capitolo Stokes introduce una fondamentale contro-narrativa. L’autore dimostra che non tutti i pensatori ebrei del periodo del Secondo Tempio erano a proprio agio con questa deriva deterministica. Spiegazioni che scaricavano la colpa della malvagità umana su agenti esterni sollevavano infatti spinosi problemi teologici riguardo alla giustizia di Dio e al libero arbitrio umano (p. 176). Se gli uomini peccano perché indotti da spiriti che Dio stesso ha scatenato, come può un Dio giusto ritenerli responsabili e punirli?
Stokes identifica una corrente di pensiero che, in polemica con queste idee, riafferma con forza la responsabilità umana. Il primo e più esplicito esponente di questa visione è Gesù figlio di Sira, autore del Siracide. Componendo la sua opera nel primo quarto del II secolo a.C., Ben Sira ammonisce i suoi discepoli con parole inequivocabili: «Non dire: “A causa del Signore sono venuto meno”, perché egli non fa quello che detesta. Non dire: “Egli mi ha tratto in errore”, perché non ha bisogno di un peccatore» (Sir 15,11-12) (p. 179). Secondo il Siracide, Dio ha creato l’uomo e lo ha «lasciato in balìa della sua propria libera scelta [yēṣer]» (Sir 15,14). È l’uomo, non Dio, a scegliere tra il bene e il male, la vita e la morte (p. 180).
Un’eco ancora più diretta e polemica si trova, secondo Stokes, nell’Epistola di Enoc (1 Enoc 91-108). Sebbene parte della più ampia tradizione enochica, questo testo si distacca nettamente dalla teologia del Libro dei Vigilanti e, soprattutto, da quella di Giubilei. L’affermazione chiave si trova in 1 Enoc 98,4: «Il peccato non fu mandato sulla terra; ma gli uomini l’hanno creato da se stessi, e quelli che lo compiono incorreranno in grande sventura» (p. 188). Stokes evidenzia la precisa scelta lessicale: l’idea che il peccato sia stato “mandato” (Vannawa in ge’ez) sulla terra è un’allusione diretta a Giubilei 11,5, dove il Principe di Mastema “mandava” (Vannawa) i suoi spiriti a diffondere il peccato (p. 193). L’Epistola rigetta questa eziologia. Nella sua visione, gli spiriti maligni e i demoni non sono istigatori attivi del peccato, ma vengono ridotti a meri oggetti passivi di un culto idolatrico, il prodotto della “pazzia del cuore” degli uomini (1 En 99,7-9) (p. 196). Sono gli uomini a ingannare se stessi, non sono gli spiriti a ingannarli. Questa differente teologia, suggerisce Stokes, è legata anche a una diversa concezione dell’elezione: mentre Giubilei traccia una linea netta e predestinata tra Israele e le nazioni, l’Epistola mostra un’apertura universalistica, invitando tutti gli uomini al pentimento, un appello che presuppone la reale possibilità di una scelta (p. 199).
Stokes esplora brevemente anche altri due testi. Un frammento dei Rotoli del Mar Morto, Bareki Naphsi (4Q434), sembra reinterpretare Zaccaria 3 sostituendo “il Satana” con l'”istinto malvagio” (yēṣer) come oggetto del rimprovero divino, internalizzando così la fonte del male (p. 200). Infine, la Lettera di Giacomo nel Nuovo Testamento offre una sintesi matura: da un lato, afferma con forza la responsabilità umana («Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni», Gc 1,14); dall’altro, riconosce l’esistenza del diavolo come tentatore, ma sottolinea che egli può e deve essere resistito («Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà lontano da voi», Gc 4,7) (pp. 201-202). Questo capitolo dimostra brillantemente che il dibattito sull’origine del male era vivo e acceso, con una forte corrente intellettuale che si opponeva alla demonizzazione della causalità e insisteva sulla centralità della scelta e della responsabilità umana.
rā‘
Capitolo 7: Belial, il peccato e il settarismo
Con il settimo capitolo, l’indagine di Stokes si addentra nel cuore della letteratura qumranica, analizzando come le credenze sul Satana si siano ulteriormente evolute e adattate all’interno di un contesto specificamente settario (p. 204). L’autore sottolinea che il corpus dei Rotoli del Mar Morto è variegato e non presenta una dottrina monolitica; tuttavia, emerge una figura satanica predominante, conosciuta principalmente con il nome di “Belial” (p. 205).
Stokes chiarisce che il passaggio terminologico da “Mastema” (ostilità) a “Belial” (bĕliyya‘al, indegnità, malvagità) non è casuale. Questo nome enfatizza in modo ancora più netto l’associazione della figura con la corruzione morale e il peccato, piuttosto che con la semplice aggressione fisica (p. 223).
Il capitolo prende in esame diversi testi. Le Visioni di ‘Amram, un’opera aramaica più antica, funge da anello di congiunzione. In essa, il padre di Mosè ha una visione di due figure angeliche, una di luce e una di tenebre, che si contendono il dominio sull’umanità. La figura oscura è chiamata “Melki-Resha”, ovvero “Re della malvagità” (p. 214). Questo testo, con il suo dualismo e il suo legame con Zaccaria 3, prefigura le teologie più sviluppate che si troveranno negli scritti settari successivi (p. 215).
Il testo centrale di questo capitolo è il Documento di Damasco (CD). Quest’opera, di fondamentale importanza per la setta, adotta e rielabora in modo creativo la teologia di Giubilei per i propri scopi polemici (p. 217). In CD, Belial assume il ruolo che in Giubilei era del Principe di Mastema, ma con una differenza fondamentale: la sua opera di inganno non è più rivolta principalmente alle nazioni pagane, ma è “inviato contro Israele” (CD 4,12-13) (p. 226). Nello specifico, Belial irretisce tutti quegli ebrei che non appartengono alla comunità di Damasco, facendoli cadere nelle sue “tre reti”: la fornicazione (intesa come matrimoni illeciti secondo la halakhah settaria), la ricchezza e la contaminazione del tempio (CD 4,15-18) (p. 227). Belial diventa così la spiegazione teologica della frattura tra la setta e il resto del giudaismo. Gli altri ebrei non sono semplicemente in errore, sono vittime dell’inganno di un agente satanico, una convinzione che serve a rafforzare l’identità e la legittimità del gruppo come l’unico vero “resto” d’Israele (p. 228). Come in Giubilei, Belial comanda degli “spiriti” (CD 12,2) e si oppone all’inviato di Dio, Mosè, aiutando i maghi egizi (CD 5,17-19) (p. 224). La sua sfera d’influenza, però, si è spostata dal mondo esterno al cuore stesso del popolo d’Israele, diventando uno strumento per definire i confini religiosi e sociali della setta.
Capitolo 8: Belial e le forze delle tenebre
L’ottavo capitolo rappresenta l’apice dell’analisi della demonologia qumranica, concentrandosi su due testi che spingono la concezione del Satana verso un dualismo cosmico senza precedenti nella tradizione ebraica: il Trattato dei Due Spiriti e la Regola della Guerra.
Il Trattato dei Due Spiriti, conservato all’interno della Regola della Comunità (1QS 3,13-4,26), offre una spiegazione radicale e onnicomprensiva dell’esistenza del bene e del male. Secondo questo testo, Dio stesso, «dalla sorgente della luce», ha creato lo “spirito della verità” e, «dalla fonte delle tenebre», lo “spirito della menzogna” (1QS 3,18-19) (p. 242). L’umanità è divisa in due campi, governati rispettivamente dal “Principe della luce” e dall'”Angelo delle tenebre” (1QS 3,20-21). Quest’ultimo, che Stokes identifica con Belial, è la figura satanica del trattato (p. 245). La sua origine non è dovuta a una ribellione successiva (come per i vigilanti) ma è parte integrante del piano originario e predestinato di Dio. Questa visione, che presenta forti parallelismi con il dualismo zoroastriano (p. 269), ha una conseguenza teologica sconvolgente: l’Angelo delle tenebre non solo domina sui “figli della menzogna”, ma è anche la causa per cui “deviano tutti i figli della giustizia” (1QS 3,21-22) (p. 247). Il peccato, anche all’interno della comunità degli eletti, è spiegato come l’opera di questa potente forza oscura. Il conflitto è dunque sia cosmico, tra due schiere angeliche, sia psicologico, una lotta che si svolge “nel cuore dell’uomo” (1QS 4,23) (p. 247).
La Regola della Guerra (1QM), d’altro canto, proietta questo conflitto su un piano militare ed escatologico. Descrive la battaglia finale tra i “figli della luce” e i “figli delle tenebre” (p. 256). In questo testo, Belial è inequivocabilmente il comandante supremo delle forze del male, che comprendono le nazioni pagane (i kittim) e gli ebrei apostati, definiti collettivamente il “gruppo di Belial” (1QM 1,5). L’opera sintetizza e amplifica tutte le tradizioni precedenti:
- Belial come nemico di Israele: Guida le nazioni in guerra contro il popolo di Dio, come Mastema in Giubilei 48 (p. 259).
- Belial come capo di spiriti/angeli: Comanda una schiera di “angeli di distruzione” (1QM 13,12) (p. 258).
- Belial in un conflitto angelico: Si scontra direttamente con Michele, il principe angelico di Israele, in un duello che ricorda Daniele 10 e che determinerà le sorti dei rispettivi popoli (1QM 17,5-8) (p. 263).
Ma la Regola della Guerra compie un ultimo, decisivo passo. In diversi passaggi, la battaglia non è più solo tra Michele e Belial, ma è descritta come uno scontro diretto tra “la parte di Dio” e “la parte di Belial” (1QM 1,5). Il testo parla dell'”ira di Dio riversata su Belial” (1QM 4,1-2) e della “grande mano di Dio” che si alzerà contro di lui (1QM 18,1) (p. 264). Pur rimanendo saldamente all’interno di un quadro monoteistico in cui Dio è supremo, la retorica del testo eleva Belial da funzionario o avversario secondario a nemico diretto di Dio (p. 265). In questi testi qumranici, conclude Stokes, il processo di trasformazione è quasi completo: il giustiziere di Dio è diventato il capo delle forze delle tenebre e l’avversario per antonomasia della Divinità stessa.
Capitolo 9: Il Satana nel Nuovo Testamento
Il capitolo finale dell’indagine di Stokes funge da punto di arrivo, dimostrando come le complesse e stratificate tradizioni ebraiche sul Satana confluiscano e vengano ulteriormente sviluppate negli scritti del Nuovo Testamento (p. 273). Gli autori neotestamentari sono gli eredi di questo intero percorso evolutivo e i loro ritratti del Satana riflettono tale ricca e talvolta contraddittoria eredità.
La terminologia stessa è indicativa: le designazioni più comuni, ho (“il Satana”) e
satanasho (“l’Avversario” o “il diavolo”), vengono usate in modo interscambiabile (p. 282). Stokes nota che, sebbene
diabolosho funzioni spesso come il titolo ereditato da Giobbe e Zaccaria, in alcuni casi l’assenza dell’articolo (es. Lc 22,3) suggerisce che il termine si è ormai cristallizzato in un nome proprio, “Satana”, completando la transizione ipotizzata dalla vecchia critica (p. 280).
satanas
L’attività del Satana nel Nuovo Testamento è una sintesi di tutti i ruoli sviluppatisi in precedenza:
- Ingannatore e Tentatore: Questo è ormai il suo ruolo primario, in linea con Giubilei e Qumran. Tenta Gesù nel deserto (Mt 4), porta via la parola seminata nei cuori (Mc 4,15), si maschera da angelo della luce e si serve di falsi apostoli (2 Cor 11), ed è il “padre della menzogna” che sta dietro agli avversari di Gesù e al tradimento di Giuda (Gv 8,44; 13,2) (pp. 285-286).
- Aggressore e Giustiziere: La tradizione più antica, tuttavia, non scompare. Il Satana ha il “potere della morte” (Eb 2,14), causa malattie e infermità (Lc 13,16) e, soprattutto, funge ancora da agente disciplinare di Dio (p. 287). Stokes sottolinea l’importanza di 1 Corinzi 5,5, dove Paolo comanda di “consegnare a Satana” un peccatore “a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato”. Questo, secondo l’autore, non è un atto di scomunica metaforico, ma un ricorso diretto al ruolo del Satana come castigatore fisico, un giustiziere che esegue una punizione correttiva per conto di Dio (pp. 288-289). Anche la “spina nella carne” di Paolo, un “angelo di Satana”, ha una funzione pedagogica voluta da Dio (2 Cor 12,7) (p. 290).
Il Nuovo Testamento, quindi, mantiene la tensione tra il Satana come nemico di Dio e il Satana come suo funzionario (p. 291). Testi come il Vangelo secondo Giovanni e l’Apocalisse lo dipingono come l’avversario cosmico, mentre gli scritti paolini conservano tracce evidenti del suo ruolo di agente punitivo.
Stokes si concentra infine su due sviluppi molto importante attestati nel Nuovo Testamento. Il primo è il ruolo del Satana come “accusatore dei nostri fratelli” (Ap 12,10). Contrariamente all’interpretazione comune, Stokes sostiene che questa non è un’accusa legale per peccati passati. Piuttosto, sulla scia di Giobbe e Giubilei, l’accusa consiste nell’istigare Dio a mettere alla prova la fede dei giusti nel presente, insinuando che essi non resisteranno alla persecuzione. La vittoria dei santi, infatti, consiste nel rimanere fedeli “fino a morire”, smentendo così le accuse del Satana (p. 298).
Il secondo sviluppo è l’identificazione del Satana con “il serpente antico” (Ap 12,9; 20,2). Stokes interpreta questa associazione non come un’esegesi di Genesi 3, ma come l’apice di una lunga tradizione interpretativa che inseriva la figura del Satana in racconti biblici da cui era originariamente assente (p. 303). Gli autori neotestamentari non usano il Satana per spiegare il serpente, ma usano l’immagine potente e primordiale del serpente ingannatore per caratterizzare la natura del Satana, loro avversario contemporaneo (p. 306).
Conclusione
In conclusione, Satana. Come il giustiziere di Dio è diventato il nemico per eccellenza è un’opera di eccezionale lucidità e rigore accademico. Ryan E. Stokes guida il lettore attraverso un percorso affascinante e complesso, svelando come una figura divina secondaria, un “aggressore” o “giustiziere” al servizio di YHWH, si sia gradualmente trasformata attraverso secoli di rielaborazione teologica e letteraria (p. 309).
Il viaggio parte dal giustiziere di Balaam e Giosuè, passa attraverso la svolta radicale del tormentatore di un innocente in Giobbe, si arricchisce delle tradizioni sugli spiriti e i demoni nel Libro dei Vigilanti, e si complica ulteriormente nella duplice veste di agente divino e nemico del popolo di Dio nel Libro dei Giubilei. La tradizione raggiunge il suo culmine dualistico nei testi di Qumran, dove Belial, l’Angelo delle tenebre, emerge come il capo di un regno oscuro e il nemico diretto di Dio. Infine, il Nuovo Testamento raccoglie tutti questi fili, presentando un Satana che è contemporaneamente tentatore, aggressore, accusatore, serpente antico e avversario di Cristo, una figura la cui complessa identità riflette l’intera, tortuosa storia della sua evoluzione.
Il contributo di Stokes è davvero un qualcosa di importante negli studi sul giudaismo del Secondo Tempio. Egli non solo offre una ricostruzione storica meticolosa, ma costringe il lettore a riconsiderare presupposti a lungo dati per scontati. La sua analisi semantica di śāṭān come “aggressore” e la sua lettura della composizione redazionale di Giobbe sono solo due esempi di come un approccio critico rigoroso possa illuminare in modo nuovo testi antichi.
In definitiva, la storia del Satana, come dimostra Stokes, è molto più della biografia di un essere sovrumano. È la storia di come la fede di Israele, e in seguito del cristianesimo, abbia lottato con il problema del male, della giustizia divina e della sofferenza umana. Nel tracciare la metamorfosi del giustiziere di Dio nel nemico per eccellenza, Stokes ha scritto un libro indispensabile non solo per gli specialisti, ma per chiunque desideri comprendere le radici profonde di una delle figure più potenti e persistenti dell’immaginario religioso occidentale (p. 314).
Per chi volesse acquistare il libro: https://amzn.to/4eBMrla