Un’opera-ponte nel panorama degli studi paolini
Nel campo vasto e spesso conteso degli studi paolini, emergono periodicamente opere capaci non solo di presentare tesi innovative, ma anche di sintetizzare decenni di ricerca, rendendoli accessibili a un pubblico più vasto e segnando un punto di non ritorno nel dibattito. Paolo di Tarso, un ebreo del suo tempo, il volume scritto a quattro mani da Gabriele Boccaccini e Giulio Mariotti ed edito dall’editore Carrocci di Roma nel 2025, si colloca a pieno titolo in questa categoria. L’opera si presenta come un contributo fondamentale, un vero e proprio ponte tra le più recenti e rivoluzionarie prospettive accademiche internazionali e il panorama degli studi italiani, spesso più cauto nell’accogliere i mutamenti di paradigma (p. 30). La collaborazione stessa tra Boccaccini, studioso di fama mondiale del giudaismo del Secondo Tempio e fondatore dell’Enoch Seminar, e Mariotti, giovane e brillante ricercatore, simboleggia una continuità e una vitalità intellettuale che attraversa le generazioni, portando a compimento un percorso di ricerca frutto di anni di impegno ed entusiasmo (p. 35).
La tesi centrale del libro è enunciata con una chiarezza disarmante fin dalle prime pagine e ribadita con coerenza lungo tutta l’argomentazione: Paolo di Tarso non fu né l’inventore di un cristianesimo antigiudaico né un apostata dalla fede dei suoi padri (p. 11). Al contrario, egli “è ebreo e lo è per sempre” (p. 129). Il suo pensiero, la sua missione e la sua teologia sono pienamente e unicamente comprensibili solo se ricollocati all’interno del loro contesto originario: la vibrante e plurale galassia dei “giudaismi” del I secolo (pp. 25, 33). Questa affermazione, apparentemente semplice, ha implicazioni dirompenti. Il titolo stesso, Paolo di Tarso, un ebreo del suo tempo, è una dichiarazione programmatica e metodologica. Non si parla di “Paolo e il giudaismo”, una formulazione che presupporrebbe due entità distinte e potenzialmente in opposizione, ma si colloca l’apostolo in modo irriducibile dentro il suo mondo, rendendo tale contesto l’unica chiave ermeneutica valida per decifrarne il messaggio (p. 27).
Per giungere a questa conclusione, Boccaccini e Mariotti dialogano criticamente con duemila anni di storia dell’interpretazione. Il volume si muove con agilità tra la decostruzione delle letture tradizionali – da quella patristica a quella, fondamentale, di Lutero – e il confronto con i più recenti approdi della ricerca accademica. Gli autori accolgono e portano a compimento le intuizioni della “New Perspective on Paul” (rappresentata da studiosi come E.P. Sanders, James Dunn e N.T. Wright), che ha definitivamente smantellato la caricatura del giudaismo del Secondo Tempio come religione del “legalismo” basato sulle opere (pp. 17, 20). Tuttavia, non si fermano qui. Spingono l’analisi oltre, fino ad abbracciare pienamente la cosiddetta “Paul-within-Judaism Perspective” (o “Radical New Perspective”), una corrente di studi che afferma la permanente e integrale ebraicità di Paolo, non solo etnica ma anche religiosa e teologica (pp. 23, 27).
La struttura del libro riflette questo percorso intellettuale in modo magistrale, articolandosi in tre parti distinte e consequenziali. La Parte Prima, “L’invenzione del Paolo antigiudaico”, è un’opera di archeologia ermeneutica che smonta le letture storiche che hanno alienato Paolo dal suo contesto (p. 32). La Parte Seconda, “La riscoperta dell’ebraicità di Paolo”, ricostruisce il mondo intellettuale e teologico dell’apostolo, collocandolo saldamente all’interno del pensiero giudaico apocalittico (p. 33). Infine, la Parte Terza, “Cristo, unica e inclusiva via di salvezza”, presenta la proposta teologica originale e più audace del volume, delineando un modello di salvezza paolino che è radicalmente inclusivo e non sostitutivo (p. 33). In questo modo, il libro non si limita a essere un’altra monografia su una figura storica, ma si propone come una vera e propria “summa” critica, il punto di arrivo di un percorso intellettuale collettivo, iniziato dopo gli sconvolgimenti della Shoah e le rivoluzionarie scoperte di Qumran, che hanno costretto il mondo accademico a ripensare dalle fondamenta la natura del giudaismo antico e, di conseguenza, le origini stesse del cristianesimo (p. 17).
La decostruzione di un’icona. L’invenzione storica del Paolo antigiudaico
La prima sezione del volume di Boccaccini e Mariotti è un’analisi rigorosa e impietosa della Wirkungsgeschichte, la “storia degli effetti” o della ricezione, del pensiero paolino. Gli autori non si limitano a confutare le interpretazioni tradizionali, ma ne tracciano la genealogia, dimostrando come l’immagine di un Paolo “antigiudaico” non emerga direttamente dai suoi scritti, ma sia una costruzione stratificata, il prodotto di necessità teologiche e polemiche di epoche successive. Questo approccio critico rivela che ogni generazione ha letto Paolo attraverso le lenti delle proprie battaglie, proiettando su di lui preoccupazioni che gli erano estranee.
Il percorso di questa “invenzione” inizia nel II secolo con i Padri della Chiesa. Paradossalmente, come argomentato nel primo capitolo, l’immagine di Paolo come “nemico” del giudaismo nasce dalla necessità di difendere l’unità della rivelazione biblica contro l’eresia di Marcione (pp. 50-51). Marcione, postulando una rottura radicale tra il Dio crudele dell’Antico Testamento e il Dio d’amore rivelato da Gesù, aveva fatto di Paolo il suo campione, l’apostolo che aveva compreso la discontinuità tra Legge e Vangelo (p. 51). Per contrastarlo e affermare che il Dio di Gesù era lo stesso Dio di Abramo e Mosè, i Padri della Chiesa (come Ireneo e Tertulliano) dovettero riappropriarsi di Paolo, ma lo fecero accettando la premessa marcionita di una contrapposizione tra la sua teologia e la Legge mosaica (pp. 52-53). In questa lettura, Paolo diventa colui che annuncia il superamento e il compimento della Legge in Cristo. Un dibattito che, nel I secolo, era interno al giudaismo – su come i gentili potessero entrare a far parte del popolo di Dio nell’era messianica – fu così trasformato in una polemica tra due religioni ormai distinte e rivali: il “cristianesimo” e il “giudaismo”. Paolo fu arruolato come il primo e più autorevole testimone di questa separazione (p. 62).
Questo primo slittamento interpretativo fu poi riempito di un nuovo e potente contenuto teologico dalla Riforma protestante. Il secondo capitolo delinea l’ascesa e il successivo declino del “Paolo luterano” (p. 65). Secondo gli autori, Martin Lutero e i riformatori proiettarono anacronisticamente la loro polemica contro la teologia delle “opere” della Chiesa cattolica romana sul giudaismo del I secolo (p. 69). In questa griglia interpretativa, il giudaismo divenne il simbolo di una religione “legalista”, fondata sul merito umano e sulla vana pretesa di guadagnarsi la salvezza attraverso l’osservanza dei precetti (p. 69). Di conseguenza, Paolo fu trasformato nel campione della giustificazione per sola fide, l’eroe teologico che si opponeva frontalmente a questo presunto legalismo ebraico. Per secoli, questa lettura ha dominato l’esegesi protestante e, per reazione, anche quella cattolica, radicando l’idea che il cuore del messaggio paolino fosse una critica radicale al giudaismo in quanto tale. Solo la ricerca accademica del tardo XX secolo, in particolare con l’opera spartiacque di E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism (1977), ha dimostrato in modo conclusivo come questa rappresentazione del giudaismo fosse una caricatura storica, un “fantoccio polemico” che non trovava riscontro nelle fonti giudaiche coeve (pp. 20, 80).
Infine, il terzo capitolo analizza come questa costruzione teologica abbia prodotto le sue conseguenze soteriologiche più nefaste. L’assioma patristico extra ecclesiam nulla salus (“fuori dalla Chiesa non c’è salvezza”), sviluppato in un contesto di consolidamento istituzionale del cristianesimo, fu retroproiettato sul pensiero di Paolo (p. 83). Il suo annuncio della salvezza in Cristo, originariamente un messaggio di inclusione per le “pecore perdute” di Israele e delle nazioni, fu trasformato in una via esclusiva e sostitutiva (p. 99). Se la salvezza è solo nella Chiesa, e la Chiesa ha sostituito Israele nel piano di Dio, allora l’alleanza mosaica perde ogni valore salvifico. Paolo, l’apostolo dei gentili, divenne così, suo malgrado, il fondatore dell’esclusivismo cristiano e il primo teorico della teologia della sostituzione, secondo cui il patto di Dio con il popolo ebraico era stato revocato e trasferito alla “nuova Israele”, la Chiesa (pp. 39, 62). Questa catena ermeneutica – la separazione patristica, il riempimento teologico luterano e la conseguenza soteriologica esclusivista – ha creato quella figura distorta di Paolo che ha dominato per secoli il pensiero occidentale, alimentando un antigiudaismo teologico le cui tragiche conseguenze storiche sono ben note.
La riscoperta dell’ebreo. Paolo nel contesto del giudaismo apocalittico
Dopo aver decostruito l’immagine tradizionale, Boccaccini e Mariotti dedicano la seconda e più ampia parte del volume a una meticolosa ricostruzione storica del vero Paolo, l’ebreo del suo tempo. Questo percorso di riscoperta si fonda su una rilettura radicale di tre pilastri del suo pensiero: l’esperienza di Damasco, la natura del problema teologico che intendeva risolvere e il significato della sua missione ai gentili.
Il punto di partenza è una ridefinizione dell’evento sulla via di Damasco, che la tradizione ha etichettato come la sua “conversione” (p. 105). Gli autori dimostrano in modo convincente come questo termine sia profondamente anacronistico e fuorviante (p. 116). Nel I secolo, il movimento di Gesù non era una “nuova religione” separata dal giudaismo, ma una delle tante correnti messianiche e apocalittiche che animavano il panorama giudaico (pp. 27, 109). Di conseguenza, l’esperienza di Paolo non può essere descritta come un passaggio dal giudaismo al cristianesimo. Fu piuttosto, come Paolo stesso la descrive, una “rivelazione” (apokalypsis) e una “chiamata” (klesis) profetica che riorientò la sua vita e la sua teologia all’interno del giudaismo (p. 123). Paolo, il fariseo zelante, non abbandonò la sua identità ebraica né la sua osservanza della Torah; piuttosto, “convertì” la sua comprensione del giudaismo, passando da una corrente (quella farisaica, che probabilmente attendeva un messia futuro) a un’altra (quella del movimento di Gesù, che credeva che il Messia fosse già venuto e avesse inaugurato i tempi escatologici). Fu un cambiamento radicale, un movimento da una varietà di giudaismo a un’altra, ma in nessun modo un atto di apostasia (pp. 127, 129).
Una volta stabilito che Paolo rimane un pensatore ebreo, la domanda fondamentale diventa: qual è il problema centrale che la sua teologia cerca di risolvere? La risposta tradizionale, incentrata sulla Legge, si rivela inadeguata. Qui Boccaccini e Mariotti introducono quella che è forse la chiave ermeneutica più interessante del loro lavoro: la centralità della tradizione apocalittica enochica (p. 30). Basandosi su decenni di studi specialistici (in gran parte promossi dallo stesso Boccaccini con l’Enoch Seminar), essi sostengono che per comprendere Paolo bisogna guardare a quella “contro-narrazione” sull’origine del male che affonda le sue radici nel libro di 1 Enoc (pp. 139-140). In questa visione, il problema primario dell’umanità non è la trasgressione della Legge mosaica, ma una condizione di schiavitù cosmica. Il male non è solo un atto di disobbedienza umana, ma una potenza superumana, un dominio esercitato da angeli ribelli (come Azazel in 1 Enoc 10,8) che, fin dai tempi primordiali, hanno corrotto la creazione e tengono prigioniera l’intera umanità sotto il potere del peccato e della morte (pp. 140, 151). In questo quadro, gli uomini sono le vittime di una compromissione dell’ordine cosmico (p. 140). La Legge mosaica, che Paolo stesso definisce “santa, giusta e buona” (Romani 7:12), è impotente di fronte a questa situazione, non perché sia difettosa, ma perché non è stata data per combattere una guerra cosmica (p. 162). Essa può indicare il peccato, ma non può liberare dalla sua tirannia. Spostare l’asse del problema da un piano etico-legale a un piano cosmico-apocalittico permette di risolvere l’apparente rifiuto paolino della Torah e di comprendere perché la soluzione debba essere un intervento divino di portata altrettanto cosmica.
Questa nuova comprensione del problema illumina infine la natura della missione paolina ai gentili (p. 178). La sua predicazione non mira ad abolire la Torah per gli ebrei, per i quali essa rimane il segno del patto e la via per la giustizia (p. 190). La sua missione si inserisce piuttosto nelle attese escatologiche giudaiche, secondo cui, alla fine dei tempi, le nazioni pagane avrebbero abbandonato i loro idoli per volgersi all’unico vero Dio, il Dio di Israele (p. 173). La venuta del Messia ha inaugurato questa fase finale della storia. La controversia che infiamma le lettere di Paolo, in particolare Galati e Romani, non riguarda quindi la validità della Torah in sé, ma la questione specifica di quali precetti (in particolare la circoncisione, le leggi alimentari e l’osservanza del sabato) debbano essere imposti ai gentili che ora, per grazia, sono chiamati a far parte del popolo di Dio (p. 196). Paolo non combatte contro il “giudaismo”, ma contro altri missionari ebrei seguaci di Gesù (i cosiddetti “giudaizzanti”) che avevano una diversa visione su come integrare i gentili. La sua non è una battaglia contro la Legge, ma un dibattito intra-giudaico e intra-messianico sulla corretta halakhah (norma di comportamento) per i non-ebrei nell’era messianica (p. 27).
La proposta teologica. Cristo, via di salvezza unica e inclusiva
La terza e ultima parte del volume rappresenta il culmine dell’argomentazione, in cui la decostruzione delle interpretazioni errate e la ricostruzione del contesto storico convergono in una proposta teologica tanto audace quanto coerente. Boccaccini e Mariotti delineano qui una soteriologia (dottrina della salvezza) paolina che non solo risolve le tensioni interne ai testi dell’apostolo, ma offre anche una visione di straordinaria attualità per il dialogo interreligioso.
Il punto di partenza è una cristologia pienamente inserita nel quadro del giudaismo apocalittico. Cristo, per Paolo, è la risposta giudaica al problema giudaico (apocalittico) del dominio cosmico del male (p. 203). La sua morte e risurrezione non sono un quaclosa che abolisca la Torah o annulli il patto con Israele; sono piuttosto l’atto escatologico con cui Dio interviene per spezzare le catene del peccato e della morte, offrendo il perdono e la liberazione che la Legge, da sola, non poteva procurare (p. 222). Gesù è il Messia che esercita sulla terra l’autorità divina di perdonare i peccati, un concetto che, secondo gli autori, trova le sue radici proprio nella tradizione enochica, dove si attendeva una figura messianica che avrebbe purificato la terra dalla corruzione angelica (p. 222). La fede in Cristo, quindi, non è l’adesione a una nuova religione, ma l’accettazione di questo atto di liberazione divina operato per mezzo del Messia di Israele.
Su questa base, Boccaccini e Mariotti edificano il loro modello delle “tre vie di salvezza”, una tesi già precedentemente esposta da Boccaccini in un suo studio (Le tre vie di salvezza di Paolo l’ebreo, Claudiana, 2021) e che qui viene ripresa e ulteriormente elaborata. Secondo questa lettura, Paolo non propone un’unica via esclusiva per tutti, ma un sistema articolato e inclusivo che rispetta le diverse condizioni dell’umanità di fronte a Dio.
- La prima via è quella della Legge mosaica. Per gli ebrei giusti che riescono a osservare la Torah, essa rimane una via valida ed efficace di salvezza. L’alleanza del Sinai non è mai stata revocata (pp. 233, 256).
- La seconda via è quella della legge naturale. Per i gentili giusti, le “nazioni” che non hanno ricevuto la rivelazione del Sinai, la salvezza è accessibile attraverso l’obbedienza alla legge non scritta nel cuore, alla propria coscienza, che permette loro di compiere il bene e di essere graditi a Dio (come Paolo stesso argomenta in Romani 2) (pp. 233, 256).
- La terza via è quella della giustificazione per fede. Questa è la novità radicale del Vangelo paolino, ma la sua funzione è specifica. È la via offerta da Dio, per pura grazia, ai peccatori – sia ebrei che gentili – che sono irrimediabilmente caduti sotto il dominio del male e non riescono a percorrere le prime due vie. Per queste “pecore perdute”, la fede nel sacrificio redentore di Cristo offre il perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio, aprendo loro una porta alla salvezza che altrimenti sarebbe sbarrata (pp. 238, 256).
Il punto fondamentale di questo modello è che la terza via, quella cristologica, è additiva, non sostitutiva (p. 33). La grazia offerta in Cristo non annulla la validità della Torah per gli ebrei o della legge naturale per i gentili, ma si aggiunge ad esse come un dono ulteriore e straordinario della misericordia di Dio. In questo senso, Cristo è l’unica via di salvezza, non perché sia l’unico sentiero percorribile, ma perché la sua opera salvifica è l’evento universale che rende possibile e include l’intero sistema, garantendo la validità anche delle altre due vie. La sua è una via unica e inclusiva, non unica ed esclusiva (p. 252). Di conseguenza, l’affermazione dogmatica tradizionale secondo cui “solo i battezzati si salvano” è, nella prospettiva degli autori, una radicale distorsione del pensiero paolino (p. 12).
Questa visione è ulteriormente raffinata dalla distinzione, fondamentale per Paolo, tra “giustificazione” e “salvezza finale”. La giustificazione per fede è un evento che accade nel presente del credente: è il perdono dei peccati passati, un atto di grazia che lo pone in un giusto rapporto con Dio (p. 238). La salvezza, invece, è l’esito del giudizio finale, un evento futuro che, per Paolo, avverrà per tutti, credenti e non, “secondo le opere” (Romani 2:6) (p. 252). La fede in Cristo non è un’esenzione dal giudizio, ma il perdono che permette al peccatore di rientrare in un percorso di vita nuova, la cui autenticità sarà poi valutata nel giudizio finale. Questo permette a Paolo di predicare un vangelo di grazia incondizionata per i peccatori senza sacrificare la serietà dell’impegno etico.
Valore e collocazione di un’opera fondamentale
In conclusione, Paolo di Tarso, un ebreo del suo tempo è molto più di un’eccellente monografia accademica. È un’opera di sintesi magistrale e di proposta innovativa che segna un punto fermo nel dibattito contemporaneo su Paolo, ricollocandolo in modo definitivo e convincente all’interno del suo irrinunciabile contesto ebraico. Il volume accoglie l’impulso critico della “New Perspective”, ma lo supera, portandolo alle sue conclusioni più logiche e coerenti e allineandosi con le tesi più avanzate della “Paul-within-Judaism Perspective”.
La proposta di una teologia paolina inclusiva, articolata attorno alle “tre vie di salvezza”, si rivela uno strumento ermeneutico di straordinaria potenza, capace di risolvere con eleganza e fondamento storico molte delle apparenti contraddizioni che hanno a lungo tormentato gli interpreti dell’epistolario paolino. La tensione tra Legge e grazia, tra particolarismo e universalismo, tra fede e opere, trova in questo modello una composizione armonica.
Ma il valore del lavoro di Boccaccini e Mariotti non è puramente accademico. Le implicazioni teologiche della loro lettura sono profonde e dirompenti. Smontando alla radice la teologia della sostituzione, essi offrono una solida base paolina per un ripensamento radicale delle relazioni ebraico-cristiane, non più fondate sulla delegittimazione reciproca ma sul riconoscimento di percorsi distinti ma ugualmente validi all’interno dell’unico piano salvifico di Dio. Il libro restituisce ai lettori – ebrei, cristiani e non credenti – un Paolo liberato dalle incrostazioni dogmatiche di secoli di polemiche. Non più l’apostolo dell’intolleranza e dell’esclusivismo, ma un “araldo della misericordia di Dio verso i peccatori” (p. 262), una figura la cui visione di un’inclusività radicale, fondata sull’infinita grazia divina, può parlare con sorprendente forza al nostro tempo plurale e in cerca di dialogo. Si tratta, senza dubbio, di un contributo essenziale e destinato a rimanere un punto di riferimento per chiunque voglia accostarsi al volto autentico e complesso dell’apostolo delle genti.
Per chi volesse acquistare il volume: https://amzn.to/46GR7UJ

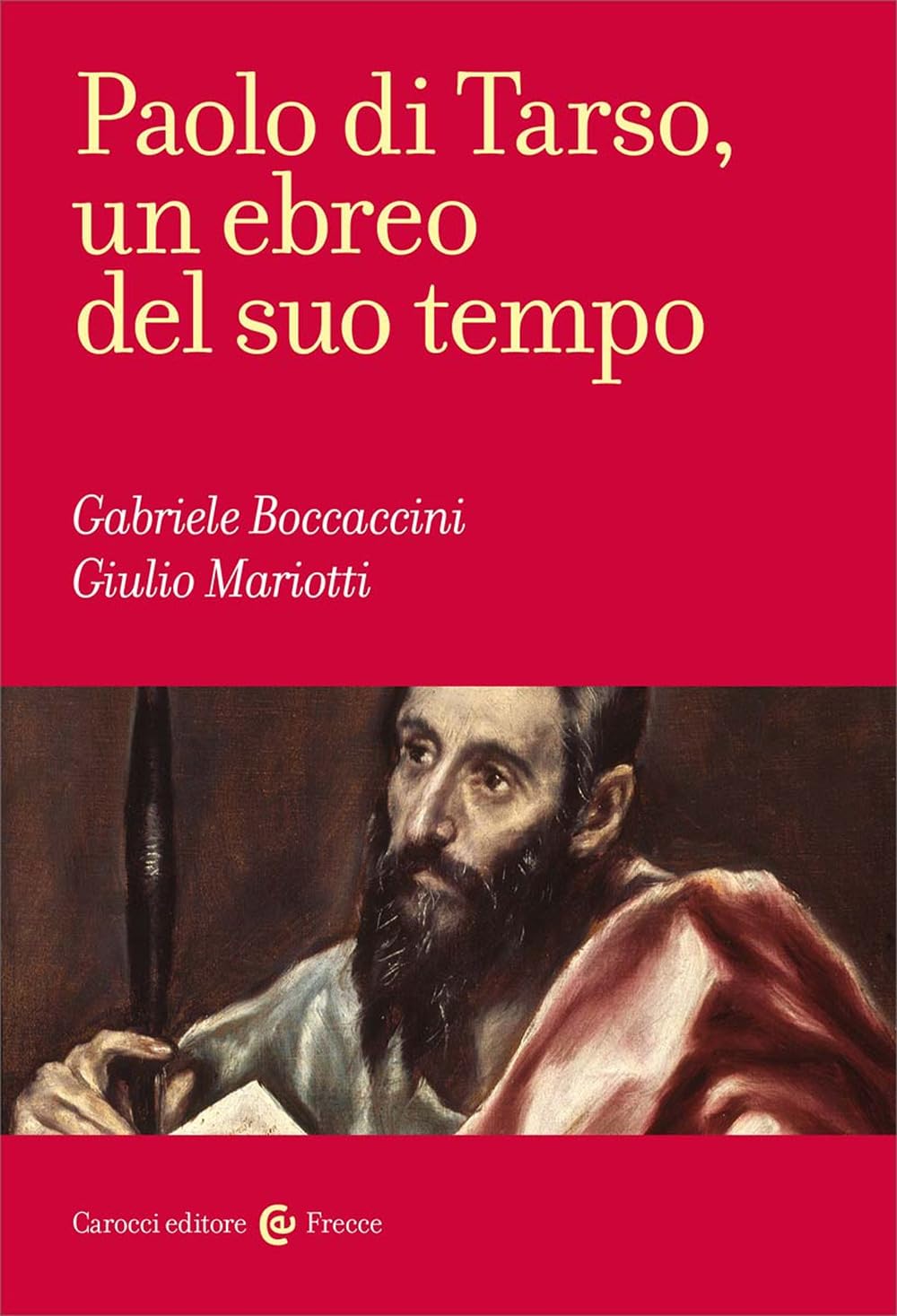
Grazie Adriano per questa dettagliata e utilissima recensione.
Grazie