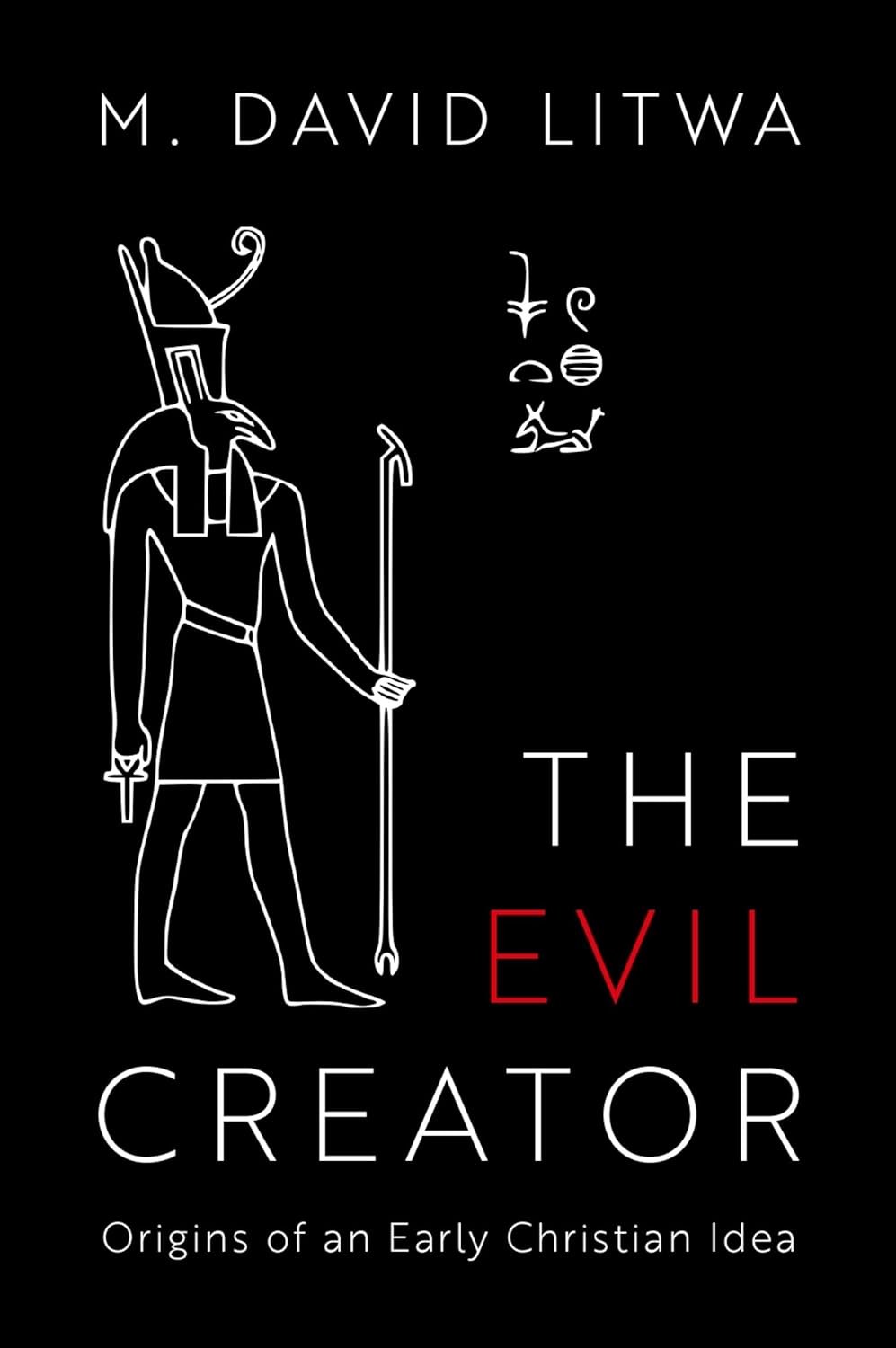La tesi centrale e il metodo della “storia della ricezione”
Nel panorama degli studi sul cristianesimo antico, la questione delle origini del dualismo – la credenza in due principi divini, uno buono e uno malvagio – ha a lungo occupato un posto di rilievo. Con il suo libro The Evil Creator: Origins of an Early Christian Idea (OUP 2021), M. David Litwa interviene in questo dibattito con una tesi tanto chiara quanto provocatoria: la nozione di un demiurgo malvagio, spesso associata ai cosiddetti “gnostici”, non è primariamente un’importazione dalla filosofia platonica, né una reazione sociologica alle crisi politiche del giudaismo del I e II secolo. Al contrario, essa è un prodotto diretto e intenzionale dell’esegesi biblica praticata da specifici gruppi paleocristiani. Litwa respinge le teorie che vedono l’idea del creatore malvagio come una reazione alla distruzione del Tempio o alle guerre giudaiche, così come quelle che la derivano dal dualismo platonico o dall’espulsione dei cristiani dalle sinagoghe. La sua indagine si concentra invece su come “storie e ‘detti difficili’ della scrittura” abbiano generato un “profondo sospetto” sul carattere benevolo del creatore veterotestamentario.
Per condurre questa analisi, Litwa adotta esplicitamente il quadro metodologico della “storia della ricezione” (reception history), che egli definisce come “lo studio dei significati attivati di un testo in un dato contesto storico”. Questo approccio gli consente di analizzare le interpretazioni “eretiche” non come perversioni di un senso “chiaro” e “ortodosso”, ma come letture coerenti e legittime all’interno del loro specifico orizzonte ermeneutico. Sospendendo i giudizi di valore teologici tradizionali, Litwa tratta con serietà accademica la logica interna di questi esegeti radicali, cercando di comprendere come e perché giunsero a conclusioni così scandalose per l’epoca.
Questa scelta metodologica ha implicazioni profonde. Litwa non si limita a presentare una nuova teoria; costruisce un argomento polemico che inverte la freccia causale proposta da decenni di studi. Se studiosi come R. M. Grant e Alan Segal vedevano l’idea del creatore malvagio come una reazione a un mondo percepito come ostile, Litwa ribalta la prospettiva: non è il mondo cattivo a implicare un dio cattivo, ma sono le letture critiche delle Scritture a rivelare un dio cattivo, il che a sua volta spiega la percezione di un mondo alieno e ostile. Il locus della generazione dottrinale si sposta così dall’ambiente esterno al laboratorio interno dell’esegesi cristiana. Di conseguenza, la “gnosi” non appare più come una religione aliena che ha contaminato il cristianesimo, ma come una possibilità radicale nata dall’interno del cristianesimo stesso, attraverso l’atto di leggere e interpretare le sue stesse Scritture.
Le radici pre-cristiane ed egiziane – Il dio-asino e la polemica anti-giudaica
Nella prima parte del suo libro, Litwa esplora una tradizione polemica pre-cristiana che funse da catalizzatore per le successive demonizzazioni cristiane del demiurgo. L’argomento del primo capitolo è che in Egitto esisteva un “meme” culturale consolidato che identificava il dio degli Ebrei, YHWH, con il dio egizio del caos e del male, Seth, a sua volta fuso con il mostruoso Tifone della mitologia greca. Questa identificazione non era casuale, ma si basava su una serie di analogie: entrambi erano percepiti come divinità straniere, legate al deserto e alle tempeste. Un elemento cruciale, secondo Litwa, era l’assonanza tra la resa greca del nome di YHWH, Iaō, e una parola egiziana per “asino”, iō. Poiché Seth-Tifone era spesso raffigurato con tratti animaleschi, e in particolare con quelli di un asino, questa connessione linguistica e funzionale facilitò la nascita di una polemica anti-giudaica che accusava gli Ebrei di adorare segretamente una divinità con la testa d’asino. Questa tradizione è attestata da autori come Mnasea e Apollonio Molon, che riportano la storia della scoperta di una testa d’asino d’oro nel Sancta Sanctorum del tempio di Gerusalemme.
Litwa sostiene che questo modello polemico, già pronto e culturalmente riconoscibile, fu adottato da alcuni gruppi cristiani in Egitto come un’arma per esprimere la loro ostilità verso il dio creatore, che essi identificavano con YHWH. Le prove di questa appropriazione culturale sono rintracciabili in diverse fonti. I “fibioniti”, descritti da Epifanio, credevano che il loro arconte supremo, Sabaoth, avesse la forma di un asino o di un maiale, entrambi animali associati a Seth. Nell’Apocrifo di Giovanni, uno degli arconti inferiori generati dal demiurgo, Eloaios, è descritto con una “faccia d’asino”. Infine, il cosiddetto “diagramma ofita”, descritto da Origene, presenta un demone-governante chiamato Onoel, un nome che Litwa interpreta plausibilmente come “Dio-Asino”.
Sebbene l’analisi comparativa di Litwa sia estremamente efficace nel dimostrare la circolazione di questo “meme” del dio-asino, il nesso causale che egli propone merita un’osservazione critica. L’autore suggerisce che la tradizione di Seth-YHWH fornì una “valenza negativa precostituita” che i cristiani poi applicarono al creatore, implicando che il meme abbia causato o almeno informato pesantemente la teologia negativa. Tuttavia, si potrebbe ipotizzare una causalità inversa o simbiotica. È possibile che i gruppi cristiani, già sospettosi nei confronti del creatore per ragioni puramente esegetiche (ad esempio, la sua gelosia in Esodo 20,5 o il suo comportamento nel giardino dell’Eden), abbiano trovato nella cultura egiziana locale un’immagine polemica perfetta per esprimere e visualizzare una teologia negativa già formulata. In questo scenario, il meme del dio-asino non sarebbe la causa della demonizzazione, ma il suo veicolo espressivo. Il metodo comparativo di Litwa identifica una correlazione potente, ma la prova della direzione della freccia causale rimane un punto aperto al dibattito, suggerendo una relazione più complessa tra esegesi interna e appropriazione culturale esterna.
L’esegesi giovannea come fonte generativa – Il ‘padre del diavolo’ in Giovanni 8,44
Se il primo capitolo esplora un’influenza culturale esterna, il secondo sposta l’attenzione al cuore dell’esegesi cristiana, individuando nel Vangelo secondo Giovanni una fonte generativa fondamentale per l’idea del creatore malvagio. L’argomento di Litwa si concentra sull’ambiguità grammaticale di Giovanni 8,44. La frase greca hymeis ek tou patros tou diabolou este può essere interpretata in due modi: una “lettura appositiva”, comune nelle traduzioni moderne (“voi siete dal padre vostro, il diavolo”), o una “lettura relazionale” (“voi siete dal padre del diavolo”). Litwa dimostra, attraverso una serie di testimonianze patristiche, che questa seconda lettura non solo era possibile, ma era attivamente praticata da diversi gruppi cristiani antichi.
Questa esegesi alternativa aveva conseguenze teologiche devastanti. Se il “padre” dei giudei interlocutori di Gesù è il “padre del diavolo”, e dato che i giudei nel vangelo rivendicano Dio (il creatore) come loro padre (Giovanni 8,41), la conclusione logica è che il creatore biblico è il padre del diavolo. Di conseguenza, le caratteristiche attribuite a questa figura in Giovanni 8,44 – essere “omicida fin dal principio” e “menzognero” – vengono direttamente applicate al creatore stesso. Litwa rintraccia questa linea interpretativa in diversi gruppi. I peratai, ad esempio, identificavano esplicitamente il “padre che uccide gli uomini fin dal principio” con “il governante e creatore della materia”. Allo stesso modo, gli “altri” di Ireneo (gli ofiti), gli arcontici e persino i manichei sono presentati come testimoni di questa tradizione esegetica che vedeva una parentela diretta tra il creatore e il diavolo.
L’analisi di Litwa su questo punto è particolarmente acuta, poiché rivela che una delle idee teologiche più radicali e “eretiche” del cristianesimo antico non nasce da fonti esterne o da mitologie importate, ma da una plausibile, sebbene non ortodossa, interpretazione grammaticale e contestuale di un testo che sarebbe poi diventato canonico. La teologia tradizionale ha risolto l’ambiguità di Giovanni 8,44 a favore della lettura appositiva, neutralizzando la sua potenziale carica dualistica. Litwa, tuttavia, dimostra che la lettura relazionale era un’opzione ermeneutica viva e feconda. Questo suggerisce che il confine tra “ortodossia” ed “eresia” nel II secolo non era una linea netta tracciata tra testi accettati e rifiutati, ma spesso una battaglia su come leggere gli stessi testi condivisi. L’eresia, in questo caso, non è un’intrusione esterna, ma una possibilità ermeneutica latente all’interno del corpus scritturale stesso, pronta a essere “attivata” da lettori con presupposti diversi.
L’approccio marcionita – Il creatore di mali e le Antitesi scritturistiche
La seconda parte del libro è dedicata a Marcione di Sinope, forse il più famoso sostenitore di un creatore inferiore e malvagio. Litwa presenta Marcione non come un filosofo gnostico, ma come un esegeta biblico radicale, il cui metodo principale era la contrapposizione (antithesis) tra il carattere del Dio creatore e quello del Dio buono e straniero rivelato da Gesù. È importante notare che, secondo Litwa, Marcione non era un “diteista” nel senso comune del termine; egli distingueva tra il vero Dio, superiore e buono, e un demiurgo inferiore, che egli chiamava “creatore” (cosmocrator) o “dio di questo mondo”, ma a cui di fatto negava la vera divinità. Il suo metodo non consisteva tanto nel separare la Legge dal Vangelo, quanto nell’usare entrambi i corpora per dimostrare l’esistenza di “due figure superumane con due caratteri opposti”.
Per costruire il suo atto d’accusa contro il creatore, Marcione attingeva abbondantemente dalle Scritture ebraiche. Litwa ricostruisce diverse di queste antitesi, mostrando come Marcione usasse i testi del creatore contro di lui. Alcuni esempi sono particolarmente illuminanti:
- La confessione del male: In Isaia 45,7, il creatore stesso dichiara: “Io sono colui che crea i mali (kaka)”, un’ammissione che Marcione prendeva alla lettera come prova della sua natura maligna.
- La gelosia divina: In aperta violazione dei principi filosofici secondo cui un vero dio non può provare passioni negative, il creatore si definisce un “dio geloso” in Esodo 20,5, un tratto che per Marcione era un segno inequivocabile di imperfezione e malvagità.
- L’invidia nell’Eden: Il divieto di mangiare dall’albero della conoscenza in Genesi 2,17 era interpretato come un atto di invidia malevola, con cui il creatore negava all’umanità un bene che egli stesso possedeva.
- Contrasti morali: Marcione contrapponeva sistematicamente le azioni del creatore a quelle di Cristo. Il comando di saccheggiare gli egiziani (Esodo 3,22) era opposto alla povertà volontaria predicata da Gesù. La brutale legge del taglione (“occhio per occhio”) era messa in antitesi con il principio di non-ritorsione. L’episodio terrificante degli orsi di Eliseo, che sbranano quarantadue bambini per una beffa (2 Re 2,23-24), era contrapposto all’amore di Cristo per i fanciulli.
In questa sezione, emerge però una tensione nel metodo di Litwa. Egli sostiene che Marcione era “biblico fino in fondo” e che la filosofia non era la “forza motrice” del suo pensiero. Tuttavia, l’analisi stessa di Litwa rivela che i criteri con cui Marcione giudica e condanna il creatore – l’impassibilità, l’assenza di invidia, la coerenza, la benevolenza universale – sono profondamente radicati nelle norme filosofiche ellenistiche (platoniche e stoiche) su ciò che è “degno di Dio” (theoprepēs). Senza il presupposto che un vero dio non possa essere geloso, arrabbiato o contraddittorio, le antitesi di Marcione perderebbero gran parte della loro forza polemica. Pertanto, è più accurato affermare che il progetto di Marcione non è una scelta tra esegesi o filosofia, ma un’esegesi guidata da e filtrata attraverso presupposti filosofici. Il metodo comparativo di Litwa, pur concentrandosi sui testi, rivela implicitamente una dipendenza dalla filosofia più forte di quanto l’autore stesso non ammetta esplicitamente.
Ancora sull’approccio marcionita – L’esegesi paolina e la demonizzazione del demiurgo
Se le Scritture Ebraiche fornivano a Marcione il materiale per il suo atto d’accusa, furono le epistole di Paolo a fornirgli la chiave di volta per cementare l’identità malvagia del creatore, trasformandolo nell’antagonista attivo della storia della salvezza. Litwa dedica gli ultimi capitoli a mostrare come le letture marcionite di alcuni testi paolini abbiano portato a questa conclusione.
- Il “dio di questo mondo” (2 Corinzi 4,4): Per Marcione, questa figura non era Satana, ma il creatore stesso. Questa identificazione era supportata dal fatto che il creatore, nelle Scritture ebraiche, ha una lunga storia di accecamento e indurimento dei cuori. Inoltre, Litwa mostra come Marcione leggesse questo passo in congiunzione con 1 Corinzi 2,8, in cui i “governanti di questo mondo”, agenti del creatore, crocifiggono il “Signore della gloria” per ignoranza. In questa lettura, il creatore non è solo un dio inferiore e ignorante, ma il mandante della crocifissione di Cristo, l’atto più malvagio concepibile.
- Il “distruttore della Legge” (Efesini 2,15): Questo versetto, che afferma che Cristo ha “distrutto la Legge dei comandamenti”, era per Marcione una prova inconfutabile. Se la Legge, come Paolo stesso suggerisce altrove, è associata alla maledizione, al peccato e alla schiavitù, allora non può essere buona. E se la Legge è cattiva, anche il legislatore, il creatore, deve esserlo. Cristo non viene a compiere la Legge, ma a distruggerla, liberando l’umanità dal suo tirannico autore.
- La “maledizione del creatore” (Galati 3,13): Questo è forse l’apice dell’argomento marcionita. Quando Paolo scrive che Cristo “divenne una maledizione per noi”, Marcione intende questo nel senso più letterale e terribile: Cristo ha subito la maledizione pronunciata specificamente dal creatore nella sua stessa Legge (Deuteronomio 21,23). L’atto di maledire il Figlio del Dio buono è la prova definitiva e inappellabile della natura maligna del creatore.
La sintesi di queste esegesi paoline, come ricostruita da Litwa, rivela una profonda e coerente rilettura della soteriologia cristiana. La morte di Cristo non è più un sacrificio offerto al creatore per placare la sua giusta ira, ma un atto di liberazione dal creatore, che viene smascherato come l’antagonista cosmico. La crocifissione non è un atto di riconciliazione con il dio di questo mondo, ma il culmine della sua ostilità, un atto che Cristo subisce per redimere l’umanità dal suo dominio. La salvezza, quindi, non è il perdono all’interno del mondo del creatore, ma la fuga dal mondo del creatore verso il Dio buono e straniero. Il metodo di Litwa non solo spiega l’origine di un’idea, ma svela una struttura teologica alternativa completa, radicata in una lettura radicale ma coerente delle Scritture.
| Gruppo Cristiano | Testo Scritturale Chiave | Conclusione Teologica sul Creatore (secondo Litwa) |
| Ofiti / Fibioniti | Tradizione polemica di Seth-Yahweh | È un demone zoomorfo, con la forma di un asino, associato al male e al caos. |
| Peratai / Arcontici | Giovanni 8,44 (lettura relazionale) | È il padre del diavolo, e come suo figlio è “omicida fin dal principio” e “menzognero”. |
| Marcione | Isaia 45,7; Genesi 2,17; Esodo 20,5 | È il creatore di mali, un essere geloso, invidioso, violento e contraddittorio. |
| Marcione | 2 Corinzi 4,4; 1 Corinzi 2,8 | È il “dio di questo mondo”, cieco e ignorante, che ha orchestrato la crocifissione di Cristo. |
| Marcione | Efesini 2,15 | È il legislatore di una Legge malvagia, strumento di schiavitù, che Cristo è venuto a distruggere. |
| Marcione | Galati 3,13; Deuteronomio 21,23 | È il legislatore maledicente che ha pronunciato la sua maledizione sul Figlio del Dio buono. |
Valutazione critica e conclusione – Contributi e limiti del metodo comparativo di Litwa
In conclusione, The Evil Creator di M. David Litwa è un’opera provocatoria e di fondamentale importanza, che riesce nel suo intento di riorientare il dibattito sulle origini del dualismo cristiano. Il suo contributo più significativo è quello di spostare con successo il fulcro dell’indagine dalla sociologia e dalla filosofia all’esegesi biblica, dimostrando in modo convincente che l’idea di un creatore malvagio fu il risultato di complesse strategie ermeneutiche. La sua capacità di ricostruire le logiche interne delle letture “eretiche”, trattandole con la serietà accademica che meritano, è encomiabile e offre un modello per futuri studi sulla storia della ricezione. Il libro è un potente promemoria del fatto che il “canone” e la sua interpretazione erano campi di battaglia aperti e contesi nel II secolo.
Tuttavia, il metodo di Litwa presenta alcuni limiti che meritano di essere evidenziati. In primo luogo, la questione della causalità contro la correlazione rimane aperta. Sebbene Litwa dimostri in modo convincente che certi gruppi usavano queste esegesi per sostenere la loro teologia, è meno conclusivo nel provare che queste esegesi fossero la causa originaria dell’idea del creatore malvagio, piuttosto che una sua giustificazione a posteriori. La sua metodologia comparativa identifica parallelismi e influenze, ma la direzione precisa della causalità rimane, in ultima analisi, un’inferenza.
In secondo luogo, il libro spiega brillantemente come l’idea del creatore malvagio sia stata costruita testualmente, ma non chiarisce pienamente perché in primo luogo questi gruppi abbiano sentito il bisogno di intraprendere una lettura così radicalmente negativa. L’origine dell’impulso ermeneutico a leggere la Bibbia “controcorrente” non è forse essa stessa un fenomeno che richiede una spiegazione? Qui, forse, fattori sociologici, esperienziali o filosofici, che Litwa tende a minimizzare, potrebbero essere reintrodotti non come cause dirette della dottrina, ma come condizioni che hanno reso plausibile e desiderabile una tale lettura radicale.
Infine, come per ogni studio su Marcione, la ricostruzione delle sue posizioni si basa su una lettura “allo specchio” di fonti ostili come Tertulliano ed Epifanio. Litwa gestisce questo materiale con grande perizia e cautela, ma la natura intrinsecamente speculativa di questo metodo deve essere riconosciuta.
Nonostante queste osservazioni critiche, The Evil Creator rimane un’opera essenziale. Ridefinisce i termini del dibattito e costringe gli studiosi a prendere molto più sul serio l’ingegnosità biblica e la coerenza teologica dei cosiddetti “eretici”. È una lettura indispensabile per chiunque si occupi di cristianesimo antico, di “gnosi” e della complessa e spesso sorprendente storia della ricezione biblica.