Nel panorama degli studi sulle origini cristiane, pochi libri hanno la capacità di scuotere le fondamenta delle certezze condivise come “Il vangelo ebraico: Le vere origini del cristianesimo” di Daniel Boyarin. In questo saggio denso, erudito e al tempo stesso accessibile, il rinomato studioso del Talmud e della cultura rabbinica si prefigge un obiettivo tanto ambizioso quanto dirompente: decostruire la grande narrazione che per duemila anni ha contrapposto ebraismo e cristianesimo come due universi teologici distinti e inconciliabili. La tesi di Boyarin, sostenuta con una meticolosa analisi dei testi evangelici e della letteratura ebraica coeva, è che questa separazione non fu un evento originario, una “biforcazione delle vie” avvenuta con la predicazione di Gesù, ma il lento e sofferto prodotto di secoli di controversie, polemiche e, in ultima analisi, di una ridefinizione politica delle identità religiose. Il cristianesimo primitivo, lungi dall’essere una religione “nuova” sorta in opposizione a una “vecchia”, era, nella visione di Boyarin, una delle tante, vibranti e legittime espressioni del pluralistico mondo ebraico del Secondo Tempio. L’opera si propone quindi come un audace tentativo di “rimpatrio”: riportare i Vangeli a casa, nel loro contesto ebraico originario, per leggerli non come l’atto di fondazione di un’alterità, ma come un capitolo interno, per quanto radicale e di enorme successo, della storia religiosa di Israele. Continue reading →
Origini cristiane
Inventore del cristianesimo? Un’analisi critica del Paolo di Augias
Un Paolo per il grande pubblico, un problema per la storia
L’opera di Corrado Augias, Paolo: L’uomo che inventò il Cristianesimo (Rai Libri 2023), si inserisce in un filone di alta divulgazione che ha il merito indiscutibile di rendere accessibili al grande pubblico figure e temi di notevole complessità. La prosa è avvincente, la narrazione fluida e la capacità di sintesi dell’autore permette al lettore di seguire le intricate vicende dell’apostolo con un interesse che raramente i saggi accademici riescono a suscitare. Tuttavia, è proprio qui che si annida il problema fondamentale del volume. Questa recensione si propone di dimostrare come il libro, pur essendo una lettura piacevole e stimolante, presenti una ricostruzione storica e teologica di Paolo e del cristianesimo nascente che non è semplicemente datata, ma si pone in radicale e inconciliabile contrasto con i risultati consolidati della ricerca specialistica degli ultimi decenni. Continue reading →
I farisei di Sievers e Levine: una pietra miliare per la decostruzione di uno stereotipo
Un’opera necessaria e un gesto profetico
La pubblicazione del volume I farisei, a cura di Joseph Sievers e Amy-Jill Levine, rappresenta un evento di eccezionale importanza nel panorama degli studi biblici e del dialogo ebraico-cristiano. Frutto di un convegno internazionale tenutosi presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma nel 2019, quest’opera non è una semplice raccolta di saggi accademici, ma un progetto organico e programmatico con una missione chiara: decostruire sistematicamente uno degli stereotipi più antichi, persistenti e dannosi della cultura occidentale. La scelta di aprire il volume con il discorso rivolto da papa Francesco ai partecipanti al convegno è un gesto di grande valore simbolico e teologico. Le parole del pontefice inquadrano l’intera impresa non come un mero esercizio erudito, ma come un imperativo etico e pastorale. Definendo il termine “fariseo” come “uno degli stereotipi più antichi e più dannosi”, Francesco collega direttamente la sua rappresentazione negativa alle radici dell’antisemitismo e invoca la ricerca accademica affinché contribuisca ad “acquisire una visione più veritiera” di questo gruppo. Questo avallo pontificio eleva lo scopo del libro da dibattito specialistico a tappa fondamentale nel dialogo ebraico-cristiano inaugurato dalla dichiarazione conciliare Nostra Aetate. Continue reading →
Il miracolo sotto lo sguardo dello storico: Un’analisi a partire dall’agnosticismo metodologico
Introduzione: Il dilemma dello storico di fronte al miracoloso
Il cuore del cristianesimo è un paradosso per lo storico. Le fonti fondanti di questa religione, i Vangeli, si presentano come biografie di una figura storica, Gesù di Nazaret, eppure le loro narrazioni sono intrise di resoconti di eventi che sfidano le normali categorie della spiegazione storica: guarigioni istantanee, esorcismi, controllo sulle forze della natura e persino la risurrezione dai morti. Questo intreccio inestricabile tra il resoconto storico e l’affermazione miracolosa crea una profonda crisi metodologica. Come può lo storico, il cui mestiere si fonda sull’analisi di cause ed effetti all’interno di un quadro di intelligibilità umana, affrontare testi che postulano costantemente l’irruzione del trascendente? La tentazione è duplice e speculare: da un lato, l’accettazione fideistica che pone le narrazioni al di fuori del vaglio critico; dall’altro, il rigetto aprioristico che le liquida come pure invenzioni, perdendo così l’opportunità di comprendere il fenomeno storico nella sua complessità. Continue reading →
Recensione: “Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence” di Charles A. Gieschen
Pubblicato nel 1998 dalla prestigiosa casa editrice Brill nella collana “Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums und des Urchristentums”, il volume Angelomorphic Christology: Antecedents and Early Evidence di Charles A. Gieschen rappresenta uno studio accademico di rara profondità e portata, che ha rimesso profondamente in discussione le fondamenta di decenni di ricerca sulla cristologia delle origini. Con una meticolosità impressionante, Gieschen ha fidato il consenso accademico che aveva a lungo relegato l’identificazione di Cristo con figure angeliche a un fenomeno tardivo, eretico o, nella migliore delle ipotesi, marginale e rapidamente superato dal cristianesimo “ortodosso”. Nel testo l’autore si oppone direttamente a conclusioni perentorie come quella di James Dunn, citata in apertura, secondo cui “nessun autore del Nuovo Testamento ha pensato a Cristo come a un angelo” (p. 3). Gieschen sostiene che questa visione si basa su due fraintendimenti fondamentali: in primo luogo, un’eccessiva attenzione alla mancanza del titolo esplicito “angelo” applicato a Cristo, ignorando una più vasta gamma di descrizioni funzionali e formali; in secondo luogo, un modello evolutivo della cristologia che presuppone uno sviluppo lineare da concezioni “basse” (Gesù come profeta) a concezioni “alte” (Gesù come Figlio preesistente), un modello che Gieschen, sulla scia di Martin Hengel, considera fallace (p. 5).
La tesi centrale del volume, esposta con chiarezza programmatica, è che “le tradizioni angelomorfiche, specialmente quelle derivanti dalle tradizioni dell’Angelo del Signore, ebbero un impatto significativo sulle prime espressioni della cristologia, al punto che l’evidenza di una Cristologia Angelomorfica è discernibile in diversi documenti datati tra il 50 e il 150” (p. 6). Per dimostrare questa affermazione audace, Gieschen costruisce un’argomentazione sistematica in quattro parti: una solida introduzione metodologica, un’analisi enciclopedica degli antecedenti nel pensiero israelitico e giudaico, un esame dettagliato delle prime testimonianze nella letteratura cristiana e una conclusione che ne delinea le profonde implicazioni. Continue reading →
Storia o polemica? Analisi critica di “Nel nome della croce” di Catherine Nixey
La figlia di Gibbon e il ritorno della polemica illuminista
Poche opere di storia antica hanno recentemente suscitato un dibattito pubblico così acceso come Nel nome della croce di Catherine Nixey (titolo originale: The Darkening Age), pubblicato in Italia dall’editrice Bollati Boringhieri di Torino. Salutato come un fenomeno editoriale internazionale e descritto con ammirazione per la sua prosa avvincente e la sua forza polemica — un recensore lo ha definito una “freccia di balista” — il libro si propone di rovesciare la narrazione tradizionale sulla transizione dalla Tarda Antichità al Medioevo. La tesi centrale di Nixey, esposta con chiarezza fin dalle prime pagine, è che il cosiddetto “trionfo” del cristianesimo non fu una conversione pacifica o un’evoluzione spirituale, ma una deliberata e sistematica distruzione della cultura, dell’arte e della filosofia del mondo classico da parte di un monoteismo intrinsecamente violento e intollerante. L’autrice dichiara esplicitamente di voler raccontare la storia dal punto di vista degli “sconfitti” , dando voce a coloro che furono travolti dall’avanzata della nuova fede. Continue reading →

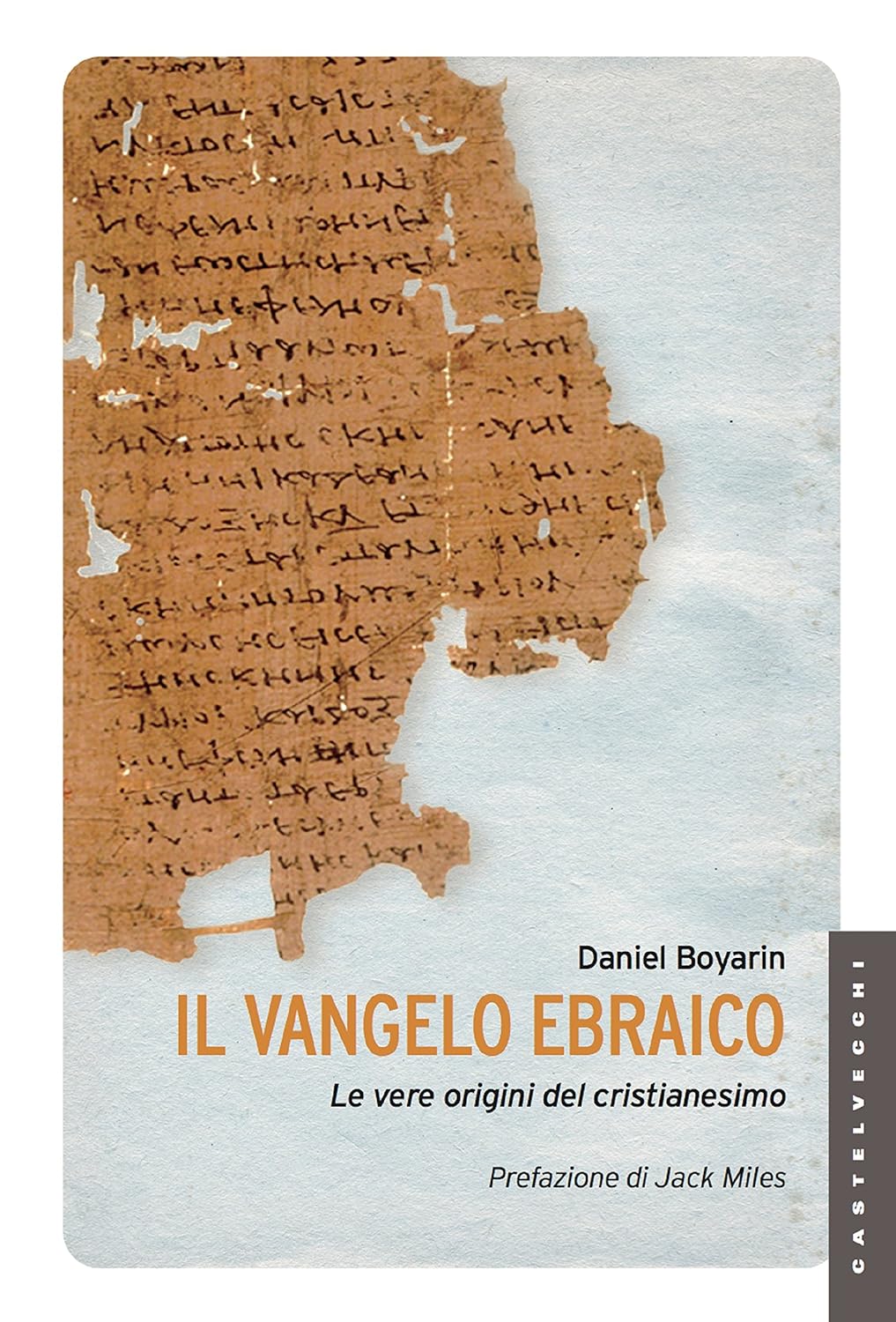
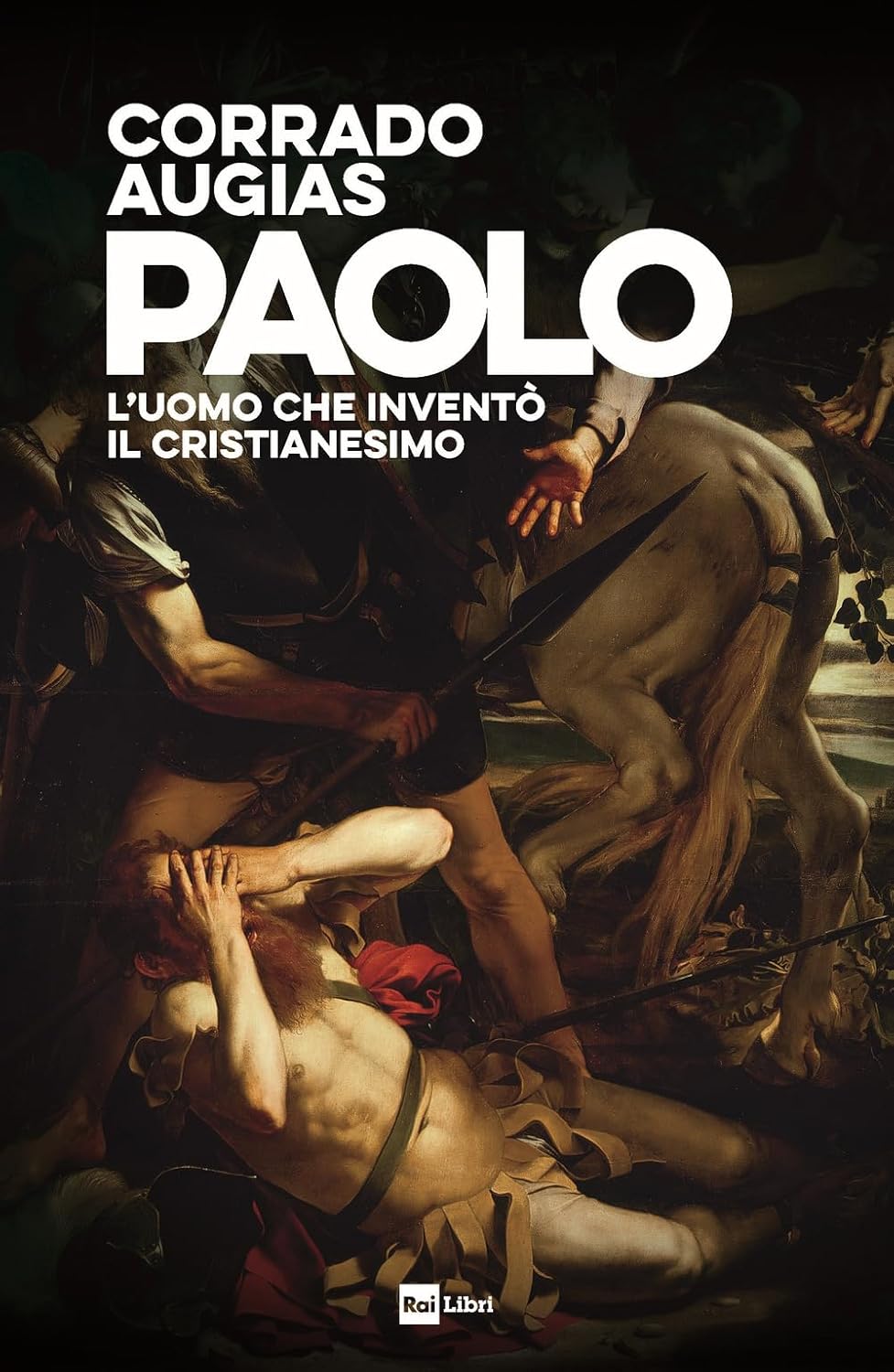
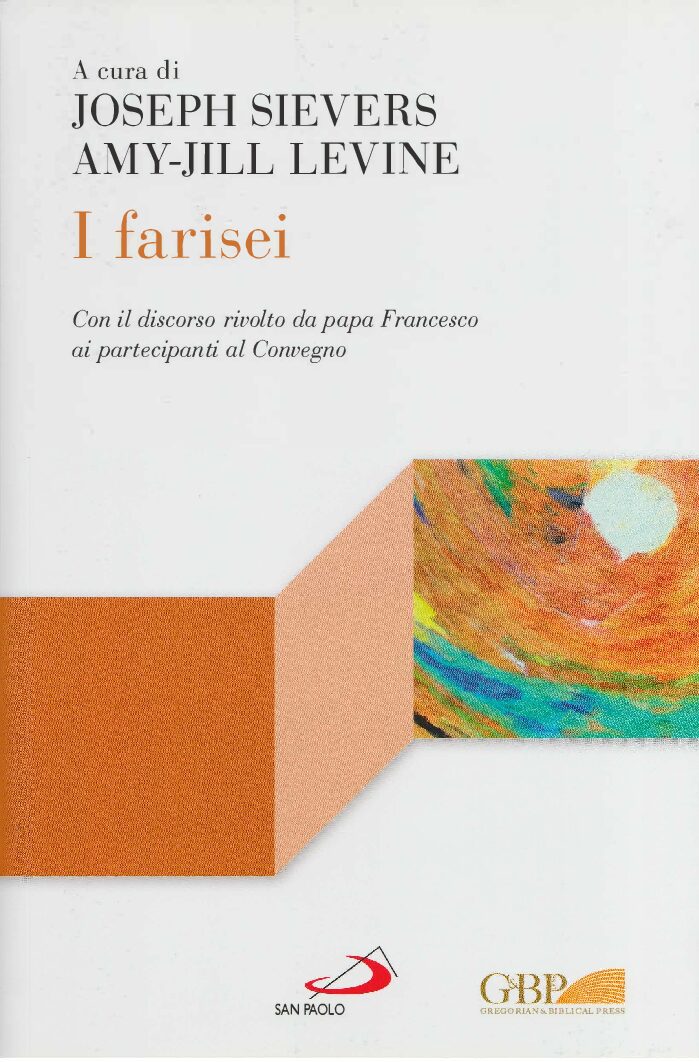

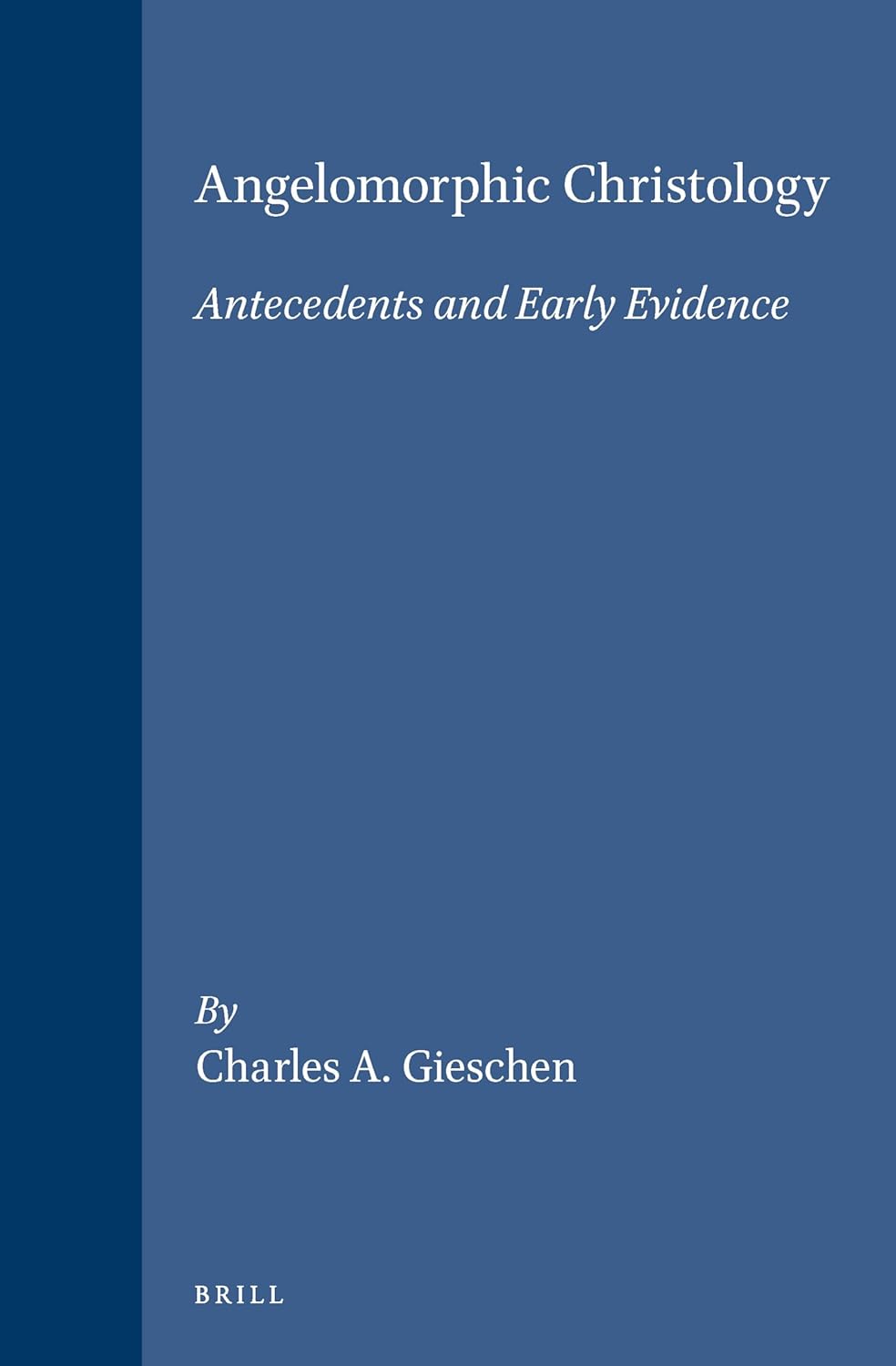
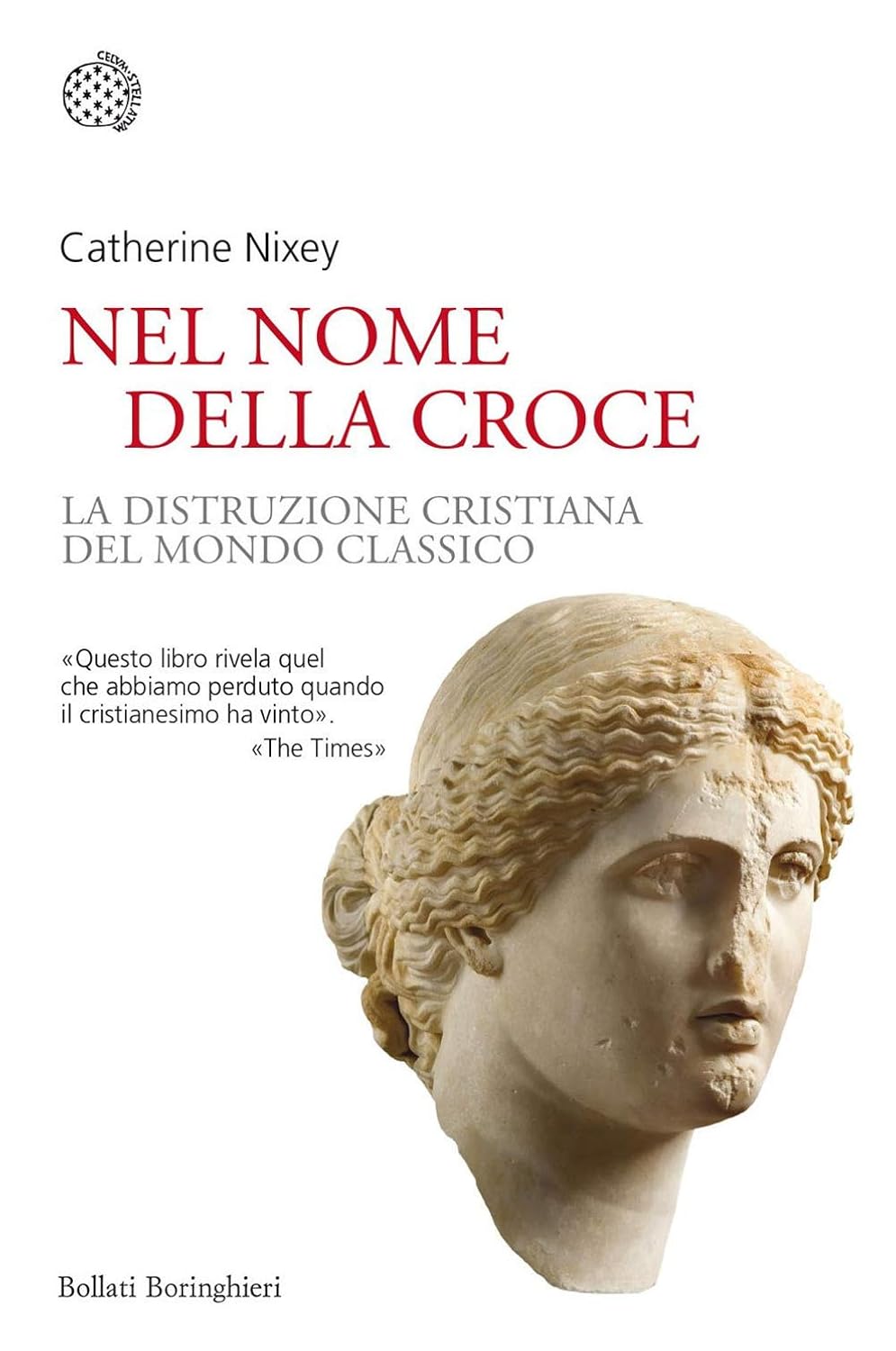
Commenti recenti